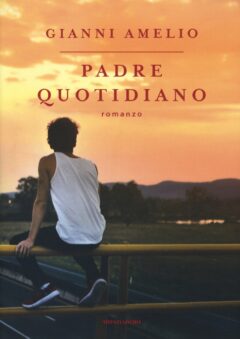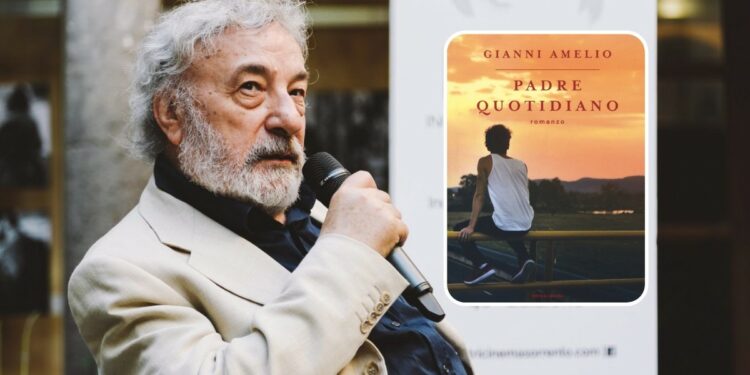«Padre quotidiano» è il romanzo del regista Gianni Amelio che, come già avvenuto per il suo, da molti frainteso, film «Lamerica», è destinato a suscitare un dibattito nel mondo albanese.
Questa volta però non sarà più l’italiano Gianni Amelio ad essere chiamato in causa, ma un Amelio albanese, un uomo che, in quegli anni di miseria e di fame, è entrato dentro il mondo albanese, tanto da sentirsi tale a tutti gli effetti. Era la miseria, «ed è avvicinandosi sempre di più a lei, che – scrive l’autore – senza rendermene conto stavo diventando albanese anche io», e si sa, la povertà rende tutti uguali: questa è stata la soluzione più riuscita anche del socialismo applicato, ovvero rendere uguali tutti al cospetto della povertà. Ma l’autore del romanzo è in qualche misura albanese anche per il fatto che il racconto è filtrato dagli occhi del suo figlio adottivo albanese, anzi, è attraverso quel ragazzo che spesso assume completezza la storia, non quella familiare e personale, ma quella più ampia del paese in cui è ambientata.
«Padre quotidiano» è un titolo che forse è conseguenza di motivi ben diversi, nelle intenzioni dell’autore, dalla assonanza – che io trovo – con «pane quotidiano», ma è attorno al «pane» che ruota la storia del romanzo, e che determina lo stesso valore e ruolo dei «padri». Quel pane che quotidianamente mancava nelle case degli albanesi, soprattutto nelle zone in cui è ambientato. E si racconta appunto di questa povertà, questo pane manchevole nelle sue diverse sfumature, la cui assenza generava opportunismi e meschinità di ogni genere, ma è anche umanità in una accezione nobilitante «di pane sale e cuore candido», tipicamente albanese.
È un romanzo, e non ha la pretesa di esserne altro, ed è per questo che, forse, ciò lo rende portatore di una verità ancora maggiore, di una narrazione più vicina alle verità da cogliere. È la narrazione di un Albania nei momenti più difficili, uno di quei momenti in cui gli albanesi non si potevano fotografare, non perché all’epoca non volessero essere fotografati; al contrario, la Polaroid li impressionava, quel «rivedersi in foto nel giro di pochi secondi li lasciava a bocca aperta e con gli occhi tonti», ma è ora che forse non vorrebbero più vedere quelle fotografie.
È un Albania da dimenticare, da ricreare possibilmente lontana da ogni forma di realismo, con gli abbellimenti posteriori tipici dell’oggi. Perché il romanzo è crudo nel raccontare quell’Albania, e a molti potrebbe non andare a genio il veder declinata attraverso quelle dinamiche la parola «albanese». Ma forse la verità è che si era anche così, c’era anche quell’Albania e quegli albanesi, affamati e scalzi, poveri e cocciuti, pronti a tutto per una questione di «onore», ma anche disposti a prostituirsi da «pederasto» (in tante, e forse troppo ripetute, situazioni sono narrati così), in cambio di un passaggio per oltrepassare il mare.
Per un certo verso, quindi, si tratta di un contributo importante per gli studi albanesi che vogliono analizzare l’immaginario di quegli anni, per gli albanesi interessati a capire la storia e la società post-regime, un periodo all’insegna di una estrema povertà, certamente omologante da una parte, ma anche causa di differenze di classe e di status dall’altra, anche dove regnava la fame e avrebbe dovuto trionfare invece l’uguaglianza. E’ proprio nella metafora della fotografia, quel meravigliarsi da parte degli albanesi del tempo davanti alla Polaroid, che viene colta anche la distanza di quel mondo albanese da un Occidente caratterizzato dal progresso materialista e consumistico.
Tuttavia, esistono diversi mondi albanesi dentro il romanzo: il nord e il sud e la loro distanza (più mitizzata dalle parole degli italiani che veritiera) e soprattutto la distanza verticale fra Tirana e il nord, o meglio, nei confronti della gente del Nord, rappresentata attraverso il confronto morale tra la miseria umana dei burocrati della capitale e la miseria materiale della gente bisognosa del popolo. Nel libro, tra i diversi aspetti mostrati, al di là della dinamica familiare e i sentimenti umani dell’autore e della famiglia Zekaj, quello che colpisce maggiormente è proprio la questione del «disprezzo» nei confronti del mondo «montanaro» da parte della gente di Tirana, una problematica che sembra essere stata artatamente rimossa nell’Albania di oggi ma che invece è ancora più attuale poiché ha assunto nuove modalità molto più raffinate nell’estrinsecarsi.
Un tema importante del romanzo è la somiglianza, a volte nostalgica, dell’Albania, soprattutto quella del Nord, con il paese calabrese d’origine dell’autore, ma con un ritardo temporale da parte della prima rispetto al secondo di almeno trent’ anni.
Sempre somiglianza, ma strana e non più degna di ammirazione, quanto piuttosto di un’ indifferenza sprezzante, è, secondo il regista, anche quella tra Tirana, luogo di burocrati tronfi, costruita nel vuoto, un po’ fascista e un po’ sovietica, e città italiane minori dal passato alquanto modesto quali invenzioni fasciste come Sabaudia. Così, quello che era il tema centrale de «Lamerica», il viaggio a ritroso nel tempo, storico e personale, è qui evidenziato in maniera diretta.
Si sa, «il passato è un paese straniero», ma a volte capita che un paese straniero divenga il proprio passato e ritorni per mettere mano ai propri vuoti e alle proprie mancanze. E così, questo viaggio a ritroso è soprattutto la metafora della ricerca del proprio padre, quello che quotidianamente mancava, ritrovandolo, alla fine, peregrinando per l’Albania di quegli anni (nell’Italia del passato), nel diventare «padre quotidiano» di un figlio a cui si spera di assomigliare.