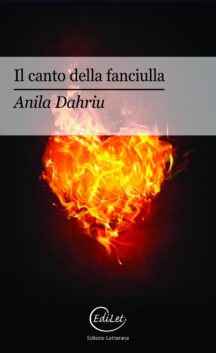Anila Dahriu, classe 1970, nasce a Valona e cresce in Albania. Tre i suoi libri pubblicati in Italia – il cui ultimo «Il canto della fanciulla», uscito a marzo del 2022 ed edito da EdiLet – Edilazio Letteraria – come scrive il saggista e critico letterario Marco Onofrio, nella prefazione, che vi invitiamo a leggere, è “una battaglia di anime alla ricerca dell’amore vero come unico antidoto al male che avvelena il mondo”.
Dalla Prefazione di Marco Onofrio
Anila Dahriu non segue le mode “minimaliste” del mainstream poetico italiano: la scrittura messa in “evento” attraverso questo incalzante poema traguarda il massimalismo referenziale ed espressivo delle grandi imprese letterarie. Una lingua risentita e orgogliosa, frantumata dalle allucinazioni per trafiggere il cuore dell’esistenza oltre le «sofferenze dei secoli» e il «guasto del tempo» in cui gli umani – come «squali feroci» – intessono le loro trame maligne di dominazione.
Le sirene del Mito sono state «fatte a pezzi dalle onde», cioè dalla forza tremenda della Storia. Allora resta solo la possibilità di accedere a uno “stile del ventre” fatto di spasmi, «crampi di dolore» e «urli vulcanici», che informa la poesia come ricettacolo di frammenti dispersi, dimora di tempeste, tambureggiante “machina” infernale.
Il canto della fanciulla è l’innocenza originaria che giura i suoi segreti all’eternità nel momento stesso in cui accetta di impegnarsi nella dura psicomachia dell’esperienza. È una battaglia di anime alla ricerca dell’amore vero come unico antidoto al male che avvelena il mondo. Questo poema, infatti, nasce dall’elaborazione psicologica di una traumatica disillusione: «Pensava che l’amore è più forte della malvagità / Sbagliava… All’orizzonte c’erano le nuvole nere / Impegnate nella loro missione». Il mondo è tristo e reo: non c’è giustizia neppure tra le galassie del cielo stellato. La società è ustionata dai sospetti, dall’odio, dal rancore. Vincono i “furbastri”, i mestatori, i trionfatori dell’inganno. Il «ruscello del male» è l’invidia, la malapianta che annoda ovunque le sue catene di ipocrisia e volgarità: è il «malanno viscido che si perpetua nei secoli». Eppure la voce divina e umana che si agita nelle falde di questo poema crede ancora alla «bontà», alla forza ostinata e disperata della Luce. Dio, che parla nella prima parte, è stanco della Storia e tuttavia esiste, e può forse intervenire – grazie agli uomini e alle donne di buona volontà – per riscrivere il «finale senza soluzioni / Senza futuro». La poesia, di conseguenza, aspira a coincidere con l’opera sciamanica della curandera, proponendosi come canto di guarigione e rigenerazione; accettando dunque di sottoporsi a una prova estrema: o incenerirsi tra le spire degli inferi e tacere per sempre; o risorgere dal proprio dolore per fare nuovo il volto, e anzitutto il cuore, delle cose.
L’operazione innescata fin dalla prima parola del poema è una sorta di esorcismo: Anila Dahriu lancia la sua sfida al mondo come esso (purtroppo) è e si getta a capofitto nell’oscurità, a mo’ di pioniera coraggiosa, per sciogliere i nodi che reggono i sipari dei «teatrini», ingoiando malefici per neutralizzarli e finalmente purificarli dalle sostanze immonde. Lavora dalla parte di Dio per favorire il riscatto di questa umanità ormai in piena decadenza. Non le fanno ribrezzo le parole “agghiaccianti” che occorrono per scoperchiare le botole e smascherare i giochi. Rompe infatti l’omertà delle regole non scritte e scuoia con versi vibranti le superfici graziosamente pitturate nell’ottica della reciproca convenienza. La sua voce, su tali presupposti, aderisce alla chiave tonale del demonico, il titanismo del sacro che presiede sia l’angelico e sia il demoniaco, collaborando “dal basso” a portare la vita avanti nella sua evoluzione. Infatti le parole della Dahriu emergono da magmi così profondi da potersi sviluppare nel doppio registro della “preghiera” e della “bestemmia”, anche in senso ambivalente (cioè di una bestemmia che prega, e viceversa), essendo benedizione e maledizione strettamente legate al suo italiano di origine/substrato albanese.
Si affida per questo viaggio dantesco dagli inferi umani, visti con gli occhi di Dio, al “purgatorio” della redenzione amorosa, trasfigurata nella seconda parte dal canto della fanciulla per te, alla “rerum natura” che, di per sé, renderebbe organiche e buone tutte le cose esistenti, se non ci fosse il male a deviarle dal corso originario, e quindi la «forza eterna» che muove i pianeti e le «costellazioni che regnano nell’universo». Qui il dettato si illimpidisce, dopo le tempeste attraversate, poiché giunge alle sorgenti stesse del Sogno da cui balugina la prospettiva di un “mondo” e di un “modo” diversi, liberi, radicalmente nuovi. E può accadere non prima di avere oltrepassato gli orizzonti chiusi e i «muri alti dei confini» entro cui incista la comune umanità. Lo sguardo cosmico, acquisito lungo il difficile percorso, agevola l’opera d’amore che fa spuntare dall’anima le ali dell’eternità, a vantaggio di «quel volo desiderato, smisurato» grazie al quale sarà possibile abbandonarsi semplicemente al «profumo dell’attimo» per raggiungere la tanto sospirata pienezza dell’essere, in una specie di annuncio del pleroma ultraterreno, a matrice gnostica e cristiana, che vale già come elemento di cura, se non come sintomo di probabile guarigione dal “male di vivere” che ci fa tanto feroci.