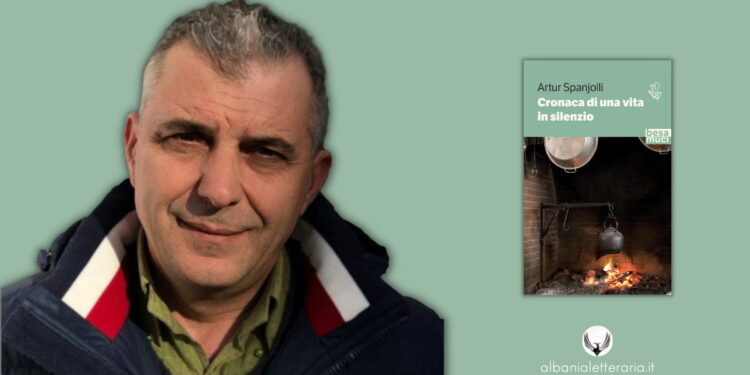Nato a Durazzo nel 1970, Artur Spanjolli, si trasferisce in Italia nel 1992, dove si laurea in lettere e svolge l’attività di scrittore e pittore. Prolifico autore, ha prodotto diversi libri scritti in italiano, di cui sette sono stati pubblicati. Da circa quattro anni scrive nuovamente in albanese.
Intervista ad Artur Spanjolli
Come nasce Cronaca di una vita in silenzio?
L’idea di scrivere il libro è nata nell’autunno del 1993. Ero appena tornato da un lungo soggiorno nel mio Paese e mi ero già iscritto alla facoltà di Lettere e Filosofia a Firenze. In quel periodo, leggevo sia Faulkner che Marquez, mi interessava quella letteratura legata profondamente ai loro Paesi d’origine. Il primo, unito al suo profondo sud del Mississippi e il secondo alla sua terra natale, Aracataca.
Dopo l’esilio, ho sentito una sorta di perdita di identità non indifferente, per questo il mio romanzo doveva essere anche un gesto di conservazione della stessa e non solo. Diversamente dagli altri immigrati impegnati a scrivere le loro storie, io volevo redigere quella della mia famiglia, anche per raccontare a un pubblico diverso chi fossi, da dove venissi e a quale cultura appartenessi. Scrissi il libro in albanese tra ottobre e novembre dello stesso anno, in via Borgo Pinti 13 a Firenze, con una Olivetti a doppio foglio. Posai il dattiloscritto nell’armadio e attesi la fine dei studi. A luglio del 2000, ripresi il materiale e ne trassi un’altra variante, perfezionata in lingua Italiana. Tra il 2000 e il 2002, lo riscrissi passando nuovamente dall’albanese all’italiano e nel 2003 piacque alla casa editrice Besa, che decise di pubblicarlo in un’edizione bilingue.
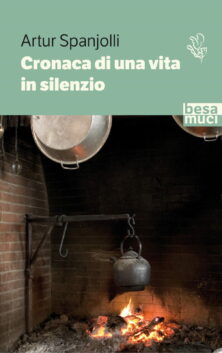
Quale messaggio ha voluto lasciare attraverso questa storia?
Il romanzo parla di una famiglia numerosa tradizionale del mezzogiorno albanese, della sua centralità, dei suoi valori e dei legami patriarcali. Descrive il sistema dei valori tradizionali familiari, che vengono rispettati senza sottomissione. Io parlo di gente piena di umanità, di rispetto e attraverso i monologhi dei personaggi, consegno anche delle riflessioni profonde sulla nostra esistenza sotto il potere del regime. La storia abbraccia quasi ottant’anni di vita albanese, partendo dai tempi del re Zogu fino al 1991, abbracciando i cambiamenti epocali dell’Albania post Hoxha. La trama si snoda intorno alla figura di un giovane defunto; gli altri nove personaggi stanno in silenzio, in commemorazione del morto. Non parlano per quindici minuti, ma ognuno di loro, attraverso i monologhi interiori fa luce sulle vicende familiari. Quindi, il libro racchiude la storia personale, uno spaccato di quella collettiva e del Paese, senza trascurare quella del popolo albanese. Degna di nota, la ricostruzione della straordinaria figura del defunto morto accidentalmente in età relativamente giovane, un personaggio che vuole essere un omaggio alla santità laica dell’essere umano.
Due parole sul contenuto della storia, le influenze letterarie e perché secondo lei bisogna leggere questo romanzo?
Nel romanzo non si trovano grandi storie, oppure scene d’azione o avvenimenti straordinari. Avendo come fonte primaria la vita vissuta e quindi le memorie familiari, ho puntato sulla quotidianità. Se uno scrittore sa manipolare le scene comuni, se sa trarre l’essenziale dalla quotidianità, evidenziando il valore più intrinseco e fondamentale dell’essere umano, cioè la capacità di dare e di ricevere amore, se ha stile e sa narrare bene anche le faccende più comuni, allora il romanzo prende vita, acquista spessore umano e parla di cose che toccano ogni individuo. Il libro parla di emozioni universali e sentimenti e per questa ragione, secondo me, il libro è sempre attuale. Non è solo una buona lettura, ma concede spunti di riflessione sul valore più profondo del bene.
Narra le vicende di una famiglia numerosa di agricoltori trasferitasi in città, di stampo patriarcale. Nonostante questo, i protagonisti si relazionano tra di loro con un calore e un’intensità tale da dare spessore al fuoco sacro del vivere in comunità. Parlare di famiglia ai tempi d’oggi credo che sia più importante che mai, perché è da lì che trarremo l’uomo del futuro. È da lì che partono i semi che porteremo dietro per il resto della nostra vita. Non è un romanzo che racconta di sofferenza, o di strappi generazionali, ma di solidità dei legami famigliari, che è l’elemento portante della storia.
Perché sarebbe bene leggerlo? Credo che chi ama i valori della famiglia, chi crede nei legami forti di sangue, nelle relazioni intense, sincere e continue all’interno del nucleo familiare, possa trarre da questa lettura l’essenza stessa del vivere comune.
Ci racconti la sua storia personale, del suo arrivo in Italia, da dove viene, dove vive.
Sono arrivato nel lontano 1992. Era fine ottobre quando presi l’aereo dall’aeroporto di Rinas con un visto di dieci giorni per ritirare un premio vinto in un concorso organizzato da Rai 3 intitolato: “I giovani incontrano l’Europa”. Dopo aver ritirato il premio ad Abano Terme, decisi di rimanere da clandestino in Italia.
Mi trasferii a Firenze dove non conoscevo quasi nessuno e qui cominciò il mio calvario. L’inverno del 1992-3 fu davvero difficile e molto problematico in tutti i sensi. Ho sofferto di depressione in quel periodo, cosa che poi è passata. I patimenti e le sofferenze sono durati circa un anno, poi, grazie anche a dei fiorentini per bene, sono riuscito a risolvere tutte le questioni burocratiche che mi erano d’intralcio e alla fine mi sono iscritto all’università di Firenze. Il resto è arrivato a poco a poco: la laurea dopo sette anni di sacrifici il lavoro come artista e pittore, come i primi libri pubblicati a partire dal lontano 2004. Dopo è arrivata la famiglia ecc, ecc.
La cosa più importante è avere l’obbiettivo chiaro di cosa si vuole raggiungere nella vita e a quello puntare e lottare per raggiungerlo. La lotta è forse più bella della realizzazione stessa. Ho sempre voluto diventare uno scrittore.
Tutt’ora vivo a Firenze, dove svolgo la doppia attività di scrittore e pittore.
Lei è uno scrittore di madrelingua straniera. Quali sono le problematiche dei passaggi da una lingua all’altra? Qual è la sua lingua principale quando sviluppa una storia?
A me è accaduto qualcosa di singolare, ma credo che questo fenomeno capiti un po’ a tutti gli scrittori d’origine straniera che vogliono scrivere in una lingua di maggior diffusione globale. In Albania, i miei vent’anni mi trovarono con tanta fame di cultura, con un pazzo desiderio di tentare la fortuna all’estero. Perciò, assorbire la cultura italiana, europea e mondiale, tentare di scrivere nella lingua di Dante e Petrarca, è stato per un obbiettivo bramato per molto tempo.
Non è che mi fossi “annoiato” della/ o “disdegnato” la mia lingua materna, ma negli anni Novanta, vedevo l’assorbimento dell’italiano come una missione, come un tentativo di crescita interiore e culturale, ma soprattutto professionale. Mi mancava un percorso internazionale e questo l’ho fatto con la lingua italiana. Una volta compiuto il cerchio, esattamente tre anni fa, ho ripreso a scrivere in albanese.
Come gli elefanti che vogliono tornare all’origine, anche io ho voluto recuperare l’albanese che stavo perdendo. Dopo venticinque anni di letture in italiano, ho scritto gli ultimi romanzi in albanese e credo di continuare per il resto della mia carriera di scrittore. Ho scritto ben venti libri in italiano dei quali sono stati pubblicati sette.
Una delle problematiche è legata alla struttura dell’italiano che è ben diversa da quella albanese. Anche la fraseologia, i modi di dire e la sintassi hanno meccanismi diversi. Nel 2004, quando tradussi un mio romanzo dall’italiano in albanese, il redattore che lo prese in consegna disse testualmente “Questo non è albanese!”. Tutto per colpa dei dodici anni di assidue letture in italiano. Ora, uno dei pochi limiti che ho con l’italiano sono le doppie. Non riesco a sentirle in italiano, perché, come si sa, noi non ne abbiamo nella nostra lingua.
Da quattro anni, dunque, la lingua principale in cui sviluppo le storie è l’albanese.
Tanti scrittori attingono dalla storia di sofferenza che ha avuto il popolo albanese per cinquant’anni sotto la dittatura. Qualcuno ha addirittura creato una carriera raccontando queste storie. Cosa ne pensa a riguardo?
Penso che ci sia bisogno di un distacco. Quelle storie per me non sono interessanti, sono cose che so già e conosco personalmente, ma non le ritengo utili, neanche per il pubblico occidentale che è già sazio di storie dell’Est. Basta! Bisogna rinnovarsi. Scrivere meglio un romanzo storico o scrivere intorno alle problematiche contemporanee.
Abbiamo tanti problemi da raccontare del nostro mondo della nostra epoca, storie fatte di sofferenza, di frustrazioni, di violenza familiare, di mancata emancipazione, di negazione di diritti umani. Forse i particolari della nostra storia serviranno ai nostri nipoti. A loro forse sì, per non dimenticare, ma non solo; prima di tutto per riflettere sugli orrori del passato e per costruire meglio il futuro.