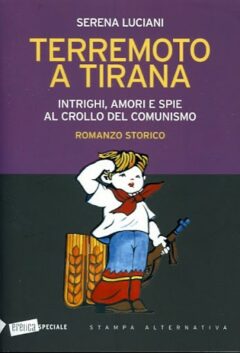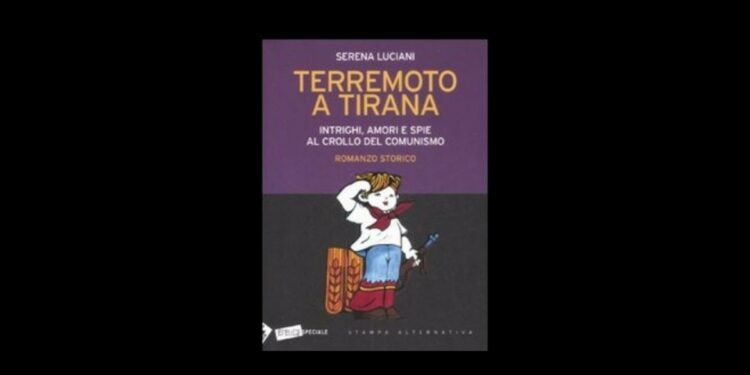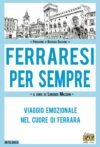Durante una delle tante presentazioni del nuovo libro, Serena Luciani, autrice del libro Terremoto a Tirana ha detto che quando ha applicato per il lavoro sperava la mandassero il più lontano dall’Italia, per trovare una nuova cultura e una nuova mentalità.
E che in un certo senso è rimasta delusa quando l’hanno assegnato a Tirana che era appena fuori dall’Italia per cui, si supponeva, una città europea. Nei fatti poi, però, non era così vicina come appariva geograficamente.
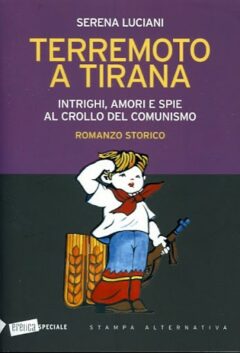
Terremoto a Tirana (Stampa Alternativa, 2008)
Ho visto la vostra presentazione a Ferrara, e una fetta consistente del pubblico era composta da giovani albanesi interessati a sentire parlare della loro storia da una persone terza ed imparziale. Succede così anche in altre presentazioni?
Prima di Ferrara, ci sono state solo due presentazioni a Roma, finora: la prima, alla Casa Internazionale delle Donne, lì c’erano italiani ma anche albanesi dell’Occhio Blu, l’Associazione culturale e di amicizia Italia-Albania di cui sono presidente; una delle socie, albanese di Scutari, ha rivelato cose interessanti che non sapevo su certi venti di apertura che si infilavano nei programmi scolastici all’epoca, come segnale di rinnovamento, ma da fuori noi stranieri eravamo all’oscuro.
C’erano anche giovani sconosciuti, tra i quali uno che mi ha rivelato di essere uno dei primi che nel ’90 entrò nella mia Ambasciata come rifugiato, tutto spaventato. Ci siamo commossi e speriamo di rivederci, mi incuriosisce molto il suo parere sul libro.
Alla tua Ambasciata c’erano anche giovani, l’Ambasciatore Llesh Kola ha detto “Comperate e leggete questo libro sia che siate italiani che albanesi, perché è da questo romanzo di Serena che ho imparato a conoscere il mio paese,” parole più belle non poteva pronunciare, per me.
Tuttavia a queste presentazioni le persone tacciono, timidamente e non fanno quasi mai domande. Sarebbe più interessante organizzare piccoli gruppi informali, nelle scuole, nelle università, nei centri sociali, eccetera. A Ferrara per esempio ritornerò per una bella iniziativa del liceo Ariosto, ( “Galeotto fu il libro”) che invita otto scrittori all’anno, facendo prima leggere a gruppi di ragazzi i libri dell’autore, così quando lui arriva loro sono in grado di domandare, criticare, discutere. Sono invitata anche io, vi farò sapere quando.
I tempi di scrittura di questo libro sono stati di circa 5 anni, che è un periodo relativamente lunga per un romanzo. Come mai?
Cinque anni per un romanzo storico (non un fantasy) non sono poi troppi. Per prima cosa c’è il lavoro di ricerca sui fatti storici internazionali, non solo albanesi, dell’epoca, ricerche che ho svolto sia in Italia che a Tirana. I rivoli di suggestione che sono confluiti nel fiume della narrazione sono tanti e anche quelli più fantastici o lontani hanno richiesto ricerche, letture: così per lo sbarco di Cesare a Dhermì, o per le sirene a doppia coda, dal misterioso significato che viene sciolto alla fine con una “invenzione”. Per tutte queste cose gli americani si servono di assistenti che chiamano “negri” (così come faceva il prolifico Alexandre Dumas) ma per me queste ricerche sono parte del piacere dello scrivere, anche perché a volte si pesca una idea importante dove meno te la aspettavi, sicché anche se tanti fili sembrano ingarbugliare il lavoro, ad un certo punto ciascuno trova il suo posto, o magari qualcuno viene messo da parte per altre opere. Bisogna avere braccia robuste per tenere saldamente in pugno tutta la struttura del romanzo, che, come diceva Virginia Woolf, ha da essere solida come cemento armato, ma il lettore non deve mai avvertirne la fatica o la pesantezza.
Nessuno mi ha rivelato segreti straordinari, fra coloro con cui ho parlato in questi anni, ma un episodio qui, un commento là, una piccola analisi economica, un aneddoto, una vicenda umana drammatica, mi hanno aiutato a comporre un quadro che con la mia sola esperienza dei primi tre anni non sarebbe stato possibile. Secondo Manzoni è impossibile scrivere un romanzo storico, perché o non si rispetta la verità della storia, o si tradiscono le leggi della letteratura romanzesca. E se lo dice lui! Oltre a questa difficoltà c’era il carattere parzialmente autobiografico della narrazione a vincolarmi più del desiderato, ma quando ho cominciato a trattare la protagonista, il mio alter.ego, come un personaggio altro da me ho capito che ero salva. Trovare un compromesso fra l’invenzione romanzesca (un certo numero di intrighi mai esistiti, ma verosimili) e la storia vera non era impossibile: era un sfida, alta, non sapevo se ce l’avrei fatta a condurla in porto in modo soddisfacente, ma sentivo necessario raccontare gli straordinari eventi di cui ero stata testimone. Ho scelto la strada del romanzo corale, con moltissimi personaggi, il che costringe il lettore all’ inizio a fare un po’ di fatica per orientarsi, ma serve a offrirgli l’atmosfera dell’epoca, le idee, le fissazioni, i pregiudizi, senza giudizi manichei.
Naturalmente volevo poi che i personaggi principali avessero uno spessore umano tale da raggiungere nell’arco della narrazione anche un loro crescita e il lettore con loro (e anche l’autore, in parte). Infine, avevo scritto talmente tanto, (800 pagine!) che ho trascorso il quinto anno solo a tagliare, curando il giusto ritmo, molto lento all’inizio per dare la sensazione del mondo chiuso, inamovibile, apparentemente, poi via via sempre più veloce e travolgente fino al finale rossiniano nel quale il talento, il lavoro ben fatto, si oppongono alla forza bruta e la respingono.
Quali furono, se ci furono, le reazione dell’ambasciata italiana al crollo del comunismo, oppure la posizione di Roma? Volevano un Albania libera? Avevano previsto il crollo, come si erano preparati considerato che l’Italia e la Grecia sarebbero stati le destinazioni naturali degli immigrati albanesi?
Le Ambasciate erano tutte per la democrazia e la fine del comunismo, oltre alle occidentali anche quelle di Ungheria e Cecoslovacchia, tuttavia erano impreparate ad accogliere migliaia di rifugiati. Dei cinesi non so: ma cito nel romanzo il fatto che un 8 marzo ci fecero vedere un film-opera metaforicamente critico contro la Rivoluzione Culturale, nessuno dei diplomatici presenti se ne accorse.
In una sua recente apparizione lei ha anche detto ” Molte delle cose le ho capito dopo il crollo del comunismo, quando ho rivisitato Tirana?” A cosa si riferisce?
Anche se mentre lavoravo a Tirana cercavo di superare tutti gli ostacoli che si frapponevano fra me e la comprensione della realtà, più in là di tanto non potevo andare. Dopo la caduta, quando sono ritornata più volte a trovare gli amici o in vacanza, ho imparato molte cose sul carattere albanese,( oltre all’orgoglio e alla fierezza), cioè appunto il senso dell’humour, la robustezza di fronte alle avversità, l’accoglienza. Ma anche la forza dei sentimenti primordiali, sia di amore che di odio, di invidia e di generosità, di rancore e desiderio.
Sentimenti che nella civiltà capitalistica si annacquano. Mi si è rivelata anche la doppiezza cui molti erano stati costretti, fingendo di aderire ad un regime che non condividevano. D’altra parte c’erano e ci sono ancora, se non proprio nostalgici del passato, persone che si sentivano socialmente più protette allora che non ora. Dal ’92 ho anche assistito a un senso di delusione amaro e penoso da parte dei vecchi orgogliosi, inorriditi dai grandi cambiamenti collegati alle nuove attività criminali (droga e prostituzione). ma anche alla formidabile capacità di ripresa dopo la guerra civile del ’97.
Ho finalmente potuto vedere la splendida costa che va da Vlora a Saranda, dove nel romanzo invio la protagonista, ma che in realtà all’epoca era zona militare, off limits. Non c’è per me un privilegio più grande quale quello di farmi una nuotata a ferragosto torno torno il promontorio su cui si erge il castello di Alì Pascià, a Porto Palermo, senza case intorno e al massimo due ombrelloni.
Ho avuto più occasione dopo il mio soggiorno di tre anni, di leggere testi che riguardavano la vostra cultura, per curiosità prima e poi per il romanzo. Ho studiato anche un poco la lingua all’università, nel 2001 e 2002 sicché un poco capisco, ma voi parlate troppo bene l’italiano, come si fa a starvi al passo?
All’Opera c’erano eccellenti cantanti e ballerini (tanto è vero che molti si sono collocati all’estero in m
odo prestigioso, come Inva Mula), ma anche buoni direttori d’orchestra e fra gli strumentisti gli archi e alcune pianiste. Più di tutto mi colpiva il carattere profondamente musicale e poetico, direi epico, del popolo, al sud in particolare, zona che conosco meglio, con la sua polifonia. Temo che questo patrimonio millenario si stia spegnendo e sarebbe una perdita enorme.
Dice che durante la sua permanenza a Tirana era sempre pedinata da almeno due o tre persone del Sigurimi, che non cercavano ne anche di nascondersi. Come lo spiega?
Il sigurimi seguiva di lontano e di nascosto tutti i diplomatici, tallonava invece noi italiani a tre metri, in modo plateale e grottesco, per via dei sei fratelli Popa, rifugiatisi da noi nell’85. Loro dicevano che lo facevano per proteggerci dalla folla inferocita per l’asilo politico offerto ai sei, in realtà era una sorta di umiliazione. A volte la prendevi con spirito, a volte no.
L’Albania poteva apparire, in quei anni, come la tanta proclamata ” paradiso socialista”, oppure era solo utopia e propaganda?
Nessuno di noi pensava che fosse il paradiso socialista. Si capiva che le differenze di classe, rispetto al mondo capitalista, erano molto attenuate, ma le file per il cibo rivelavano l’assenza di benessere. C’erano i 15 giorni di vacanze gratuite, le scuole e gli ospedali gratuiti, ma gli ospedali erano molto carenti, anche se con ottimi diagnostici. Nelle maggior parte delle case mancavano gli elettrodomestici più utili ad alleviare la fatica, per non parlare delle interruzioni di energia elettrica e di fornitura dell’acqua. In compenso, il livello culturale degli studenti era superiore alla media dei loro coetanei italiani e c’erano dappertutto centri culturali.
Poi però c’era il problema della mancanza di libertà e di rispetto dei diritti della persona, della mancanza di partiti, etc.
C’erano i fiumi puliti, i cibi genuini, ma in sostanza l’economia arrancava ed è poi questo, credo, che ha condotto al crollo, più di tutto.
Descrivendo la sua intervista all’ambasciata albanese a Roma lei dice che gli albanesi erano molto informati su quello che succedeva in Italia, e dunque credevano che anche gli europei erano informati di quello che succedeva a Tirana. Ma era veramente così?
In Italia nessuno sapeva niente dell’Albania, neanche della sua arte e letteratura, un po’ per provincialismo, un po’ perché era un paese chiuso, e piccolo, un po’, credo, perché il periodo del colonialismo era stato rimosso dalla coscienza degli “italiani brava gente”.
Ha mai temuto per la sua sicurezza?
Personalmente non ho mai avuto paura, ero sempre seguita, monitorata, si sapeva tutto di me e si poteva vedere che nessuna mia azione era volta altro che a cercare di aprire “finestre”, cioè opportunità di conoscenza con il mondo al di fuori, come il mio ruolo in fondo richiedeva, senza intrighi ma anche senza indecisioni. Semmai soffrivo di solitudine, per i divieti di incontrare gli albanesi e perché nessuno si fidava veramente di nessuno e quindi ognuno rientrava tra i sospetti di essere una spia: ho sempre pensato, forse ottimisticamente, che la mia condotta lineare avrebbe fatto premio su tutto ciò, magari ho avuto fortuna.
Quando c’è stata l’invasione della mia ambasciata, preceduta da colpi d’arma da fuoco proprio sotto la mia casa, essendo claustrofoba ho avuto più che altro paura di restare chiusa per giorni assieme ai rifugiati senza poter tornare a casa. Ma io potevo uscire, in realtà, la preoccupazione principale era per loro, spaventati, disorientati, disorganizzati.
Comunque alla caduta della statua di Hoxha io non ero presente, ero già nella nuova sede di Londra.
“Andare in Albania a fine anni ottanta per me era come tornare ai luoghi della mia infanzia nel 1989.” Eravamo davvero così…ingenui, poco sviluppati e poco europei nel senso capitalistico del termine?
Ingenui rispetto a ciò che li aspettava nel capitalismo sì, sicuramente, lo vedevano come il paese del ben godi dove restavano le vecchie sicurezze del comunismo, casa, ospedale, scuola gratis più le nuove possibilità di arricchimento del capitalismo, molti pensavano che sarebbero stati “risarciti” dai paesi capitalisti per gli anni di sofferenze subite
Perché l’Albania dell’epoca mi rimandava alla mia infanzia? Per esempio per le poche automobili in circolazione, che permettevano ai bambini di giocare in strada, come fu per la mia generazione, le scivolarelle pericolose, le automobiline fatte con i cartoni. E poi le ragazze molto educate e con movenze graziose, come noi un tempo, prima che i jeans ci appiccicassero addosso il passo del bovaro. Ma un po’ tutto era demodé, i vestiti, i cappelli degli uomini, come se il tempo si fosse fermato. Invece, tutto stava per cambiare.
Lei parla, anche nel suo libro tramite i personaggi, dell’amore per l’opera. Dice anche che “L’opera mi ha salvato”, almeno a Tirana. Era davvero di un così alto livello, specialmente per una persona come lei che veniva dall’Italia?
All’Opera c’erano eccellenti cantanti e ballerini (tanto è vero che molti si sono collocati all’estero in modo prestigioso, come Inva Mula), ma anche buoni direttori d’orchestra e fra gli strumentisti gli archi e alcune pianiste. Più di tutto mi colpiva il carattere profondamente musicale e poetico, direi epico, del popolo, al sud in particolare, zona che conosco meglio, con la sua polifonia. Temo che questo patrimonio millenario si stia spegnendo e sarebbe una perdita enorme.
Cosa pensavano gli albanesi dell’Italia? Lo consideravano un nemico, un esempio da seguire, guidati da quello in modo nascosto vedevano in tivù?
Non credo che gli albanesi in Italia ci sentano come nemici, nè ci vedano come modello, si trovano abbastanza bene qui, direi, dopo i primi momenti che sono duri per chiunque emigra dal suo paese, ma parlando così bene la lingua si integrano facilmente, quello che chiedono è rispetto, di se stessi e della propria cultura.
“Certo, ( gli albanesi ) flirtano con l’Unione Sovietica ma sono democristiani?” è la frase detta da un alto rappresentante italiano. Sapevano quello che succedeva a Tirana? Può spiegarci meglio che senso ha una frasi così assurda.
La battuta a Londra del presidente italiano sta a significare “ci capiamo fra noi gente di potere, che si sia di destra o di sinistra, voi che siete all’opposizione non contate niente, neppure per motivi di fratellanza ideologica”. Vezzi degli uomini di potere, farti capire che loro fanno parte di un club esclusivo e tu no. La protagonista se ne infischia, dei club esclusivi e tende ad agire da sola, ma lungo il romanzo impara pian piano l’importanza di costruire alleanze. E cresce.
Com’erano i rapporti con i funzionari albanesi?
Con i funzionari albanesi i rapporti erano formalmente cortesi ma esasperanti, non si veniva mai a capo di nulla. Finché, finalmente….(vedi romanzo)
Lei è ancora in contatto con l’Albania. Ci torna spesso, ci fa le vacanze, e immagino che sia anche un’attenta osservatrice del paese, potendo confrontare l’Albania comunista con quella post-comunista. Le piace quello che vede?
Mi piacciono alcune delle cose che vedo oggi, come un maggior benessere, tanti giornali e televisioni, tanti caffè e ristoranti dove incontrarsi che prima mancavano, la città di Tirana è più colorata, avverto dalle fiere industriali un po’ di ripresa produttiva e per fortuna la costa che amo, quella da Vlora a Saranda, non è stata ancora cementata. Ma: la vita per chi ha stipendio fisso è molto difficile, molti fanno due, tre lavori, i prezzi sono alti, non ci sono abbastanza prodotti agricoli locali, non sono ancora partite industrie di trasformazione (dei capperi, per esempio, che avete spontanei in abbondanza, voi non li usa
te, ma da noi si vendono bene, benissimo, che aspettate?) non è adeguatamente migliorata nella qualità, come potrebbe, la produzione di formaggio (differenziando maggiormente le tipologie), di olio e di vino su standard europei.
Della corruzione e del problema della spazzatura, una vera piaga, che dire? Dobbiamo proprio somigliarci nei peggiori difetti?
Spero che salviate la costa, l’ultima incontaminata nel Mediterraneo. Sareste davvero molto, molto originali e davvero avreste motivo di essere orgogliosi, giacché nessuno ci è riuscito, né italiani, né francesi, né spagnoli.
Come immagina il futuro del paese?
Per il futuro, auguro che entriate presto a far parte della comunità europea.