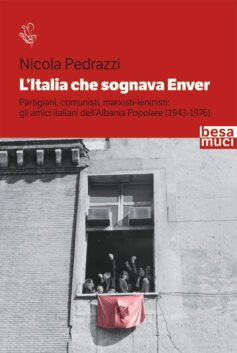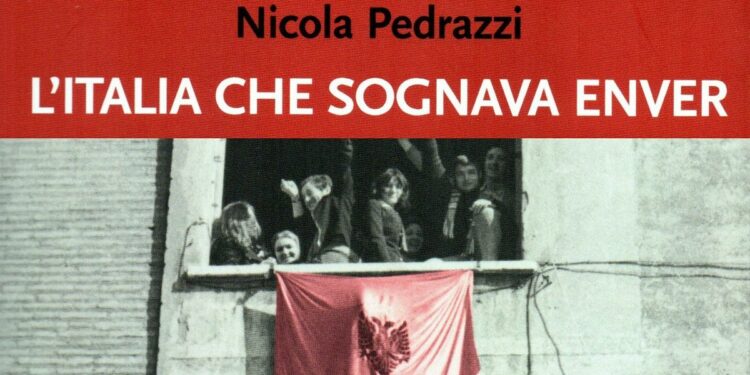Sommario
E’ stato recentemente pubblicato un ponderoso volume di Nicola Pedrazzi, ricercatore presso OBC Transeuropa di Trento – considerato il più importante centro di informazione e ricerca italiano ed europeo sui Balcani.
Dopo la laurea magistrale in Scienze Internazionali e diplomatiche all’Università di Bologna, dal settembre 2012 al gennaio 2016 Nicola Pedrazzi ha condotto la propria ricerca dottorale in Albania, per conto dell’Università di Pavia.
Titolo del saggio, frutto di questa ricerca è: “L’Italia che sognava Enver- Partigiani, comunisti, marxisti-leninisti: gli amici italiani dell’Albania Popolare”.
L’Autore si è avvalso, per la parte albanese, delle fonti archivistiche presso l’Archivio Centrale dello Stato Albanese di Tirana e – in Italia – dell’Archivio Storico-Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri a Roma.
Sempre per la parte albanese ha consultato una coerente letteratura di regime: da un lato gli scritti di Enver Hoxha ed i testi dell’Istituto di Studi Marxisti-Leninisti; dall’altro la pubblicistica ufficiale (il quotidiano “Zëri i popullit”, organo di stampa del PPSH, “Zëri i Rinisë”, “Puna”, “Mësuesi”, etc, tutti conservati presso la Biblioteca Nazionale di Tirana.
Se nel fronte albanese le fonti sono riconducibili ad un ordine monolitico, il lato italiano della ricerca – afferma l’A. – possiede un carattere polifonico e multilivello. Oltre all’Archivio del MAE e all’Archivio Centrale dello Stato, sono stati consultati gli Archivi della Fondazione Basso, dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, di quello dell’Emilia e – di particolare importanza – quello dell’Associazione “Bashkim Kulturor Arbëresh” di Spezzano Albanese che, unico in Italia, custodisce le collezioni complete di tutte le riviste italiane dell’area marxista-leninista.
1 Primo capitolo
Il primo capitolo “L’Italia e il comunismo nella formazione dello Stato albanese” è suddiviso in due sottocapitoli: “Le relazioni italo-albanesi dalla nascita dello Stato albanese alla monarchia zoghista (1912-1928)2 e “Il comunismo secondo Enver Hoxha (1941-1985)”.
Nel primo si evidenzia che l’interesse italiano nei confronti dell’Albania non è una invenzione del fascismo, ma affonda le sue radici nei Risorgimenti dei due paesi e nel ruolo diplomatico che l’Italia giocò nella formazione dello stato albanese prima e dopo la Grande Guerra.
Riportiamo quanto scrive Pëllumb Xhufi nel contributo “Flussi italiani nel movimento albanese di rinascita nazionale” pubblicato nel numero della rivista “Il Veltro” edita in occasione del Centenario dell’Indipendenza albanese, citato dall’A.:
«L’Italia del Risorgimento affascinò sin dall’inizio gli ideologi del movimento nazionale albanese. Uno di essi, Pashko Vasa, riconosce lui stesso, nel 1850, che fu l’amore per l’Italia, oltre che per la giustizia, che lo spinse a buttarsi nella rivoluzione di Venezia, nel 1848. Il suo amico, e coautore del primo programma politico del movimento, Sami Frashëri, era convinto che l’Italia, paese che aveva ospitato trecentomila albanesi, fosse la migliore garanzia per l’integrità territoriale del futuro Stato albanese. “Essa non permetterebbe mai che l’Albania fosse spezzettata tra greci e slavi”»
Le complesse vicende di quegli anni sono ampiamente illustrate nel libro: La massiccia penetrazione economico- infrastrutturale dell’Italia in Albania sin dal 1925; il Patto di amicizia e sicurezza del 27 novembre 1926; il Trattato di Tirana a distanza di un anno. Il 1° settembre 1928 Zog veniva nominato Re.
“Il comunismo secondo Enver Hoxha (1941-1985)” è dedicato alla biografia di Enver Hoxha e – afferma l’A. – “non è scorretto affermare che dal 1948 il comunismo albanese coincise de facto con Il comunismo secondo Enver Hoxha: la linea politico-ideologica e le scelte, internazionali ed interne, intraprese dall’Albania Popolare furono in ultima istanza il risultato delle esigenze e della volontà di un uomo solo al comando”.
Numerose pagine sono dedicate alla fondazione del PCA, alle vicende successive all’8 settembre 1943, all’invasione tedesca ed allo sbarco degli alleati in Grecia, alla liberazione dell’Albania nell’autunno del 1944 fino al 28 giugno 1948, quando l’Albania si schierò formalmente con l’Unione Sovietica.
Pedrazzi riporta dalla “Storia ufficiale del Partito del Lavoro d’Albania” la versione della fondazione del PCA: “La Riunione del Gruppi Comunisti per la fondazione del partito fu tenuta, in forma clandestina, a Tirana, dall’8 al 14 novembre 1941. Vi parteciparono 15 persone, fra cui Enver Hoxha, Qemal Stafa, Vasil Shanto, Pilo Peristeri ed altri”.
Nato nella clandestinità e in piena occupazione italiana, il PCA faceva della liberazione della patria il principale obiettivo programmatico.
2 Secondo capitolo
Oltre 80 pagine del secondo capitolo – Un’amicizia da rifondare: la resistenza 1943-1949 – sono dedicate alla guerra partigiana che durò tre anni: dalla fondazione del PCA (novembre 1941) alla liberazione del paese (novembre 1944). “Tuttavia, fino alla caduta mondiale del comunismo, per oltre mezzo secolo, questa breve esperienza divenne l’epicentro della secolare storia albanese, stadio ultimo e perfetto di un’evoluzione politica e morale che aveva traghettato la Nazione dal Medioevo al Socialismo. Questo capitolo – scrive l’A. – ripercorre gli ultimi tragici anni di guerra attraverso le testimonianze postume di chi li ha vissuti”.
Diamo un elenco dei paragrafi del capitolo: 1 – Dopo l’8 settembre: i soldati italiani in Albania; 2 – Dalla divisione “Firenze” al Comando Militare Italiano Truppe della Montagna; 3 – Il battaglione “Gramsci”; 4 – Diversamente italiani, diversamente rimpatriati: il circolo “Garibaldi”, la missione Palermo, la delusione del ritorno; 5 – Al di fuori della Resistenza: l’Italia nemica; 6 – Il PCI si sostituisce allo Stato italiano; 7 – Una Albania, due Italie. E così si conclude il denso capitolo: “Per buona parte dei partigiani italiani che ebbero la fortuna di lasciarla, l’Albania Popolare, nata dalla Resistenza comunista, rimase per tutta la vita un paese giusto che aveva avuto il coraggio della rivoluzione. Fu senza dubbio questa seconda Italia – che non coincise con l’Italia comunista, ma con un suo sottoinsieme minoritario – a custodire e tenere vivo, nella seconda metà del Secolo breve, il racconto italo-albanese”.
3 Terzo capitolo
Titolo del terzo capitolo “Il Partito del Lavoro Albanese e il Partito Comunista Italiano: «monocentrismo» e «policentrismo»: 1950-1960”.
Dopo un primo paragrafo dedicato agli antifascisti al confino ed ad uno spunto per un nuovo studio sugli albanesi di Ventotene che, secondo recenti aggiornamenti presso l’Archivio Storico dell’Isola furono almeno 76 – è interessante leggere quanto scrive al riguardo Altiero Spinelli nella sua autobiografia politica.
Pedrazzi ricorda in particolare la figura di Lazar Fundo, che dopo l’8 settembre lasciò l’Italia per ritornare in Albania presentandosi ai partigiani comunisti dichiarando che veniva a combattere con loro. Ma gli stessi lo torturarono e lo fucilarono.
Le relazioni che il PPSH intrattenne con il PCI vanno inquadrate all’interno del complesso rapporto che l’Albania instaurò con la “madre URSS” nel corso degli anni cinquanta.
Ampio spazio è dedicato – dopo aver raccolto alcune testimonianze orali – è dedicato alle conversazioni tra Krusciov e Hoxha. Sin dal 1956 l’appoggio pratico del nuovo leader sovietico “un pragmatico contadino capitalista” critico delle dogmatiche pianificazioni albanesi si era scontrato con l’indecifrabile psicologia della dirigenza albanese, un misto di nazionalismo, vittimismo e stalinismo.
Negli incontri a Tirana del maggio 1959 si consumò la definitiva rottura e – a partire da quella estate – il regime albanese guardò alla leadership sovietica non solamente con risentimento, ma con sospetto.
Alla luce dei documenti e delle testimonianze raccolte – sostiene l’A. – tre problemi di diverso ordine contribuirono alla rottura tra l’Albania e l’URSS: l’atteggiamento del leader sovietico, diretto, paternalistico e indisponibile a dissimulare un comprensibile senso di superiorità; il nuovo corso sancito da Krusciov imperniato sulla destalinizzazione e sulla distensione con Belgrado ed infine i disegni che ferivano il nazionalismo albanese.
Similmente, continua l’A. nel terzo paragrafo del capitolo, “Il PPSH e il PCI – Enver Hoxha e Palmiro Togliatti”, al rapporto tra i due segretari – anche le relazioni tra i due partiti non furono mai facili: da una parte un partito strutturato secondo i rigidi dettami del comunismo stalinista; dall’altra il PCI, un partito occidentale che aveva accettato con il compromesso costituente tutte le contraddizioni che si inserivano tra questa linea e il campo socialista di riferimento.
Seguono lunghe pagine di scambi epistolari tra Hoxha e Togliatti e di altri esponenti del PCI. Tirana, come si desume da un appunto manoscritto di Hoxha, privo di data che dovrebbe risalire all’autunno del 1957, iniziò a bollare come “revisioniste e opportuniste” le posizioni di Togliatti.
In un lungo documento del KQ indirizzato alla Legazione di Roma – che doveva rimanere segreto – sono evidenziati i nuclei della critica albanese verso i comunisti italiani. In particolare il “policentrismo” perseguito da Togliatti, inconciliabile con la visione “monocentrica” degli albanesi; l’affermazione di un comunismo specifico e nazionale, che significava per gli albanesi un pericoloso avvicinamento al modello jugoslavo; il disinteresse del PCI e del suo apparato e della stampa del partito per l’Albania Popolare.
Con il “testamento di Yalta”, Enver Hoxha si scaglia contro i revisionisti italiani. Segue un paragrafo dedicato a “Il mitra di Walter Audisio” donato dall’ex-partigiano ai compagni albanesi nel novembre del 1957.
Il capitolo si conclude con l’affermazione che – nell’interpretazione del regime albanese – il comunismo italiano aveva tradito al Rivoluzione, nel nome della Costituzione.
4 Quarto capitolo
Il quarto capitolo – di oltre 150 pagine – ha un titolo significativo: “Contro l’imperialismo. Contro il revisionismo: i marxisti-leninisti italiani nella «Cina sotto casa» – 1961-1976”.
L’alleanza sino-albanese degli anni sessanta non derivò da una convergenza oggettiva degli interessi dei due paesi – diversi, lontani, l’uno all’altro sconosciuti – ma dalla reciproca convinzione dell’utilità dell’altro.
L’alleanza con la Cina non venne mai formalizzata né da un trattato né da una cornice istituzionale. Per più di un decennio, tra Cina e Albania furono abolite le frontiere politico-ideologiche.
“Nuova Albania”, una rivista stampata a Tirana, cominciò ad essere tradotta in cinese. Il programma politico su cui doveva fondarsi l’amicizia tra i due paesi fu redatto in occasione della visita di Chou-En-Lai a Tirana nel dicembre del 1964.
Grazie all’assistenza cinese, l’Albania, a partire dal 1965, costruì e mise in funzione numerose fabbriche ed industrie.
Hoxha utilizzò la Grande Rivoluzione Proletaria promossa nel 1966 da Mao Tse Tung per dare il colpo di grazia alle comunità religiose e come pretesto per una radicale riforma dell’esercito. Ma, dagli anni settanta, la politica estera cinese ebbe un radicale cambio di linea. Cina ed Jugoslavia si scambiarono i rispettivi ambasciatori, la Cina Popolare fu ammessa alle Nazioni Unite e Nixon visitò la Cina.
Hoxha nel settembre del 1971 accusò pubblicamente la Cina di aver deviato dal marxismo-leninismo.
Diamo sinteticamente i titoli dei paragrafi che costituiscono il capitolo:
- La rottura tra PPSH e PCI
- A sinistra del PCI: la galassia degli “emmelle” italiani
- I marxisti-leninisti visti da Tirana
- Da Pechino a Roma, via Tirana: costi e benefici di una strategia
- L’Associazione d’amicizia Italia-Albania
- Il ricordo della Resistenza, il Sessantotto, la «rivoluzione tradita»
Sinteticamente possiamo evidenziare come, dalla fine degli anni Sessanta, i litigiosi movimenti marxisti-leninisti coagulatisi alla sinistra del PCI «revisionista» cercarono di appropriarsi della narrazione italo-albanese, promuovendo il rigido parallelo Cina-Albania.
Dagli archivi di Tirana emerge così – afferma l’A. – un aspetto inedito dell’Albania Popolare: ovvero la sua «apertura». L’accesso all’Albania Popolare non venne mai definitivamente precluso, men che meno agli italiani: bisognava far valere il proprio curriculum ideologico, ma per tutti gli anni Settanta le cosiddette “Associazioni d’amicizia” garantirono a generazioni di «nuovi comunisti in apprendistato» viaggi militanti – ovviamente scortati e mai lasciati soli durante la permanenza nel paese – nella terra che aveva avuto «il coraggio della rivoluzione».
Concludono il volume interviste a Sergio Staino, Costantino De Pasquale, Nevila Nika, Pino Acquafredda, Aldo Pugliese, Rita Marko, Vera Bekteshi, Fatos Lubonja, Liri Belishova.