La regina Teuta aspettava l’alba sulla vetta della torre più alta della fortezza di Risano. Nascosta per ore intere al riparo di una feritoia, attendeva scoraggiata un bagliore di luce che filtrasse attraverso il cielo mattutino, oscurato dal forte acquazzone che si abbatteva sull’intero universo. Le Bocche e la baia di Risano muggivano come enormi tori feriti, le rocce e le risacche marine fischiavano e sibilavano come serpenti inferociti; al di là delle montagne, coperte da un bianco manto di neve, lampeggiavano minacciosi fulmini che si spegnevano con gran fracasso nel mare.
La fronte della donna scottava per la febbre. Indossava ancora la pesante armatura da combattimento: si tolse l’elmo e strinse con tutte le forze i suoi capelli intrecciati a corona e annodati con un fine nastro di cuoio che ormai le aveva segnato la pelle con una profonda striscia rossastra. I grandi orecchini a forma di luna piena, che le pendevano fino al collo, tintinnarono, come il suo petto scosso da insoliti brividi sotto la corazza di metallo dell’armatura.
Avvolta fino alle orecchie in uno spesso mantello di lana, Teuta roteò languidamente gli occhi d’ambra verso est, dopo aver osservato il grosso muraglione di Risano e le sue numerose torri, schiarite nel buio fitto della notte dalle fiammelle dei focolari di pietra. Il muraglione si arrampicava, si aggrappava, zigzagava, traforava le rocce e serpeggiava attraverso le gole, gli scogli, i boschi folti, cingendo interamente la polis selvaggia, come un gigante anello difensivo costruito dalle mani dello stesso Medaur, la divinità illirica della guerra.
Tentò vanamente di scorgere un bagliore di luce nel cielo, ma non vi distinse altro che un buio profondo, la tempesta diluviale e la terribile disgrazia che incombeva sull’Illiria. Pregò Eos, la dea dell’aurora, quasi senza speranza nel cuore. All’improvviso, però, quando ormai la speranza dell’alba si era spenta del tutto e le fiammelle oscillanti delle fiaccole l’avevano trasfigurata in un fantasma di guerra in procinto di gettarsi nel vuoto dalla vetta della fortezza, la tempesta si placò, l’universo si quietò, e un lampo di luce color del sangue, come una profonda ferita causata da un coltello affilato, apparve nell’oscuro cielo di Risano.
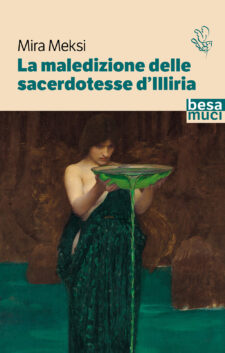
L’opinione
Storia, racconto e leggenda si fondono amabilmente in questo La maledizione delle sacerdotesse d’Illiria di Mira Meksi, scrittrice e traduttrice, tra le figure più apprezzate dell’attuale panorama letterario albanese.
Teuta d’Illiria è la protagonista indiscussa del romanzo, la regina guerriera, la figura leggendaria di un importante periodo storico. La regina pirata, capace di diventare l’incubo dei romani, dal profilo contraddittorio e fiero e soprattutto considerata l’antenata degli albanesi.
Come racconta la stessa autrice nell’interessante postfazione del libro, non esistono documenti storici relativi alla figura di Teuta, tantomeno reperti archeologici. Questo è uno dei motivi per cui la stesura del volume è costata tempo, studio e fatica; la Meksi, per dar vita e anima alle vicende della donna regina, guerriera, stratega, diplomatica e, soprattutto, il simbolo dello spirito illirico, che la legava sia alla religione, che alla fede degli illiri, compie un percorso nella propria consapevolezza prima e nella lettura di autori antichi e moderni dopo.
Così iniziò il mio lungo viaggio attraverso la foresta di migliaia di pagine di autori antichi e moderni: Polibio, Erodoto, Diodoro, Strabone, Apione, Tito Livio, ecc, e Karl Patsch, Stipcevic, Pierre Cabanes, Papazoglou, Çabej, Shaban Demiraj, Vladimir Orel, Hasan Ceka, Selim Islami, Neritan Ceka ecc., nonché attraverso le terre che portano orme degli illiri, nei musei e siti archeologici d’Albania e della regione – l’Illiria della fine del III secolo a. C., sotto il regno di Teuta si estendeva dal fiume Naro (l’odierna Neretva, Croazia) a nord, fino al golfo di Ambracia (l’odierno golfo di Arta, Grecia) a sud. (dalla postfazione del libro)
Urge creare una connessione necessaria tra Teuta e l’autrice, affinché quest’ultima possa adeguatamente narrarne le sorti e a tal proposito, la lingua albanese si erge a strumento indispensabile per poterla realizzare. Partendo dal concetto esposto da diversi filologi albanesi e non, secondo il quale essa è l’unica lingua viva derivata dall’illirico, di cui non si ha ancora nessuna traccia di scrittura, la Meksi pone la lente d’ingrandimento sulle radici della stessa, cosciente di trarne importantissimi spunti informativi.
Con moltissima fatica e ricerca, affidandosi anche alla raccolta di storie e leggende riguardanti i Balcani, l’autrice riesce a entrare in punta di piedi nel III secolo a.C., un oscuro periodo storico, rendendo quasi tangibile a se stessa il regno di Agron e di sua moglie Teuta.
Dopo la morte del re Agron, la regina Teuta trasformò Illiria in una delle più grandi potenze marine e terrestri del tempo, contribuendo con le sue gesta all’apertura di una pagina nuova nella storia del mondo: il tramonto del mondo ellenico e l’emergenza di quello romano. (dalla postfazione del libro)
La maledizione delle sacerdotesse d’Illiria è frutto di un grande lavoro, che ha richiesto impegno e tempo; quello che Mira Meksi consegna al lettore è un romanzo storico, in cui immaginazione e Storia trovano un lucido equilibrio. La peculiare attenzione che l’autrice riserva ai particolari, alle descrizioni e alle vicende storiche, non invade la parte di fiction del volume, rendendo la lettura scorrevole e di gradevole impatto. Ed è così che tra i righi del romanzo, tra un dialogo e l’altro, subito dopo un’emozione espressa, tra la descrizione di un volto e quella di un gesto, si ritrova tanta Storia, che permette di scoprire un periodo poco noto, ma di grandissimo peso per il decorso storico dell’umanità. Grazie alla fluida penna della Meksi, la regina Teuta, la sua imponenza e il suo tutto, arrivano a noi e alla nostra conoscenza.




