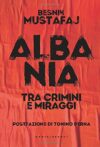Besnik Mustafaj è uno dei più prolifici e apprezzati scrittori dell’attuale panorama letterario albanese. Traduttore, giornalista e professore, oltre che diplomatico, è autore di importanti saggi e numerosi romanzi tradotti in svariate lingue.
Obiettivo e cristallino nelle descrizioni della sua Albania, Mustafaj non accarezza mai l’esaltazione nazionalista, bensì, abbraccia l’amore per una terra e per un popolo, che a suo dire, non apprende dal passato. Incontro Besnik a Tirana e così, una chiacchiera tira l’altra. Buona lettura.
Intervista a Besnik Mustafaj
Quali caratteristiche ha l’Albania dei tuoi libri?
Mi sono sempre preoccupato di narrare dell’Albania dove vive la gente che ha subito la Storia creata dalla politica. Un Paese, dove la Storia comune è diventata la zavorra dalla quale il popolo non ha saputo trarre alcuna lezione, trasformandola in un dramma collettivo. Anche dal punto di vista individuale, il profilo dell’albanese che disegno non coglie alcun insegnamento dalla propria storia personale, che faccia o non faccia parte di quella sociale. La storia individuale nasce da un’esperienza soggettiva e il fatto di non trarne insegnamento spiega il motivo per cui il popolo ripete sempre gli stessi errori, individualmente e collettivamente, di fronte alla politica e alla storia con la S maiuscola. Questa è l’Albania del mio rappresentativo immaginario.
È tua convinzione, quindi, che gli albanesi non conservino la memoria?
Penso che gli albanesi abbiano un rapporto con la memoria che rasenta il vittimismo. Al fine di compensare quella incompleta dimensione data dallo status di vittima, tendono a creare una sorta di folklore eroico, che non corrisponde minimamente alla realtà del destino individuale e di quello collettivo.
In Piccola saga carceraria tu guardi alla dittatura con gli occhi di chi l’ha vissuta e la mente di chi l’ha patita. Sembra che tu vada a scavare nella psicologia calpestata dal regime, creando una correlazione, quasi imprescindibile, tra l’una e l’altro.
In verità, ho voluto parlare della prigionia politica come istituzione e come realtà capace di influenzare più le persone libere che quelle imprigionate. Nel periodo della mia gioventù, ho scritto un romanzo incentrato sulla dittatura, che per ovvie motivazioni, non ho mai pensato di pubblicare, ma questa è una questione a parte. Avevo circa venticinque anni e vivevo già nella convinzione, che nonostante la storia avesse seguito il suo corso, la prigionia politica fosse rimasta sempre la stessa: nulla aveva cambiato la monarchia, niente il fascismo, tanto meno il comunismo. Dico questo, in riferimento alla linea storica dell’Albania, che prima è stata sotto la dominazione ottomana, poi ha lottato per l’indipendenza, fino al regime. Non solo i metodi caratterizzanti l’interdizione politica sono sempre stati gli stessi, ma anche i luoghi non sono mai cambiati. Per esempio, gli edifici adibiti ad accogliere il Ministero dell’Agricoltura nel periodo fascista, sono stati occupati dal Ministero degli Interni e durante il comunismo dal Ministero della Cultura. Anche i locali delle prigioni sono sempre stati gli stessi: ecco, ho trovato interessante sottolineare questa continuità, nonostante il passare del tempo e delle varie epoche.
Durante il periodo comunista, posso dire che il più grande gesto eroico fosse quello di farsi domande, perché solo se ti poni dei quesiti cerchi le risposte. Per questo motivo, il sistema totalitario era impostato affinché il popolo potesse non farsi domande e di conseguenza non cercare le risposte, prendendo in considerazione e per veritiera solo l’ideologia governativa. Il mistero, per me, stava proprio nel fatto che ad avere paura fossero i cittadini liberi, fuori dal carcere. Pertanto, ho voluto scrivere circa la storia della prigionia politica del Novecento durante la monarchia, il fascismo e il comunismo, tre sistemi più o meno monolitici, sia politicamente che giuridicamente. I personaggi che animano i miei libri non sono mai incarcerati, tranne quello protagonista del periodo comunista, anche se vorrebbe vivere come se fosse fuori. Quando ho compreso che la situazione mentale della gente libera e non condannata era la vera prigione e una sorta di lotta per la sopravvivenza, ho ritenuto opportuno raccontare questa verità.
Quindi, Piccola saga carceraria, se vogliamo, è una sorta di antologia composta da tre libri che potrebbero vivere separatamente. La prima storia narra della prigionia politica durante la monarchia; ho scritto circa centocinquanta pagine, facendolo passare come un racconto per bambini e pubblicandolo nel 1987. Del resto, il personaggio protagonista è un ragazzino e per questo ha visto la luce come un libro rivolto ai ragazzi, ma non lo è. Si tratta di un racconto terribile, che nulla ha a che fare con l’infanzia, ma la censura non lo ha compreso: ha guardato il profilo del bimbo e il periodo monarchico, nulla di più.
Il racconto riguardante il fascismo è stato pubblicato nel 1989, mentre quello narrante la realtà comunista, ha visto la luce su una rivista, subito dopo la caduta del regime, esattamente nella settimana seguente la liberazione. In quel periodo, ho compreso che, anche in un momento caratterizzato dalla libertà, non era facile accettare la realtà vissuta durante la dittatura. La figura protagonista di questa storia è un prigioniero politico, che ha diritto di trascorrere una notte con sua moglie in una camera, chiamata speciale. Egli attende tanto il momento per poter passare del tempo con l’unica donna della sua vita, che ama. Quando si trova nella situazione, non ce la fa a fare l’amore, perché subentra la paranoia, (o la verità), di essere ascoltato e spiato dalla guardia e per questo non riesce a essere maschio, senza poterne spiegare le motivazioni, altrimenti la donna risulterebbe colpevole di fronte al regime. Nasce, così, un’incomprensione tra i due amanti, tanto che la moglie gli chiede se fosse diventato omosessuale. Non è una domanda accusatoria, ma dettata dalla perplessità e dalla mancanza di chiarezza. Era la prima volta che si parlava di omosessualità in un libro albanese.
Quando il mio testo è stato pubblicato sulla rivista, un ex perseguitato politico e scrittore ha redatto un articolo terribile contro di me, per aver rappresentato, secondo il suo parere, i prigionieri politici come degli inetti e degli omosessuali. Questo dimostra come, per gli albanesi, la prigione sia mentale, specialmente in relazione alla politica, una realtà ancora oggi persistente.
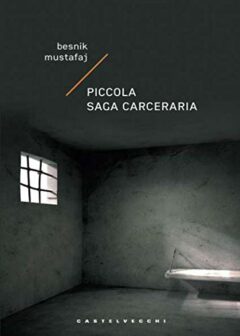
Hai pubblicato durante la dittatura. Mi interessa, a tal proposito, il tuo parere sulla Lega degli scrittori.
Ho scoperto la Lega quando avevo venticinque anni e ci sono rimasto per cinque anni. Non ho approfittato di nulla, nemmeno delle opportunità offerte di poter scrivere per loro, perché ero già giornalista e questo non mi era permesso. Posso dire che negli anni ‘60 e ’70 la Lega degli scrittori era un luogo terribile, perché era il posto da dove nasceva la denuncia pubblica degli scrittori e degli intellettuali.
Negli anni ’80, esattamente a partire dalla metà di quel periodo, io ho finito gli studi e ho cominciato a lavorare come giornalista e a frequentare l’ambiente. Bisogna tener conto del fatto, che era il tempo dell’inizio del crollo del regime, in cui Hoxha non era più così potente e di conseguenza tutto il suo circondario. Non mi è mai capitato di assistere ad alcuna riunione contro gli scrittori e quindi, non posso reputarmi un buon giudice della storia della Lega.
Negli anni ’90 appartenevo a un gruppo di giovani poeti e scrittori coraggiosi, di quelli che non avevano mai conosciuto la repressione. Eravamo totalmente incoscienti e soprattutto, con nessuno che potesse dirci: che fate? Avevamo acquisito una piccola importante indipendenza anche dai genitori, senza aver vissuto l’incubo che tanti intellettuali hanno conosciuto. Per quelli della mia generazione, la Lega non è stata importante per niente.
Io ero giornalista e nel 1988 sono stato chiamato a lavorare all’Istituto degli studi del marxismo, in qualità di traduttore. Ero davvero contento: avrei avuto il tempo a disposizione per poter scrivere, la biblioteca del comitato centrale dove potevo trovare i libri proibiti e avevo la stampa straniera da poter consultare come Le Monde, Il Corriere della sera, Il New York Times e altri. Ad agosto dello stesso anno, mi sono recato in Svizzera come interprete e al ritorno ho scritto una lettera di denuncia: eravamo ventotto intellettuali, più due autisti e avevamo quattordici uomini della Sigurimi a controllarci. In questa missiva ho chiesto come fosse possibile introdurre ben quattordici sorveglianti per ventotto artisti. Naturalmente, la mia protesta ha fatto molto rumore, c’è stata una riunione interna, dove stato quasi processato davanti ai colleghi dell’Istituto del marxismo. Mi è stato chiesto come avessi osato lamentarmi e fare una cosa del genere. In quel momento ho avuto paura, non tanto di essere arrestato, quanto di essere esiliato, soprattutto per i miei figli. È intervenuto Dritëro Agolli che mi ha preso all’Unione degli scrittori, cosa di cui sarò sempre riconoscente. Questa collaborazione è andata avanti per circa sette mesi, poi il regime è caduto. In seguito, ho compreso che loro avevano timore delle cose dette da me, altrimenti, io sarei andato in prigione, diversamente: sarei stato punito e basta.
Tu sei stato un diplomatico, ma come diventi scrittore?
Io ero già scrittore quando sono entrato nel mondo politico; premetto che non è mai stata mia intenzione fare carriera politica. Nel ‘91, infatti, ho rinunciato a diventare Ministro e di conseguenza all’ascesa. Ancora nel ‘92, ho rifiutato, in seguito alla vittoria del Partito Democratico, alla carica di Ministro degli Esteri, ma questa scelta va contestualizzata.
I deputati del Partito Democratico, agli inizi degli anni ‘90, erano tutti molto acculturati, me compreso: la conoscenza delle lingue, per esempio, era un notevole punto di forza. Sali Berisha, all’epoca Presidente della Repubblica, non aveva mai letto una legge, anche solo per capire di cosa si trattasse. Io, pensando a un testo legislativo sulle dogane, ad esempio, potevo intuire fosse compreso in circa 4-5 pagine: in realtà, si trattava di ben 300-350 pagine. Ho capito, quindi, che sarebbe stato un lavoro ben più pesante di quello che potessi pensare: io ero uno scrittore e per quelle mansioni era necessario conoscere la giurisprudenza. Con i mezzi odierni, sarebbe stato tutto più semplice, ma noi abbiamo commesso tantissimi errori. Eravamo tanti scrittori, in un Parlamento libero e pluralistico e non si fa lo Stato con gli scrittori. Per questi motivi ho rifiutato la carica. Ero uno dei pochi ad ammettere che quello non era il mio mestiere: va bene la politica, ma non il potere e le due cose sono strettamente correlate. La prima ti porta verso il dominio e le realizzazioni si ottengono con l’egemonia, non con il discorso pubblico: in questo caso sei un intellettuale, non un uomo politico.
Sono stato criticato da tutti, giudicato per aver rifiutato un ruolo di responsabilità davanti alla Nazione: anche la stampa nazionale mi ha accusato di questo. Così, ho capito che dovevo accettare un onere: in quel momento, Berisha mi chiedeva di andare come Ambasciatore a Parigi ed è qui, che ho incontrato Octavio Paz, uno scrittore, diplomatico e ambasciatore per il Messico, che mi ha decisamente consigliato di accettare l’incarico, abbattendo tutte le mie preoccupazioni legate alla mancanza di tempo per poter scrivere. Tu sei lì a rappresentare, non a presentare – mi diceva – gli altri lavorano e tu firmi. Non soffermarti a leggere, altrimenti vorrai cambiare qualcosa, necessariamente. Inoltre, uno scrittore, in questo ruolo è ben accetto: se farai bene, diranno che sei bravo, proprio perché scrittore, se farai male, penseranno che un autore è normale che possa errare. In entrambi i casi, sarai salvo.
Così, quando sono tornato a Tirana, ho comunicato la mia accettazione a Berisha, anche se in quel periodo non ho scritto molto. Avevo tanto già di preparato e quando ho avuto bisogno di fare altro, ho chiesto le dimissioni, che il Presidente non ha accettato. Era il ‘94 e non volevo fare storie. Nel ‘97, supportato dai motivi politici dell’epoca, ho potuto dimettermi. Tanti amici, Chirac compreso, volevano che restassi a Parigi: avrei potuto insegnare all’Università, o lavorare per qualche Fondazione. Erano anni bui per l’Albania, ma avevo il desiderio di tornare nell’ambiente linguistico della mia scrittura. Io scrivo solo in albanese e di Albania: i miei personaggi sono albanesi. Sentivo l’impellente bisogno di tornare alle mie radici linguistiche. La lingua per me è molto importante.
Due parole sul futuro dell’Albania
Come sai, io sono sempre presente nel dibattito politico. Mi considero un europeista, un cosmopolita che vuole restare in Albania e poter viaggiare. Sono felice di aver lavorato come Ministro per concedere agli albanesi la possibilità di muoversi senza visto, per esempio. Sono ottimista, non vedo alcuna forza politica che voglia chiudere l’orizzonte europeo alla società albanese. Quello che mi rattrista è vedere la gioventù che lascia il Paese, che, a sua volta, vive una situazione paradossale. A capo della nazione, vi è un governo profondamente corrotto e un Primo Ministro autoritario. I giovani e non solo loro, avendo la possibilità di andare, agiscono in maniera individuale. Lasciando l’Albania, non contribuiscono alla trasformazione del Paese, facendo del male allo stesso. Sono felice che la gente possa andare, ma torniamo a quanto detto all’inizio: non si trae alcuna lezione dall’esperienza individuale, se non quella di intraprendere la via più semplice. Noi siamo rimasti nei periodi più difficili: il primo giorno dopo la caduta della dittatura, durante le manifestazioni degli studenti, io non ero sicuro di tornare a casa dove era mia moglie con i bambini. Adesso, è ridotta la possibilità che possano crearsi situazioni drammatiche e diventa facile essere scontenti e rivoluzionari. Io ho fatto la mia rivoluzione e non sono un rivoluzionario, bensì un evoluzionista; credo sia un ottimo compromesso per vivere in pace con me stesso.