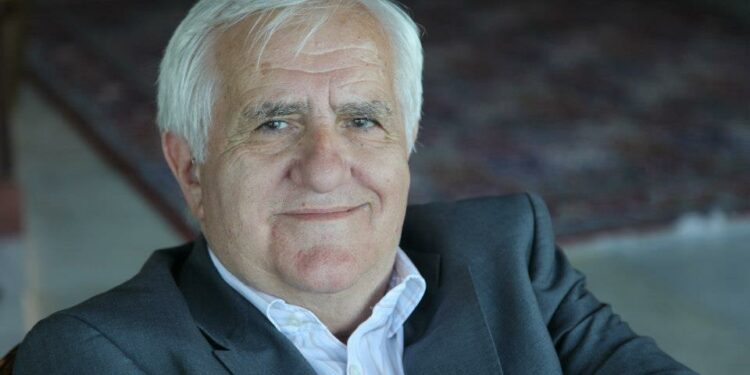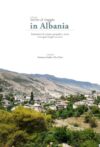Ho conosciuto Luan Starova in Calabria nel 2006, durante uno dei tanti seminari sulla cultura arbëreshe-albanese organizzati da Francesco Altimari, decano degli albanologi italiani. Negli anni a venire gli incontri si sono moltiplicati con cadenza annuale quasi regolare: in Albania, in Macedonia, in Tetovo, nella Kosova e, naturalmente, ancora in Italia, dove Luan è tornato più volte quasi a voler ribadire il profondo e indissolubile legame contratto con il mondo arbëresh. Ogni occasione di rivederlo si trasformava in un momento di confronto che ci portava inevitabilmente a discutere di letteratura, di Apollinaire e di Faik Konica, che amava entrambi infinitamente, di Kadare e di Girolamo De Rada, degli arbëreshë e, naturalmente, dei suoi romanzi, che Egli voleva tradotti dal macedone in albanese e poi, se le circostanze glielo avessero consentito, anche in italiano e nelle altre lingue europee. Era un piacere, un’autentica goduria intellettuale conversare con quest’uomo buono e gentile, colto e raffinato, tanto affabile da far dimenticare l’arroganza e la violenza che aveva patito nella sua vita. L’ultimo incontro è stato “virtuale” a causa della recente pandemia. È accaduto in occasione dell’80° compleanno del Nostro che l’Accademia delle Scienze d’Albania ha opportunatamente festeggiato con un convegno al quale ho partecipato inviando una breve interpretazione della Saga balcanica da cui sono state tratte le seguenti riflessioni. La scomparsa di Luan ha duramente colpito la sua famiglia, a cui rivolgo le mie più sentite condoglianze, e il mondo letterario albanese, all’interno del quale la sua opera occupa un posto di assoluto prestigio.
La saga balcanica di Luan Starova costituisce un evento di notevole rilevanza nel panorama della letteratura del Sud-Est europeo, della cui traiettoria non a caso segna una curvatura significativa. Rileggendola a distanza di qualche anno e facendo leva sulla nutrita bibliografia critica che nel frattempo le è stata riservata, sono diversi gli spunti che vi emergono e che obbligano a una riflessione non sempre propriamente letteraria. Al centro delle metafore di forte ascendenza surrealista di Luan Starova si collocano le profonde lacerazioni che nel corso dei secoli hanno attraversato, quasi sempre devastandola, la Penisola Balcanica e le diverse popolazioni che la abitano. Uno scenario geopolitico che ha vissuto i più grandi conflitti dell’era moderna e, soprattutto, le imposizioni di soffocanti ideologie del potere, sempre importate dall’esterno nel segno del dominio e della sopraffazione.
La saga balcanica è un modulo narrativo che ruota attorno alle vicende della famiglia Starova, del padre e della madre di Luan. Una famiglia albanese costretta a cambiare residenza con il mutare delle avverse condizioni politiche e con il profilarsi di rischi che comportavano i frequenti cambiamenti di regime. È una storia (auto)biografica che ha inizio con lo scoppio delle guerre balcaniche nel 1912, anno della realizzazione del grande sogno nazionale albanese con la dichiarazione d’indipendenza; che proseguirà, come ha ben ricordato Edgar Morin, con «quel ripiegamento nazionalista turco che condurrà alle deportazioni che più tardi saranno chiamate purificazioni etniche e persino al massacro delle popolazioni». Un continuo inanellarsi di vicende tragiche, di tentativi di annientamento dell’altro, di imposizione di un punto di vista sugli altri, la riduzione a condizione di inferiorità di coloro che etnicamente, linguisticamente, culturalmente vengono percepiti “diversi” in ordine alla rispettiva appartenenza “nazionale”, a questa categoria introdotta nei Balcani con il fragore dei cannoni e la puzza della polvere da sparo in deciso contrasto e in aperta avversione con quella consolidata visione del mondo che vedeva i diversi popoli della Penisola “l’altro dal proprio”. È nella mutazione dello sguardo e nella metamorfosi dello spirito profondo del Sud-est europeo che il racconto surreale di Luan Starova si incardina, immettendosi in un percorso intergenerazionale allo scopo di ricostruire, attraverso la narrazione delle vicissitudini familiari e delle traversie intime dell’Autore-testimone, il filo delle vicende storiche di un’intera regione, la stessa che, a partire dal 395 e per i secoli a venire, ha incarnato simbolicamente la celebre Linea di Teodosio e che, come suggerisce il titolo di un bel saggio ancora attuale di Aurel Plasari, ricompare (“rishfaqet”) nella sua antica funzione di confine tra Est e Ovest, tra Occidente e Oriente. Una funzione che all’indomani della seconda guerra mondiale si è ammantata di nuova veste, dissimulando le “differenze” etniche sotto la coltre della uniformità ideologica: dopo quello bizantino e quello ottomano, un’altra Weltanschauung ricopriva il volto del Sud-est europeo, ancora una volta proveniente da Oriente, questa volta dalla Russia sovietica.
La saga Balcanica di Luan Starova percepisce la minaccia che serpeggia per il Sud-Est europeo sin dall’immediata caduta della cortina di ferro e per disattivarne la portata disgregatrice avanza la sua ipotesi salvifica la quale, non senza un eccesso di ottimismo, si profila nei termini di una ricerca coraggiosa e accorata delle identità perdute, del recupero del passato non come glorioso panteon né come coacervo di trofei, bensì come agente catalizzatore del dialogo e dell’apertura, come ha ben chiosato Edgar Morin in un giudizio che è stato fatto proprio dai lettori e dai critici di Starova. In altri termini il lontano passato, quel medioevo tanto vituperato, anche se in forma indiretta, viene evocato come crogiolo e forgiatore della comunicazione, delle culture dell’apertura e del confronto con l’altro. Un altro che nei romanzi di Starova giunge ad assumere le sembianze di una diversità di genere, radicale come può esserlo l’effetto di una antropomorfizzazione eccessiva di animali – ad esempio le capre, il caprone, le anguille – o la suggestiva forza di rendere vitali oggetti inanimati dai quali pure dipendono il progresso delle civiltà e il destino degli uomini.
Le storie riversate nella saga balcanica ripercorrono soltanto le tensioni vissute dalla famiglia Starova, ma si dilatano sino a includere la vita di intere popolazioni, i cui destini vengono manovrati dall’alto in forza di ignoti meccanismi di potere e allo scopo di realizzare folli disegni autoritari. Come le capre, anche gli uomini e le donne, le comunità umane vengono trascinate nel vortice delle paranoie ideologiche che tutto travolgono e tutti stordiscono, inaridendo e alterando la più evidente, semplice e naturale logica delle cose. Nel nome delle ideologie – nel caso specifico considerato da Starova, del comunismo importato a forza nei Balcani all’indomani della Seconda guerra mondiale – si invertono le priorità, si inseguono insani progetti di trasformazione dell’uomo, si perseguono obbiettivi innaturali come quello della “costruzione dell’uomo nuovo”, si avanzano propositi di trasformazione delle ataviche identità sociali, si prefigurano rivoluzioni che scardinano i collaudati e secolari assetti antropologici, si disegnano profili incompatibili con la visione naturalistica dell’uomo e con la sua missione primordiale: ricevere e dare la vita. Il tutto in un quadro di determinismo ideologico che non tiene più conto della storia e della tradizione e che, invece, affida a un nuovo messianismo il potere di stravolgere le identità individuali e comunitarie.
Proprio da questo coacervo di falsi miti e di tragica realtà Starova ricava il materiale delle sue peregrinazioni narrative; da quel mondo paradossale nel quale lui e la sua famiglia – assunta a simbolo delle migliaia di altre famiglie precipitate da vittime nel delirio della nuova ideologia, nella notte sonnolenta della ragione –, estrapola gli episodi destinati a rappresentare il lato grottesco dell’esistenza umana. Una vita scandita dai mille espedienti che una volta esplorava il padre – in quanto capostipite e principale responsabile della famiglia –, erano poi messi in atto per salvaguardare l’incolumità familiare. “Kur babai shihte se familja ndodhej para rrezikut të luftës, zhdukej diku pa lajmëruar, që ta përgatiste shpërnguljen e ardhshme të familjes” [Quando papà constatava di trovarsi dinnanzi alla minaccia di una guerra, spariva senza darne notizia, per prepararsi al futuro esilio della famiglia]. Quella che un tempo corrispondeva a una vitale misura medievale della normale esistenza di popolazioni nomadi, nei tempi moderni del Novecento si trasformava in una prudente e preventiva norma di sopravvivenza. Si trattava pur sempre di un trasferimento da un luogo all’altro, ma la differenza era ontologica: non ci si spostava più per la necessità imposta dalla vita, bensì per la istintiva fuga dalla probabile morte. Un gioco di paradossi che nella realtà effettuale balcanica – di quei “maledetti Balcani” la cui modernità contrassegnata da ininterrotte e incomprensibili guerre fratricide – segnava un percorso lastricato di sofferenze spirituali e di metamorfosi culturali. Un percorso che in un momento dato della vita dei protagonisti di queste infinite peregrinazioni avrebbe pure richiesto un bilancio finale, un’analisi consuntiva delle esperienze vissute e delle lezioni acquisite. Sta in questa urgenza, a mio avviso, la visione ottimista della narrativa di Starova la quale, se è concesso un parallelismo, sembra ricalcare, ma seguendo un percorso opposto, la Weltanschauung che Thomas Mann riversò nella saga genealogica dei Buddenbrook: da un lato, si trova la famiglia anseatica, che il giovane scrittore tedesco descrisse ispirandosi alla propria vicenda familiare, quale storia familiare segnata dalla fissità (nello spazio) e destinata a subire (nel tempo) l’inarrestabile rovina sociale quale cifra e simbolo di una più generale e ineluttabile decadenza epocale; sul versante opposto si dispone la famiglia di Starova, descritta dal privilegiato punto di vista che distingue il narratore nella sua qualità di protagonista-testimone, la cui storia è votata a un’infinita mobilità (nello spazio) ed è spronata verso la riscoperta (nel tempo) di se stessa attraverso la continua rielaborazione delle ragioni profonde della sua identità. Sospinta alla ricerca spasmodica, affannata e quasi disperata di un nuovo ubi consistam, la narrazione di Starova dà vita a una vera e propria “saga familiare” che, inserita nel vortice degli eventi, trascina i singoli componenti, li obbliga a immergersi nella storia caotica dei luoghi ove si ritrovano, a subire il peso lacerante delle profonde trasformazioni determinate dalle intemperie ideologiche, politiche e militari, con effetti tanto gravi da divenire persino causa di indelebili deformazioni identitarie. Processi inevitabili di alienazione che, per un verso, tradiscono l’estrema alternativa offerta dall’istinto della sopravvivenza e che tuttavia, per un altro verso, in virtù di una singolare e individuale reazione controfattuale, incitano ad aprire la via ai paradossi giungendo persino a ipostatizzare imperativi categorici di decisa ascendenza ontologica, quale ad esempio la ricerca dell’identità perduta ed eventualmente, l’afflato di ricostruirla quasi si obbedisse a un richiamo ancestrale, profondo, inestinguibile. Proprio a questo richiamo risponde con lucida consapevolezza il narratore-testimone, non esitando a dichiararlo nella seguente descrizione del padre acutamente ripresa dal prof. Ali Aliu nella prefazione all’edizione albanese del romanzo Librat e Babait [“I libri di mio Padre”] che è anche una puntuale descrizione critica dell’intera saga balcanica:
“Babai në shpirt bartte dy lumenj të bujshëm që vazhdimisht bymeheshin, por që asnjëherë nuk bashkoheshin, as derdheshin te njëri-tjetri e as që përfundonin në detin e largët të mendimeve të tij: njëra rrjedhë shprehte instinktin për ruajtjen e identitetit…, kurse tjetra gatishmërinë që çështja e identitetit të relativizohej”.
[Dall’anima di mio padre sgorgavano due fiumi in piena che si gonfiavano continuamente, ma che non si fondevano, non confluivano l’uno nell’altro, né defluivano nel mare lontano dei suoi pensieri: l’uno esprimeva l’istinto di conservazione dell’identità…, mentre l’altro la disponibilità a relativizzare la questione dell’identità]
Il viaggio a ritroso di Starova si configura naturalmente come un viaggio nella sua intimità di testimone alla riscoperta del dramma vissuto da famiglie che ancora non sapevano di vivere sul limitare di mondi eterogenei e che, al contrario, ritenevano ingenuamente di condividere gli stessi spazi in cui lingue e culture diverse rivelavano la loro innata propensione alla porosità, alla interlocuzione pacifica e alla reciproca interazione. L’introspezione coraggiosa del singolare testimone delle vicende vissute dai “balcanici” nel corso del secolo più torbido della storia europea, scandaglia gli angoli più remoti della memoria individuale sino a trasformarla nel paradigma universale di un’intera collettività, della stessa umanità. Un concetto quest’ultimo ben chiosato da Éric Faye quando qualifica il romanzo Emigrimi i ngjalave [La migrazione delle anguille] «metaforë metafizike, metaforë politike, [sepse] pushon pak nga pak së qeni emigrimi i disa njerëzve të veçantë, për t’u shndërruar në një udhëtim të njerëzimit me zgjedhjet e tij, me ngurrimet e tij, me gabimet e tij» [metafora metafisica, metafora politica, [giacché] cessa a poco a poco d’essere l’emigrazione di alcuni esseri speciali, per trasformarsi nel cammino dell’umanità con le proprie scelte, con le proprie esitazioni, con i propri errori]. Non solo, ma a voler valutare adeguatamente il rapporto referenziale tra rappresentazione metaforica e realtà, non possiamo non concordare con il giudizio con il quale Silvana Leka, sempre riferendosi alla stupefacente metafora dell’emigrazione delle anguille – metafora che nella prosa di Starova, come si è detto, può abbracciare l’intero corpus narrativo della saga balcanica – ha evidenziato come
«Metafora vendoset në truall real kur pengesat nuk janë më abstrakte, por kur ato realizohen përmes diktatit, në emër të propagandës, të utopive dhe kur janë po aq artificiale sa forcimet e kufijve dhe mbyllja e liqeneve me diga mbytëse».
[La metafora si colloca su un mondo reale quando gli ostacoli non sono più astratti, bensì quando si realizzano attraverso del diktat, in nome della propaganda, delle utopie e quando sono tanto artificiali quanto i rinforzi dei confini e le chiusure dei laghi con dighe soffocanti].
Sul piano propriamente letterario, la narrazione di Luan Starova intercetta uno dei cruciali temi della teoria letteraria, la quale – come ha brillantemente evidenziato il prof. Ali Aliu nelle prefazioni alle edizioni albanesi dei due romanzi Librat e Babait e Koha e dhive [Il tempo delle capre], che costituiscono rispettivamente i primi due volumi della saga balcanica – da tempo pone al centro della propria riflessione ermeneutica la questione del ruolo del testimone-narratore e dei suoi rapporti con l’autore. Si tratta dell’aspetto che, al pari di numerosi altri, colloca la prosa di Starova nell’alveo di quella tradizione modernista o, meglio, surrealista, che in Apollinaire aveva il suo primo e più estroso esponente e che continuerà nel corso dei primi decenni del secolo scorso contribuendo alla trasformazione sin dalle sue fondamenta del romanzo contemporaneo. La prosa di Starova è un esempio del tutto originale della letteratura contemporanea balcanica e sviluppa, come accennavo in apertura, un personale intervento attorno al tema-chiave dell’autobiografismo letterario, imprimendo un significativa curvatura al paradigma, ancora enigmatico e tutt’altro che chiarito, che sovrasta la creazione artistica tout court e, più specificatamente, quella letteraria.
A conclusione di queste poche annotazioni, mi è gradito ricordare l’esperienza vissuta con Luan Starova nell’ottobre 2015 in occasione della sua partecipazione al Festival delle letterature migranti che si organizza a Palermo. Insieme ai colleghi Maria Teresa Giaveri e Francesco Altimari, abbiamo intrattenuto un folto pubblico conversando con il Nostro scrittore, all’uopo sollecitato a rivelare i segreti della sua scrittura. Ne è scaturita una sorta di “confessione” che ha esplicitato come la sua vicenda umana e intellettuale si sia sviluppata sul crinale dei confini, mai stabili e sempre labili, nell’incessante ricerca della dimensione identitaria, ovviamente in prima istanza della propria, ma immediatamente dopo anche in relazione a quelle degli altri. Quando gli organizzatori mi chiesero un titolo per la conversazione con Starova, quasi d’istinto, mi sovvenne un parallelismo tra la prosa di Luan Starova e quella dello scrittore arbëresh Carmine Abate: un parallelismo niente affatto estemporaneo perché scaturiva da una lettura sinottica di due esperienze di vita contrassegnata dalla medesima sofferenza, l’emigrazione, che per entrambi gli scrittori, l’uno albanese d’Italia e l’altro albanese di Macedonia, aveva esercitato una grande pressione intellettuale sulla propria prosa. Entrambi hanno interpretato la propria condizione di permanente instabilità, di migranti per l’appunto, come risorsa per intrecciare origini e percorsi individuali, giungendo a trasmettere all’altro, come ha ribadito Francesco Altimari, un’idea profonda e nient’affatto folkloristica della propria identità e della propria comunità di appartenenza. In entrambi ha pesato il cruccio della lingua e della comunicazione. Tutti e due avevano scartato gjuhën e zemrës [la lingua del cuore] a vantaggio della gjuha e bukës [la lingua del pane], che in questo caso era assurta alla lingua dell’arte. Entrambi avevano trasformato la propria condizione di migranti eterni in quella di profughi, ovvero di profughi linguistici. Da qui il titolo che ho suggerito all’incontro del 2015: “Luan Starova: Esperienza di un profugo linguistico”…. Oggi l’avrei completata aggiungendo “… alla ricerca dell’identità perduta”.