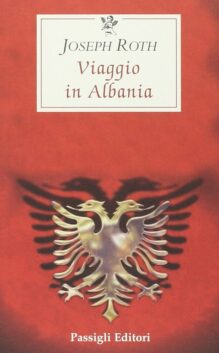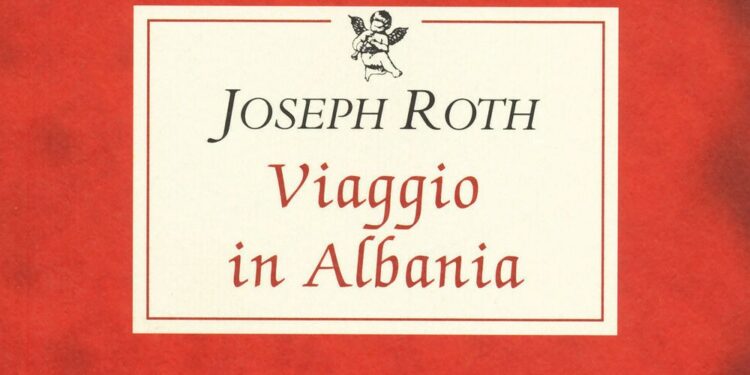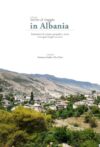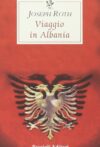Quasi cento anni fa uno dei più brillanti scrittori europei avrebbe viaggiato per l’Albania.
Corrispondente del «Frankfurter Zeitung», Joseph Roth nel 1927 attraversa un paese del quale, pur con esagerazioni e senza dati e statistiche scientifiche a disposizione (che spesso erano erronee), riesce a capire l’essenza e l’anima meglio di tanti esperti e ricercatori armati di conoscenza linguistica e di studi specifici.
«Molto meno sensibile alle bellezza della natura di quanto non lo siano i turisti di indole ottimista», come asserisce egli stesso, Roth si sofferma sugli aspetti culturali, di mentalità e di tradizioni di quel paese che egli all’epoca vedeva «a metà strada tra la vendetta di sangue e le Società delle Nazioni». Oriente in tutto e per tutto, questa sua Albania è Occidente solo «in quelle città per tre quarti europee come Skutari, Valona e Coriza»; il resto è un mondo «esotico», a volte «barbaro» a volte «primitivo».
Ma, al di là delle descrizioni che possono sembrare tese a svalutare gli albanesi (nella logica in cui scrive, tuttavia, non lo sarebbero), questi articoli sono uno straordinario documento sulla continuità di alcuni aspetti del mondo albanese, di quel passato orientale che troviamo ancora nel presente europeizzato. Anzi, si potrebbe dire anche di peggio, ovvero che l’occidentismo dell’oggi, costruito in tale maniera, potrebbe avere l’effetto di un maquillage che con il caldo e il sudore accentua e aggrava la bruttezza.
Più che le staccate o le cesure, la storia è fatta di continuità. In effetti, è spesso quel continuum, soprattutto sugli aspetti peggiori, che dovrebbe far riflettere gli storici e gli intellettuali di una data cultura. Le impressioni di Roth di cento anni fa non sono molto distanti da quelle di un intellettuale di oggi, posto che questi sia libero, disinteressato e soprattutto, non subisca la costruzione della nuova bellezza albanese.
«L’Albania è bella, infelice, nonostante la sua attualità, noiosa», sembra essere scritto da qualcuno che oggi si aggira per il paese; invece siamo nel 1927. Perché in un paese dove «la libertà è un concetto relativo» tutto diventa noioso, perché le vie dell’estrinsecazione delle virtù si riducono. Oggi si direbbe che è tutt’altro che noiosa, ma soltanto a un primo impatto da turista, quando l’anarchismo estetico crea l’illusione di stimoli autentici. Invece, il paese, allora come oggi, porta con sé gli stessi malanni, soprattutto per chi ci vive.
In un «paese in cui non è sicuro né chi governa né chi è governato», si impara – questo da secoli, poi il comunismo ha fatto la sua parte – a non esprimere la propria opinione, ma – scrive Roth – «a forza di non esprimerla, smetteranno di averne una e ascolteranno quella altrui: così, al posto di una convinzione politica, subentra l’adesione al partito politico».
Infatti, da un certo punto di vista, si potrebbe dire che gli albanesi non hanno convinzioni politiche strettamente personali, e, se e quando le hanno, sono conformi, per inerzia, ai dettami tradizionali della famiglia o del klan.
Il rapporto che agli occhi di Roth gli albanesi avevano con la loro cultura pare non essere troppo cambiato nel corso degli anni. Egli è riuscito a capire alcuni paradossi della società albanese, come quel «conservatorismo nazionale» che agisce «a scapito dell’umanità», ma anche le «peculiarità tribali a scapito della nazione». Così, non si costruisce né un mondo basato sui valori della civiltà europea e nemmeno una nazione con un senso proprio.
Balza agli occhi del grande scrittore la miseria della classe media «meschina… (essa stessa colpevole) e sempre con il desiderio di lasciare il Paese» – quanta è ancora oggi, purtroppo, verità. Le parole più belle, tuttavia, sono quelle rivolte alla classe degli «pseudointellettuali», un «élite assai esigua che provoca a questo paese più danni che profitti». Si tratta di quei «mezzo istruiti, avidi di denaro, sempre pronti a negoziare con vicini interessati e a ordinare cospirazioni».
A volte sembrano le parole di un Noli, a volte di un Eqerem bej Vlora, e volte, tradotta in prosa, una poesia di Ali Asllani, ma è uno straniero lontano a scriverle. E Roth guarda ai difetti di questo popolo con estrema obiettività, partendo dal dispiacere di vederli arrancare e soffrire in questo modo nel mezzo dell’Europa. Che si tratti dei politici, della classe media o degli “intellettuali”, il male maggiore allora, ma ovviamente anche agli occhi degli osservatori odierni, da Roth descritto in maniera letteraria come «la qualità più pericolosa, è l’amore per il denaro».
Nella maniera più sbagliata gli albanesi amano arricchirsi, perché l’Albania era ed è, appunto, «un povero paese ricco». Egli, in una maniera geniale, condanna, quindi, non tanto l’avarizia, ma il fatto che «è difficile insegnare un albanese che ci sono cose che si fanno per niente, vale a dire… nell’interesse della cosa pubblica». L’albanese che pensa soltanto al suo orto oggi è facilmente riconoscibile come lo era anche allora. In passato si parlava di bajrak; oggi quel bajrak si è ingrandito tanto da chiamarsi Tirana.
Non si può non notare quanto risultino belle le parole ironiche su quella classe di albanesi che, una volta che hanno visto il mondo, tornano in patria. L’autore si riferisce «alla pseudocultura e al mandolino di coloro che sono rientrati dall’America», ma il dramma è che, ancor oggi, quel «mandolino» rubato (oggi elevato al grado di chitarra) e le serenate copiate oltre oceano divengono, agli occhi degli albanesi, soprattutto quelli più colti, ottenebrati dal loro regionalismo malato, sinonimo di “Cultura”; parimenti, a seconda delle circostanze, le varie pseudo-città si autoincensano nel voler sembrare esclusive depositarie dell’attributo «di cultura».
Roth si accorge cento anni fa della malattia albanese rappresentata dalla devozione fanatica verso la tradizione e dall’ansia di conservare gli antichi costumi, tanto venefica al punto da trasformarci in patetici estimatori di serenate copiate da altri a scapito della vera musica o, come nel presente, in proseliti parrocchiali che protestano, nel dialetto di Tirana, per la sopravvivenza del ‘teatro nazionale’ (un edificio fascista di scarsissimo pregio estetico) a discapito di tutti i monasteri, chiese e moschee antiche che in Albania rischiano di crollare per mancanza di restauro ma che gli intellettuali di Tirana nemmeno sanno l’esistenza. D’altronde, questo paese, come diceva l’austro-ungarico Roth, è, oggi come allora, in mano, alle «sanguisughe alfabetizzate».
In conclusione, questo libro, a parer mio, è una lettura obbligata anche per gli stranieri in Albania, compresi gli ambasciatori e i diplomatici di oggi che, come quelli di allora, arrivano da «europei civilizzati» ma si riducono, con il passare del tempo, ad assumere le caratteristiche deteriori dell’albanesità.
Nel paese esiste una buona fetta di popolazione che, per cultura e mentalità, potrebbe sentirsi perfettamente a proprio agio a Parigi o a Berlino, vivendo alla stregua della migliore cittadinanza europea, ma che in patria, per l’assenza di libertà (l’anarchia è altra cosa) oppure a causa di una povertà che solo in pochi riescono a sopportare con dignità, finisce per ritrovarsi schiacciata tra il dominio dell’atavica mentalità albanese da un lato, e la presunzione dei cosiddetti «europei civilizzati» giunti nel paese dall’altro. Quindi leggetelo, leggiamolo.