Se premettiamo che il romanzo moderno, quello nato con Cervantes, è come ha detto una volta Ernesto Sabato l’ultimo osservatorio da cui si possa abbracciare la vita umana nel suo insieme, il silenzio imposto dal totalitarismo dell’est Europa a quest’arte, ha lasciato in questi paesi un vuoto, in letteratura e quindi anche nella osservazione permanente della vita umana nel suo insieme, che è durato 45 lunghi anni.
La luce che proietta su questi anni tutta la produzione del cosiddetto realismo socialista specialmente in paesi come l’Albania, dove la censura è stata fortissima e la voce della dissidenza violentemente smorzata, è troppo debole per non lasciare il forte desiderio di riscoprire attraverso la letteratura, nella sua concretezza e verità, la vita degli uomini durante questi 45 anni. E’ vero che la letteratura albanese di quei 45 anni che vanno dal 1945 al 1990 ha prodotto romanzieri pieni di talento (mi vengono in mente diversi come Jakov Xoxa, Nasho Jorgaqi, Kico Blushi, Ismail Kadarè, Fatos Kongoli) ma la loro voce, come dicevo, è stata deformata, la loro arte smorzata o peggio alterata dall’onnipresente censura e dalla altrettanto potente autocensura.
Ci sono stati scrittori come Ismail Kadarè che, grazie a calibratissime allegorie e ambientazioni temporalmente lontane, hanno cercato di evitare la censura, ma tutto ciò non ha mai avuto la forza di una potente letteratura che affrontasse in maniera diretta e vigorosa le tematiche della vita e dell’essere albanese di quegli anni.
La mia generazione, come quella dei nostri padri, è quindi orfana di un romanzo albanese che avrebbe potuto dire tantissimo ma non ha detto quasi niente sulle nostre giovinezze, i nostri desideri, la nostra storia. Non abbiamo pertanto avuto altra possibilità che rifletterci nel romanzo europeo classico dell’ottocento e più raramente del primo novecento (per fortuna spesso fuori dal raggio della censura) oppure nella prosa (questa sì ben filtrata dalla censura) di pochi autori occidentali europei del novecento. Per questa ragione è, secondo me, importantissima la rivisitazione di quegli anni da parte degli autori albanesi attuali, alcuni giovani e altri più affermati, attraverso opere che hanno avuto un’ottima ricezione in occidente. Mi soffermerò più a lungo su uno di questi autori, Ornela Vorpsi, e, solo più brevemente, per cogliere qualche contrasto, su Ismail Kadarè.
Ornela Vorpsi
Ornela Vorpsi scrive in italiano. Non conosco la storia personale di Vorpsi, se non per ciò che traspare dai suoi libri. Si sa che arriva nel 1991 in Italia (c’è una bellissima descrizione o forse invenzione del momento dell’arrivo in “Il paese dove non si muore mai”), studia belle arti a Milano fino al 1997 e si allontana poi per andare in Francia dove vive attualmente a Parigi.
“Il paese dove non si muore mai” esce in Italia nel 2005 seguito nel 2007 da “La mano che non mordi” e nel 2010 dal “Bevete cacao Van Houten” (mentre la cronologia delle edizioni francesi inverte gli ultimi due).
La scelta dell’italiano in Vorpsi presuppone una precedente scelta: non scrivere in albanese. Vorrei analizzare questa scelta. Non scrivere in albanese significa, in qualche maniera, rinunciare a un passato.
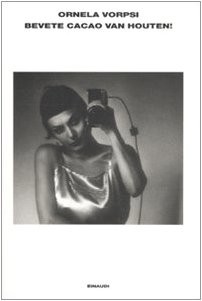
Sicuramente non a tutto il passato albanese in blocco. Se si leggono i suoi tre libri seguendo la cronologia delle edizioni francesi, si nota che i primi due trattano quasi interamente storie albanesi: il primo è incentrato sull’infanzia e adolescenza di alcuni personaggi femminili tra i quali anche la stessa Ornela e l’altro è una serie di racconti con personaggi alcuni adolescenti e altri già adulti, quasi tutti albanesi, alcuni alle prese con la loro vita nell’epoca comunista e altri con i primi anni della loro vita di emigranti all’estero.
Vorpsi quindi non rinuncia al passato albanese ma solo alla lingua. Anzi rinunciare non è la parola giusta: la rinuncia nel caso di Vorpsi bisogna intenderla più nel senso attivo di rifiutare che in quello più passivo di abbandonare. Dico questo perché mi sembra che se c’è una scelta forte per uno che scrive, quando è dato scegliere, questa è la scelta della lingua. Ritengo che gran parte della scelta si sia “imposta” insieme ai temi da trattare e che Vorpsi non avrebbe trovato la giusta distanza dalla quale parlare delle storie albanesi, se non avesse interposto il suo italiano (meticcio) tra lei e le sue storie/i suoi personaggi albanesi. La lingua in questo caso ha sottolineato la distanza che Vorpsi prende da tutto il suo (e il nostro) passato.
L’italiano diventa quindi lo strumento ottico attraverso il quale lei fa i conti con il suo doloroso passato e i suoi grotteschi personaggi. C’è una rielaborazione (conscia o inconscia non ha molta importanza) del passato attraverso la nuova lingua alla quale è chiamato ogni esiliato. Questa rielaborazione è un atto dovuto nella vita dell’esiliato, perché lui dovrà pur renderne conto, parlarne, richiamarlo alla memoria, presentare questo passato alle nuova gente che lo circonda nella sua nuova dimora e anche alla sua stessa memoria.
Nessuno di quelli che affrontano un esilio importante, cioè un esilio che sposta la persona in un’età fortemente attiva da un paese a un altro, può sfuggire a tale rielaborazione. Normalmente, dovendo dare conto a gente con una storia diversa come gli occidentali, di un passato come quello dell’est europeo che definirei “esotico” agli occhi appunto di un occidentale, questa rielaborazione del passato passa attraverso una forte semplificazione dello stesso.
Si sceglie in questa semplificazione molto spesso un registro di luoghi comuni: si sa cosa gli altri sanno di te e del tuo passato e si cerca di confortarli nel loro sapere, rafforzando gli stessi luoghi comuni. L’altra possibilità di semplificazione è quella “scandalistica” che, in prima battuta, sembra voler scuotere le credenze comuni attraverso una esagerazione a effetto delle storie raccontate. Se per esempio sto raccontando a un conoscente italiano che nel mio paese mancava un ampia gamma di prodotti alimentari che banalmente si trovavano in occidente non produco nessun effetto “scandalistico”, cosa che invece faccio se racconto che ho bevuto per la prima volta la Coca Cola quando avevo 19 anni.
La storia della Coca Cola in questo caso è vera, ma aver scelto di raccontarla non è per amore di verità (sarebbe tra l’altro una verità inutile) quanto per l’effetto scandalistico immediato che so di suscitare in un ascoltatore medio. Conosco una terza semplificazione che passa attraverso la “sentimentalizzazione” del passato. Anche in questo caso si conforta l’interlocutore giocando sulle corde del sentimentalismo che l’idea di esilio porta da sempre con sé. Quindi oltre a dover tradurre in un’altra lingua la sua storia personale o quella collettiva, un esiliato è anche chiamato prima o poi, per una questione di modus vivendi, a rendere le storie o chiamiamoli archetipi del suo passato da raccontare, come nei casi appena elencati, più digeribili alla sensibilità media (in questo caso) occidentale. Si crea così uno “story telling” parallelo al passato reale del esiliato.
Ora, mi pare ci sia uno scarto enorme tra lo story telling dell’esiliato, impostato sui luoghi comuni dei suoi interlocutori (a volte come dicevo confermante e altre scandalizzante o sentimentalizzante) e il suo passato reale, perché la rielaborazione a tesi (e in questo caso la tesi è già fissata, seppure in maniera tacita, dalla “platea” di interlocutori del nostro esiliato) è destinata a essere falsa oppure altrettanto lontana dalla verità quanto la cattiva letteratura è lontana dalla verità.
Tutto questo per dire che penso che la sfida di tutta la letteratura degli scrittori in esilio, quando scrivono del loro passato, mi sembra stia proprio nel riscoprire o meglio illuminare la realtà vissuta, senza cadere in nessuna delle trappole dello story telling che dicevo sopra. Strada molto ardua, specialmente quando, utilizzando una lingua non propria, una sensibilità media cerca di imporsi del tuo passato proprio attraverso la nuova lingua di ogni giorno. Vorpsi ci è riuscita bene, mi sembra, a eludere tutti questi pericoli. La sua prosa riscopre il passato albanese attraverso personaggi, che distillano in loro altrettante metafore esistenziali e ci fanno scoprire tutto ciò che interessa scoprire e rileggere nel nostro passato.
Forse sta proprio nel valore universale di queste metafore la forza dei racconti di Vorpsi. Senza rinunciare alla concretezza della vita albanese dell’epoca, Vorpsi introduce nei suoi racconti personaggi che sono altrettanti modi di stare nel mondo, altrettanti modi di resistere al deserto del totalitarismo, di sognare un’altra vita, di sentire con ironia e distacco e molto spesso con dolore la loro condizione o di soccombere a questa stessa condizione.
Utilizzare una lingua straniera, oltre ad essere una sfida lanciata al mondo (quella di dimostrare, cosa nel nostro caso riuscita pienamente, la bravura da scrittore) è per Vorspi prima di tutto la maniera di segnare la distanza dalla sua terra madre e dal suo tormentato passato. E’ come se facendolo parlare in un’altra lingua quel passato, Vorpsi lo facesse passare attraverso un crogiolo di purificazione oppure, se vogliamo, sotto il sole bruciante della ragione, cosa che la sua lingua, troppo legata appunto alle sue storie e ai suoi personaggi, non avrebbe permesso di fare.
E ancora è come se Vorpsi avesse avuto bisogno della distanza delle lingua, per raccontare con lucidità le sue storie, dalla posizione privilegiata di qualcuno che non solo è distante spazialmente e temporalmente da ciò che scrive, ma è distante anche all’interno dell’attimo della creazione, mentre i suoi personaggi e le sue storie prendono vita. Non che lei non abbia assolutamente bisogno dell’albanese: ma l’albanese lo utilizza come contrappunto laddove deve sottolineare una situazione esistenziale.
Per la precisione l’italiano di Vorpsi si emancipa gradualmente dal suo albanese, man mano che si passa dal primo libro “Il paese dove non si muore mai” al terzo “La mano che non mordi”.
L’emancipazione è la stessa che seguono i temi delle opere: “Il paese” è una raccolta di racconti con personaggi principali donne nell’Albania totalitarista. Da un punto di vista linguistico l’italiano cerca di rendere tutte le varie situazioni di un’epoca mai raccontata da dentro in un’altra lingua che non fosse l’albanese (e anche in quel caso, come dicevamo all’inizio, sotto la lente distorcente della censura o dell’autocensura), a volte prendendo in prestito dall’albanese molti modi di dire,a volte traducendo in italiano gli slogan dell’epoca. L’effetto è a volte comico e a volte straniante.
Come nel caso di questa presentazione, con la voce di una bambina chiamata Ornela, di una delle tante pseudofiabe in chiave fanta-ideologica, che alimentavano attraverso i libri l’immaginario dei bambini:
“Ho saputo anche che il Mar Ionio (conoscete lo Ionio, questo mare blu e trasparente che bagna l’Albania, la Grecia e una parte del sud Italia?), ecco adesso anche voi potete sapere che questo mare leggiadro e cristallino si chiama Ionio grazie a un partigiano albanese di nome Ion, il quale un giorno cadde per la patria colorando col suo sangue le acque profonde, di rosso scuro. Mi chiedo come poteva chiamarsi il mare, prima che Ion lo colorasse del suo sangue rosso. Sembra quasi che il mare non abbia avuto un nome fino al giorno in cui il partigiano albanese lo ha battezzato. Mi domando anche cosa ne pensano gli italiani e i greci, che devono chiamare il loro mare con il nome di un partigiano albanese. Anche loro magari hanno dei partigiani…ma probabilmente i loro partigiani non sono mai morti in questo mare.”
O come nel caso di questo commento amaro e ironico a uno dei tanti detti albanesi che costellano il libro. La bellezza del passaggio, secondo me, nasce proprio dall’incontro di un modo di dire intraducibile in l’italiano. E’ prima di tutto la nuova lingua che illumina di una luce ironica un detto amaro e a prima vista ermetico.
“Nel nostro caro paese dove non si muore mai, dove il corpo è forte come il piombo, abbiamo un detto, un detto profondo: “Vivi che ti odio e muori che ti piango”. Questo adagio è la linfa del nostro paese. Dopo la morte nessuna brutta parola, oserei dire nessun cattivo pensiero, ti tocca più. La morte è rispetto. (ll rispetto degli albanesi si deve meritare; cominciate a morire e lo sveglierete, una volta morti finalmente lo otterrete). All’improvviso gli uomini sono dotati di tutte le qualità, le donne di tutte le virtù. Si piange la meraviglia che eri.”
La sensibilità per il dettaglio, che certamente sfuggirà alla storiografia ufficiale dell’epoca ci fa ricordare tutto ciò che velocemente è scomparso o tende a scomparire, non solo dal paese ma anche dalla memoria collettiva: un certo tipo di pane di mais, il filo elettrico utilizzato per stendere i panni, ma in uno dei racconti anche per impiccarsi, da due donne madre e figlia sventurate, internate dal regime perché colpevoli (ma forse neanche) di una vita privata condotta non secondo i cliché della morale “socialista” ecc.
Se con il primo fa i conti con la sua dolorosa infanzia e adolescenza, con il secondo libro “Bevete cacao Van Houten”, Vorpsi illumina attraverso delle istantanee(tutti i suoi brevi racconti hanno la densità di una poesia e la brevità di una fotografia) in maniera particolare il momento di passaggio degli anni novanta dal comunismo al capitalismo. I personaggi dei primi racconti sono ancora albanesi che si affacciano gradualmente al nuovo momento storico (alcuni scappando via attraverso le ambasciate, altri che rimanendo in Albania assaporano le prime tristi libertà dell’inizio degli anni novanta).
Lo sguardo di queste “istantanee” si sposta nella seconda parte del libro sempre di più verso l’estero. I personaggi rimangono albanesi ma sono già all’estero e alle prese con i primi anni di immigrazione. C’è lo sguardo alcune volte stupefatto, altre deluso o smarrito con il quale i vari personaggi raccontano il loro incontro con l’attuale occidente (principalmente Milano, Parigi e Roma).
Ma è con il terzo libro “La mano che non mordi” che il respiro della sua prosa diventa più ampio. Come dicevo all’inizio, il suo italiano si emancipa sempre di più insieme alle sue storie, dall’albanese. Vorpsi racconta il viaggio suo da Parigi a Sarajevo per incontrare il suo amico bosniaco Mirsad. Non c’è più traccia della sua amata e odiata Albania, almeno i suoi personaggi principali non sono più albanesi.
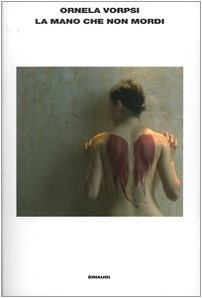
C’è un amico serbo (Dušan) conosciuto a Parigi, un amico bosniaco (appunto Mirsad) conosciuto a Milano. E c’è lei tra Parigi e Sarajevo che racconta lo spaesamento dell’emigrato e quello ancora più forte di chi torna per un attimo nella terra d’origine o meglio in una quasi terra d’origine, che non è proprio Tirana, ma assomiglia a Tirana ed è Sarajevo.
Quando racconta di come ha conosciuto l’amico serbo, spiega anche come aleggiano su di loro tutti i fantasmi della cruente storia balcanica, così fresca da adombrare immancabilmente il loro primo incontro. Ma in entrambi gli incontri sia con Mirsad che con l’amico serbo Dušan, di tutti i fantasmi della storia, quelli che gravano più minacciosi sono quelli legati alla difficoltà di vivere da stranieri (Dušan vive come Vorpsi a Parigi) oppure a una difficoltà esistenziale e basta (Mirsad ha perso “l’ovvio” del vivere e non vuole vedere nessuno, vive isolato dagli altri).
Non per puro caso mi sembra che Vorpsi getti uno sguardo obliquo e forse per questo molto illuminante sulla storia sanguinosa e tormentata dei Balcani e non è per caso che i suoi migliori amici nel libro arrivino proprio da posti off-limits per la sensibilità vetero-nazionalista albanese. Al di là di tutti gli schemi storici e ideologici, anzi in netta contrapposizione ad essi, lei e i suoi personaggi ci raccontano un’altra volta quanto siamo simili e quanto siamo vicini tra noi, quanto le nostre sofferenze siano anche le sofferenze dei nostri vicini e quanto coincida lo smarrimento che provano tutti gli emigranti (siano essi albanesi, serbi o bosniaci) di fronte all’occidente. Dicevo che nel libro non appaiono personaggi albanesi: non è proprio esatto. Qualcuno appare e la scena è degna di essere raccontata perché è una di quelle che chiudono in maniera significativa il libro.
Ornela si ferma per comprare del byrek (tipico calzone turco-balcanico) a Sarajevo. Ecco, l‘Albania ritorna alla fine del romanzo anche attraverso un oggetto/dettaglio che in questo caso è proprio il byrek e attraverso il personaggio che lo vende. Ornela ha voglia di tornare ai gusti dell’infanzia. Lo compra da un ragazzo che scopre essere albanese kosovaro. E lui appena scopre che lei è albanese e vive a Parigi le chiede subito un aiuto perché vuole andare via da Sarajevo. Insieme al byrek, il ragazzo le mette nelle mani tutta la sua vita e tutto il suo desiderio, che nutre di ingenuità, verso la terra promessa che è l’occidente.
“Dopo che ho pagato il ragazzo aggiunge: -Posso offrirti un caffè? Il caffè sarebbe un modo per parlare ancora del mio ruolo di garante. Non è tanto convinto dell’aiuto che gli posso dare, non sono convincente e neanche generosa. Rispondo di no, che purtroppo non ho tempo di prendere un caffè con lui perché altrimenti perderò l’aereo. Sento un chilo di sangue sciuparsi nel pronunciare il fatidico “no”, talmente è difficile, talmente vedo l’Albania in lui.”
E’ un no al passato quello che Vorpsi rivolge al ragazzo. Tornata a Parigi dice di abbandonarsi a un rituale (che usa dopo ogni viaggio): sentire le canzoni di Sarah Vaughan.
“Sdraiata sul pavimento, chiudo gli occhi e ascolto. E qui che il mio viaggio finisce. Nelle sue note, lontano da tutto ciò che mi è vicino”
Leggere Kadarè
Ismail Kadarè nasce in Albania il 28 gennaio 1936. E’ il più famoso scrittore albanese del dopoguerra. Tre volte candidato al Nobel, è andato via dall’Albania nel 1990 e divide da allora la sua vita tra Parigi e Tirana. Difficile fare una panoramica completa dell’opera vasta di Kadarè.
L’opera che lo rende famoso in Francia già dagli anni sessanta e, grazie alla Francia (perché tradotto proprio dal francese e non dall’albanese) più tardi anche in altri paesi occidentali, è il primo e forse il migliore dei romanzi da lui scritti “Il generale dell’armata morta”. Scrivere di Kadarè è come scrivere un po’ dei padri: non è mai facile e in questo caso diventa ancora più difficile perché la sua figura attraversa in maniera importante l’immaginario collettivo albanese della mia generazione e della generazione dei miei genitori. La ragione è semplice: se l’immaginario collettivo degli albanesi del pre-1990 è tutto illuminato, influenzato dall’occidente così vicino e così lontano, tanto agognato e mai posseduto, l’unica figura intellettuale che nei tre decenni che vanno dal 1960 al 1990 costituisce un ponte concreto verso e dall’occidente europeo, perché riconosciuto (famoso) anche in occidente è proprio lui: Kadarè.
Pur avendolo studiato a scuola e avendo riconosciuto la sua bravura come scrittore, l’importanza dell’eco della sua opera dentro e fuori dall’Albania aveva per la mia generazione sovrastato da tempo l’importanza letteraria della sua opera. Ne poteva del resto essere altrimenti in un paese la cui avidità di conoscere ed essere conosciuto dall’occidente europeo era pari solo al suo enorme isolamento. Aveva questo senso anche la famosa lettura tra le righe che si praticava un po’ a livello nazionale all’opera di Kadarè: trovare tutti gli echi della sua occidentalità nella sua opera (ciò che del resto rimaneva terreno proibito agli altri scrittori – ricordo di aver letto un articolo di Driterò Agolli, a lungo presidente della lega degli scrittori albanesi dove, non si capiva bene se scaturita dall’invidia oppure semplicemente da un granitico credo politico, si sottolineava la non appartenenza di ampi passaggi dell’opera di Kadarè al “realismo socialista”).
Leggere Kadarè aveva quindi quel gusto del proibito che aveva guardare film che non dovevi vedere nelle televisioni occidentali oppure leggere libri proibiti, con l’eccitante dell’albanese utilizzato come lingua e del miracolo dell’accettazione dei suoi libri dalla allora nomenclatura politica. Perché bisogna sottolineare che appunto perché sentivamo per così dire il profumo dell’occidente nelle sue opere, ci chiedevamo anche sempre (forse allora senza mai formulare in maniera conscia) come fosse possibile e per quanto sarebbe potuto durare questo miracolo. Insomma per quelli della mia generazione Kadarè era un avamposto dell’occidente nella chiusa e rigida Albania, un avamposto che per di più parlava albanese e raccontava belle storie.
Non poteva però sfuggire a nessuno di noi che Kadarè dedicava un po’ troppa fatica a turchi e medioevo (c’è tutto un filone di romanzi di Kadarè che parla di storie vecchie legate alla resistenza albanese agli ottomani e altro). E tra di noi avevamo anche la risposta al perché di una tale scelta: era l’unica maniera per sfuggire ad un confronto diretto con il regime.
C’è chi studiando l’opera di Kadarè non si stanca di ripetere che bisogna leggere anche questi romanzi tra le righe, a un livello di lettura che era l’unico che poteva sfuggire alla censura e che era utilizzato da Kadarè per comunicare con i più scaltri dei suoi lettori. Personalmente mi stanco alla sola idea di leggere tra le righe e anche in genere di leggere tutta un’opera come se fosse una grande allegoria, cercando i significati nascosti, il non detto ma solo alluso. Ritengo che Kadarè abbia dato il meglio di sé proprio quando ancorava i suoi personaggi al presente e studiava i rapporti tra di loro senza intenzioni allegoriche – ciò che, secondo me, fa ogni buon romanzo.
Ricordo l’avidità con la quale ho letto opere come “Il Grande Inverno” o come “Il Sangue Freddo” assaporando proprio tutto ciò che era meno politico e più privato nei rapporti tra i personaggi, perché mi sembrava che fosse l’unico sguardo moderno e scevro da censura sul privato dell’uomo albanese che la letteratura degli anni settanta e ottanta potesse offrire. Devo sottolineare che la mia lettura di Kadarè e la contrapposizione a Vorpsi non ha nessuna pretesa di completezza o scientificità letteraria. E’ solo una lettura del rapporto dei due scrittori con i loro lettori albanesi come io sono, con l’immancabile premessa, nel mio caso, che lo sguardo su questi due scrittori è dall’esterno dell’Albania e non dall’interno. Come tale, questo sguardo non può non passare attraverso il rapporto che questi scrittori hanno con la lingua e con la memoria.
Nel caso di Kadarè, la sua fama all’estero l’aveva già ampiamente preceduto prima che lui si spostasse definitivamente in Francia. Come dicevamo, si sposta in Francia nel 1990 ma aveva pubblicato il suo “Il generale dell’armata morta” nel 1963. Questo è forse il motivo principale per il quale il suo rapporto con la lingua straniera non mi sembra sia centrale nella sua poetica. Secondo me, per lo stesso motivo i suoi temi rimangono albanesi anche dopo la sua emigrazione in Francia. In qualche maniera, si può dire che Kadarè avesse già raggiunto l’apice della sua carriera romanzesca prima del 1990, cioè prima di spostarsi in Francia.
I libri scritti dopo sono una rivisitazione delle tematiche albanesi senza più nessuna censura. Leggendo l’allora non detto e adesso sottolineato nei nuovi libri di Kadarè, si ha la strana sensazione di leggere i suoi vecchi libri che hanno subito nel frattempo un intervento di chirurgia plastica di aggiunta delle parti che all’epoca erano state autocensurate dallo scrittore. E’ per questo motivo che i romanzi scritti da lui dopo il 1990, quindi senza censure, mi sembra non aggiungano niente di nuovo alla già consolidata estetica pre-novanta.
E né mi sembra che lui stesso si facesse illusioni sulle possibilità che gli avrebbe assicurato la nuova libertà di parola guadagnata nel 1990. La cifra della sua poetica di romanziere era già fissata, la sua per così dire musica era già stata espressa e forse anche rafforzata dalla censura. Questo, secondo me, anche perché tutta l’arte sofisticata del dribbling della censura si era integrata perfettamente alla sua cifra stilistica pre-novanta. Leggere i suoi romanzi post-novanta ha quindi adesso solo il sapore un po’ fuori moda delle parabole morali, nelle quali c’è una spiegazione dei passaggi che una volta erano misteriosi e dove i cattivi e i buoni sono finalmente indicati come tali senza possibilità di errore e senza mistero. Non voglio togliere in questa maniera neanche una virgola al successo che in Albania e fuori di essa l’arte di Kadarè ha riscosso.
Mi sembra soltanto che lui differisca da Vorpsi in due punti sostanziali: 1) le sue opere post-novanta non mi sembrano la rivisitazione più tagliente e priva di illusioni che si possa fare dell’epoca comunista, perché la sua estetica, al contrario di Vorpsi, non si cimenta per la prima volta con quel periodo e non ha armi nuove per affrontarlo; 2) se con Vorpsi già con il secondo, e in maniera più decisa con il terzo libro, le tematiche si spostano sempre di più nella direzione della vita dello straniero in occidente, preparando, speriamo, nuove prospettive per i prossimi libri, Kadarè mi sembra evidenzi sempre di più, con i nuovi libri e i nuovi saggi la sua intenzione di ribadire il rapporto dell’arte con la politica e con la dittatura. Forte della sua esperienza di scrittore, certe volte coccolato e altre minacciato dall’ex regime comunista, la sua riflessione romanzesca e saggistica mi sembra verta sempre di più intorno ai temi del potere e delle influenze reciproche tra potere e arte. Mi sembra che, al contrario, gli interessi poco analizzare con la sua arte il rapporto dello straniero con l’occidente.
L’altra fondamentale riflessione di Kadarè, quella che tende a dimostrare attraverso esempi storici concreti nonché riflessioni storiche e politiche di ampio respiro, la decisa appartenenza dell’Albania all’Europa moderna occidentale, non solo per ragioni geografiche ma anche per ragioni culturali, linguistiche e storiche, questa riflessione dicevo, potenziata dalla sua voce autoritaria di intellettuale, rimane una delle sue costanti. Che questa riflessione saggistica e intellettuale abbia in qualche maniera sacrificato oppure soffocato l’arte romanzesca di Kadarè, cioè l’ultima arte capace di abbracciare la vita umana nel suo insieme, mi sembra un’altra verità, che però ha bisogno di altre sedi per essere analizzata.
Ottobre 2010





