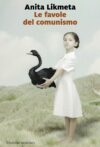Ekland Hasa nasce a Tirana, dove frequenta il Liceo artistico “Jordan Misja” e l’Accademia di Belle Arti. Consegue diverse specializzazioni in Italia e in Germania e tra i suoi maestri si possono annoverare nomi come quelli di Nihal Hakiu, Pranvera Çaushi Xhorxhi, Anita Tartarie e Ludwig Hoffman.
Artista pluripremiato, solista pianista presso Il Teatro dell’Opera e del Balletto di Tirana, decide di lasciare l’Albania nel periodo post regime, trasferendosi in Sud Italia. Qui la sua vita di musicista ha risvolti diversi, ma ugualmente gratificanti: dal 1995 in poi suona come solista e accompagnatore di cantanti lirici presso il Teatro Verdi di Marghera, il Teatro Politeama Greco, La Fenice, il Tito Schipa, il Paisiello, il Mascagni e tanti altri.
Dal 2000 diventa Direttore Artistico dell’ Accademia Lirico – Pop “Albano Carrisi”, intraprendendo un tour come pianista che lo porta in USA, Canada, Mosca, Uzbekistan, Bulgaria, Romania, Spagna, Francia, Malta, Germania, Olanda, Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia e ancora in giro per il mondo. Nel 2007 diventa cittadino d’onore della città di Nardò.
Ha lavorato per le case discografiche Albano Carrisi production e 11/8 records. È direttore musicale del Teatro Pietro Mascagni di Nardò e ha partecipato come Maestro collaboratore nel disco “Carrisi canta Caruso“. Ha suonato sotto la direzione di Hikmet Shimshek, David Andre, Ermir Krantja, Julius Bertoldi, Vito Clemente e altri nomi rilevanti. Ha collaborato con Inva Mula, Monserat Cabbaie, Leonardo Gramegna, Eva Golemi, Mariana Leka, Emanuela Di Pietro (direttrice del Coro Lirico di Lecce), Armaldo Kllogjeri e con diversi artisti in vari generi musicali. Nel 2009 è stato protagonista del film documentario Le note di Ekland di Antonio D’Aprile.
Ekland Hasa è tra i protagonisti del docu film di Esmeralda Calabria Parlate a bassa voce, incentrato sull’evoluzione storicosociale dell’Albania. Ekland, molto gentilmente, risponde a qualche mia domanda.

In Parlate a bassa voce, durante il primo lungo dialogo con Redi Hasa, lei fa un’affermazione, in riferimento al periodo che ha visto l’Albania sotto il totalitarismo, che ha destato qualche polemica: “Eravamo poveri, ma felici”. Cosa vuol dire esattamente?
Innanzitutto, è fondamentale fare delle nette distinzioni tra chi, durante il regime, ha vissuto molto male, chi ha vissuto normalmente e chi ha vissuto bene. Purtroppo ci sono state persone che hanno subito la dittatura nella maniera più crudele; questo per specificare che non sto parteggiando per Enver Hoxha. Dico solo che non tutte le cose che ha fatto sono state negative, come è altrettanto vero che quanto ha fatto di brutto è stato realmente fatale.
Io ho vissuto l’epoca del regime, proprio come quella del post regime, della democrazia fittizia e indubbiamente, entrambi i momenti storici sono stati caratterizzati da lati positivi e da quelli negativi. Anche io ho subito, in qualche modo, le restrizioni applicate in quel periodo, per come volevo far conoscere la musica, tanto da essere preso di mira, in quanto considerato un rivoluzionario.
Per esempio, ho portato sul palco un concerto di canzoni americane, che si è rivelato un grande successo, perché dal punto di vista musicale vi era grande arretratezza: si conosceva il jazz, così come i classici, ma l’impressionismo si sfiorava appena, in quanto considerato troppo progressista. Basti pensare all’XI Festival della canzone albanese, per cui hanno pagato tantissime persone, perché le musiche proposte furono considerate troppo occidentali. La vera rivoluzione si è avuta con la caduta definitiva del regime, anche se già con Ramiz Alia (il successore di Hoxha) al potere, la situazione si era molto alleggerita.
Perché ho pronunciato quella frase? Noi eravamo felici perché ci accontentavamo di poco, non eravamo schiacciati dallo stress che oggi si ritrova a Tirana e questo è un esempio su tutti. Non dimenticherò mai quando mi sono ritrovato, improvvisamente, nel bel mezzo di una sparatoria tra due ragazzini e mi sono salvato per un pelo. Ai tempi di Hoxha ciò non succedeva. Detto questo, non nego che abbia compiuto stragi ingiustificabili, come far ammazzare il direttore del Festival perché aveva falsificato i biglietti della ferrovia, racimolando circa 400 euro. Come si fa a far fucilare un uomo per pochi spiccioli?

Succedevano cose turpi, ma accadeva anche che una donna potesse camminare senza che nessuno la importunasse sia di giorno che di notte. Eravamo molto giovani, ci mancava tutto, anche se la reale povertà l’abbiamo più avvertita durante il governo successivo, che ha preso la decisione di interrompere i rapporti sia con la Russia che con la Cina, decidendo che l’Albania dovesse sostenersi da sola. In realtà, il Paese non aveva capacità alcuna di auto supportarsi. Direi che a partire da questo momento è iniziato il vero tracollo economico.
Alla base del regime comunista c’era un’ideologia tutto sommato corretta, sviluppata poi male. Noi per Hoxha eravamo tutti uguali, tanto che io, per esempio, quando ero piccolo suonavo ai matrimoni con chiunque capitasse. Per me non c’erano differenze.
Quello che nel tempo è venuto a mancare, motivo per cui dico “eravamo poveri, ma felici”, è la genuinità nell’apprezzare le piccole cose. Ogni estate, i miei genitori prendevano al mare, a Durazzo, una cabina di legno. Era poco, non c’era nulla dentro, ma eravamo felici di quel poco. Ci piaceva tantissimo trascorrere l’estate in quel modo. Ora le cose sono cambiate: c’è tanto stress e lo vedo nei miei amici che ho lasciato in Albania. La mia frase voleva essere un’espressione personale, più che collettiva.
Quando decide di lasciare l’Albania?
Mi sono laureato nell’89 a Tirana e sono stato nominato maestro sostituto del Teatro dell’Opera di Tirana, per poi diventare primo solista, grazie a un’occasione capitata improvvisamente, che permise alla mia preparazione e alla mia creatività di emergere. Svolgevo, quindi, due lavori, sia come primo solista in teatro, che come musicista durante le ore serali in un noto hotel tiranese; stavo bene. Nonostante questo, però, si rese necessario mettere sulla bilancia i lati positivi e quelli negativi: non esisteva l’uguaglianza tanto paventata, anche se c’era una cultura di base per tutti. Hoxha combatteva l’analfabetismo, ti costringeva a studiare, praticando un acculturamento di massa.

Presumo fosse un’istruzione pilotata…
Il regime aveva introdotto materie inutili. Ricordo il mio percorso di studi, in cui, accanto alle discipline inerenti la musica, vi erano altre come la storia del partito o quella del comunismo, oppure quella del marxismo e del leninismo. Si studiava anche filosofia, filologia, ma tra le materie principali ve ne erano alcune di grande inutilità, come inutile era la decisione di fermarsi all’impressionismo. Per esempio, la cultura con firma russa si studiò fino a quando non ci fu il distacco dalla Russia. Lo stesso Sergej Vasil’evič Rachmaninov non venne più preso in considerazione, in quanto emigrato in America. Vi furono gravissimi errori.
Quando ha lasciato l’Albania?
Sono partito per l’Italia insieme ad un gruppo di artisti con permessi regolari. Era il 15 novembre 1991, il giorno del mio compleanno. Non ho avuto paura, ansia sì, agitazione sì, timore no. Con me c’erano splendidi compagni di viaggio, come Kledi Kadiu, Ilir Shaqiri, Gaqo Cako e altri colleghi artisti.
Siamo arrivati in Puglia, abbiamo fatto qualche concerto, poi ognuno di noi ha preso la sua strada. il distacco è stato molto doloroso. Io sono rimasto a Nardò, in quanto si è aperta una strada, grazie alle persone che mi hanno dato una mano. Ho avuto l’opportunità di conoscere Albano, con lui ho lavorato tantissimo. Meno male, perché quando sono arrivato (ero con la mia fidanzata, che poi è diventata mia moglie), avevo diecimila lire in tasca. Ricordo di aver dormito quattro giorni fuori, alla villa comunale. I primi mesi, direi i primi quattro o cinque mesi, sono stati molto pesanti.
Negli ultimi anni si tenta, in maniera spesso fruttuosa, di far conoscere l’Albania attraverso la cultura. Succede anche tramite la musica?
Intorno alla metà degli anni Novanta conobbi, in Salento, un personaggio fantastico, piuttosto controverso, ma un grandissimo musicista: Cesare Dell’Anna. Un incontro che ha segnato la mia vita, di uomo e di musicista. Cesare viveva in una casa in campagna, che lui chiamava Hotel Albania, dove invitava tanti musicisti balcanici. Ricordo di essere rimasto davvero stupefatto di quanto la musica balcanica colpisse i salentini.
Questa è stata una fase davvero molto importante della mia esistenza, che ha rappresentato un cambiamento memorabile, da quando suonavamo di nascosto, alla massima libera espressione della nostra musica. Si era ribaltato tutto! Grazie a Cesare abbiamo condiviso la nostra arte, abbinandola alle musiche e i balli locali e lo stesso si è fatto con il cibo, perché è cultura anche quello o con la musica classica, come quella di Puccini, che si è mescolata alla balcanica. Una meravigliosa espressione artistica a 360 gradi.