Gazmend Kapllani nasce nel 1967 a Lushnje, Albania. Immigrato in Grecia dal 1991, oggi è uno degli scrittori albanesi più prolifici e apprezzati. Come ogni altro migrante, anche Kapllani si è trovato ad affrontare le difficoltà di chi lascia la propria terra.
Caparbio e determinato, non si è mai lasciato abbattere dalle difficoltà che la vita ha posto sul suo cammino. Curioso e con una gran voglia di conoscenza, è riuscito a dare il proprio corposo contributo in una realtà difficile come quella ellenica.
Laureatosi all’Università di Atene, dove ha insegnato cultura moderna albanese, è stato l’unico giornalista proveniente dall’Albania a pubblicare su “Ta Nea”, una delle testate greche più conosciute. Kapllani ha vissuto a Boston dal 2012 al 2019, dove è stato docente presso l’Emerson College. Successivamente si è trasferito a Chicago, dove ancora vive e dirige il Programma degli Studi Albanesi all’Università De Paul.
Nell’intervista che ci ha gentilmente concesso, racconta del suo ultimo libro La terra sbagliata e sottolinea la sua visone relativa ad alcune fondamentali e delicate tematiche. Buona lettura.
Il tuo cuore di migrante è carico di coraggio, speranza e tenacia, ma è anche appesantito. Nel libro Breve diario di frontiera spieghi molto bene tutte le paure che l’animo porta con sé. Ti chiedo se oggi, il tuo rapporto con i confini e il tuo spirito di immigrato hanno trovato pace.
Il cuore del migrante è uguale a quello di chiunque: è pesante, è gioioso, è leggero o triste, è pieno di contraddizioni, esattamente come ogni altro, che appartenga o meno a un immigrato. Esistono, però, alcune caratteristiche psicologiche del migrante, che vengono plasmate dalla necessità di ricominciare la vita da ground zero, sotto un altro cielo, che spesso può essere (o quanto meno sembrare) poco accogliente e in alcuni casi, ostile.
Ogni nuovo inizio, specialmente quando ha a che fare con l’essenza dell’identità e della sopravvivenza, richiede un diverso orientamento dell’Io. Max Weber afferma che gli esseri umani non possono vivere senza una narrativa interna o privi di una mappa mentale e spirituale, definita “senso della vita.”
L’immigrato, quindi, è chiamato a ricostruire il proprio “senso della vita”, spesso in un’altra lingua e in un nuovo contesto culturale. In ogni caso, si diventa migranti non per paura, bensì per il coraggio che si ha nel riporre la speranza in una vita migliore.
Per quanto riguarda la pace, posso dire che sia io, che altri albanesi o cittadini appartenenti all’Est Europa, abbiamo varcato le frontiere non per cercare la pace stessa, ma la libertà e sono certo che l’abbiamo incontrata in tanti.
Il viaggio difficile e doloroso che abbiamo intrapreso ha permesso a ognuno di noi di comprendere la differenza tra la libertà e la non libertà, tra la tirannia e la democrazia. Una delle intenzioni più lugubri del totalitarismo è quella di distruggere la capacità cognitiva dell’essere umano, che non riesce più a distinguere la libertà dall’oppressione, il bene dal male, la bugia dalla verità.
La scrittura è un ottimo strumento di conoscenza, che consente di fare pace con se stessi e di liberarci dai nostri fantasmi.
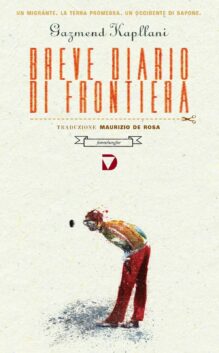
In un’intervista di qualche tempo fa, hai dichiarato che la scrittura, per te, è un atto di resistenza. Cosa significa esattamente?
Non penso di aver detto qualcosa di originale. Nella scrittura c’è sempre un elemento di resistenza. Quando si vivono situazioni politiche e sociali estreme (come il totalitarismo, oppure una collettività razzista) la letteratura si trasforma in un ottimo strumento per combattere l’oblio e l’ignoranza. Diventa un modo per ribadire, soprattutto, la necessità di rispettare la dignità individuale.
Basti pensare a quello che diceva Albert Camus attraverso le parole del dottor Rieux ne La Peste: confrontandosi con la peste, tutto diventa più prezioso, anche le piccole cose e a guadagnarci sono la Memoria e la Conoscenza. Ritengo tale pensiero un’ottima metafora con la quale identificare il ruolo della scrittura.
Hai scelto di scrivere in greco, quindi in una lingua differente da quella madre: da quando sei in America, scrivi nuovamente in albanese. Il translinguismo è una scelta dettata da una sfida o rispecchia la tua condizione di immigrato?
Entrambe le cose. Esistono tanti scrittori e scrittrici che scrivono in una lingua che non è quella madre. Alcuni di essi, come Joseph Conrad e Vladimir Nabokov, sono figure iconiche della storia della letteratura.
Chiaramente la mia non è una scelta dettata dal pensiero verso gli altri, ma nei confronti di me stesso. Nessuno ha mai compreso questo in Grecia. Mi sono sempre sentito dire: “Ci fa tanto piacere che tu abbia scelto di scrivere in greco”. Ritengo di essere stato sempre sincero nella risposta: “Io non l’ho fatto per voi, l’ho fatto per me”. Queste parole non sono mai piaciute, tanto da risultare noiose; al contempo, hanno infastidito anche le misere persone albanesi, che ancora oggi si ritrovano un bunker al posto del cervello.
Mi ritengo fortunato per aver avuto il coraggio, la curiosità e la possibilità di scrivere in altre lingue (ci vuole coraggio!) senza mai abbandonare l’albanese.
Ora vivo in America e scrivo in inglese e chissà, forse un giorno scriverò anche in italiano. Scrivere utilizzando idiomi differenti consente un forte arricchimento dell’immaginazione, perché ognuno di essi gioca in maniera diversa con la fantasia.
È indubbiamente necessario costruire una forte e profonda relazione con l’altra lingua, con la consapevolezza che non si diventa scrittori migliori perché si utilizza un lessico differente. Per essere un bravo autore devi far crescere e curare quello che hai dentro di te, che va ben oltre la lingua.
Spesso si afferma che l’immigrato non ritrovi mai la sua identità, che si senta sempre ospite del Paese che lo ha accolto e altrettanto quando torna nella sua terra natia. Sei d’accordo?
Io vedo l’immigrazione come uno degli elementi fondamentali dell’avventura umana sulla terra. Non si può pensare all’Europa senza il fenomeno migratorio, per non parlare dell’America o dell’Australia. Effettivamente, le transizioni umane più sconvolgenti della storia moderna vedono protagonisti gli europei: 55milioni di persone provenienti dall’Europa, (tra loro moltissimi Italiani) sono approdate in America nel periodo che intercorre tra il 1840 e il 1940. Ricordiamo anche le ondate di migranti e rifugiati di guerra del XX secolo.
Mi stupisce e allo stesso tempo mi affascina che in Europa ci sia il grande problema del “non ricordo” legato all’immigrazione. In un continente come il nostro, fatto da migranti, esistono pochissimi musei dedicati e aperti solo negli ultimi anni.
Nulla è citato nei testi scolastici: questo è grave se si pensa che per noi, cittadini della cosiddetta “Altra Europa” (Est e Sud-Est Europa), l’immigrazione costituisce una delle caratteristiche fondamentali della nostra identità moderna.
In Occidente i transiti migratori vengono vissuti come l’invasione da parte di altri; noi, invece, dell’Est Europa e dei Balcani, vediamo l’emorragia migratoria della nostra gente verso Ovest, come una minaccia enorme per l’identità e l’esistenza della comunità nazionale. Quanto sta accadendo in Ucraina ne è un limpido esempio: una popolazione intera potrebbe avere la necessità di rifugiarsi lontano dalla propria terra, a causa della paranoica volontà russa di praticare un genocidio.
Questo è il motivo per cui, nella nostra tradizione popolare e intellettuale, l’immigrazione viene costantemente illuminata da una luce malinconica, quasi fosse una sciagura e un disastro. Per di più, durante la Guerra Fredda, in alcuni Paesi, specialmente in Albania, sofferente a causa di un isolamento assurdo durato mezzo secolo, gli stati totalitari comunisti hanno coltivato una enorme ostilità contro la figura dell’esule e dell’ immigrato. In Unione Sovietica, si punivano i dissidenti mandandoli nei gulag, oppure deportandoli all’estero.
In ogni caso, l’ironia tragica dell’isolamento è che gli albanesi hanno vissuto coesistendo sempre con altre culture, almeno dall’epoca medievale in poi. Le tracce della nostra presenza si trovano da Istanbul a Buenos Aires, da Atene a Chicago e da Odessa a Mexico City.
La disgregazione provocata dal comunismo è arrivata dopo, portando l’emarginazione totale, la crepa con il mondo e altre culture. L’obiettivo della nomenclatura comunista era quello di trasformare l’Albania in una sorta di giardino zoologico senza visitatori.
Dopo la caduta del regime – e da questo punto di vista la mia generazione può ritenersi molto fortunata per essersi liberata da quella mostruosa tirannia – si è verificata una vera e propria esplosione dell’immigrazione albanese verso l’Occidente, indubbiamente connessa con quella degli est-europei verso Ovest, dopo la caduta del Muro di Berlino.
Penso che questa sia stata la versione europea della Great Migration Americana (l’immigrazione che ha coinvolto milioni di Afro Americani che dal Sud si sono riversati nel Nord Est statunitense dal 1910 al 1970).
L’immigrazione massiccia albanese, di cui tanto si è parlato e sulla quale si continua a confrontarsi, va considerata come un’azione da contestualizzare nello sforzo enorme e disperato di un popolo di rimettere ordine e ritrovare il proprio orientamento nel mondo. Per fare un semplice paragone, quello albanese è simile al disagio in cui si ritrova una persona alla quale, dopo cinquant’anni di prigione, si dice che è libera di andare e di fare quello che vuole.
Per di più gli immigrati albanesi ed altri dell’Est Europa hanno incontrato spesso l’ostilità e il disprezzo dell’Occidente, specialmente nei primi anni, cosa che ha creato ulteriori difficoltà sociali e individuali. Viaggiare nel mondo come migrante, con una identità stigmatizzata, è come attraversare l’Atlantico su una vecchia barca che ingoia acqua.
Per concludere, aggiungo che è questo il profilo del fenomeno migratorio del quale scrivo. Ritengo che i contesti storici, culturali e sociali siano molto importanti per comprendere l’immigrato come individuo, un concetto valido per ogni epoca.
Per esempio, lo Stato albanese post-comunista ha ereditato molte caratteristiche di quello che lo ha preceduto e ancora oggi guarda con una certa ostilità chi emigra. Non è un caso che non riconosca ai migranti il diritto di voto e che essi siano tra le prime vittime della violenza massiccia proprietaria (molte volte rubano loro le proprietà o le case che costruiscono in Albania).
Con il tuo ultimo libro La terra sbagliata consegni al lettore un disegno cristallino della complicata realtà di chi lascia la propria terra, con la quale si ritrova, prima o poi, alla resa dei conti. Confine, immigrazione, identità e famiglia corrono parallelamente nel volume, intersecandosi, a volte, brutalmente. Ti chiedo, innanzitutto, perché nasce questo testo e se le vicende di Karl e Frederick vogliono essere la riproduzione speculare della storia dell’Albania.
Innanzitutto, la scrittura costituisce per me un tentativo di viaggiare in quello che Italo Calvino chiamava il “mondo non scritto”, dandogli parola tramite l’immaginazione. La terra sbagliata non è un libro che vuole narrare la Storia dell’Albania, perché in fin dei conti, la Storia si interessa soprattutto ai fatti, alla letteratura e alle emozioni umane.
Credo che possa essere sia un libro a immagine speculare della realtà di un Paese, ma anche di una dimensione universale, perché le esperienze umane nella buona letteratura assumono sempre fattezze globali. Sono affascinato dal dramma umano, che vive tra la necessità di conservare le radici e la voglia di libertà, generando una sofferenza totale e diacronica.
Penso che dal punto di vista filosofico, La terra sbagliata sia anche una meditazione sulla libertà e le scelte morali che quotidianamente facciamo; proprio come scrive Tony Morrison, una cosa è essere liberati e un’altra cosa è prendersi carico della nostra libertà.
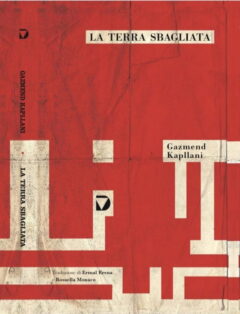
Pensi che un giorno possa esserci un mondo privo di immigrazione o privato dei suoi confini? Infondo, le frontiere sono linee di demarcazione disegnate dall’uomo…
Tutta la nostra vita è una cartografia di frontiere, visibili e invisibili. I confini mutano in continuazione con le nostre idee e le concezioni che costruiamo su noi stessi, sullo spazio e sugli altri. A ogni modo, a me piacciono gli uomini e le donne che sanno varcare le frontiere con grazia, determinazione e onestà. Penso che si possa meglio comprendere il mondo, quello vero, guardandolo non dal centro, ma dai suoi margini.
Due parole sulla condizione dell’Albania oggi e sul suo futuro, secondo te.
L’Albania post-comunista di oggi è un Paese che si è liberato dal lugubre regime dittatoriale, ma non ha potuto ancora prendersi carico della libertà ritrovata. Intendo dire che non riesce ancora a trattare responsabilmente la libertà, interiorizzandola come il proprio modo di pensare e di agire.
Per poter realizzare questo ci vuole molto coraggio, considerato il passato oscuro e la giustizia traballante, che caratterizza il presente e rischia di contraddistinguere il futuro.
Manos Xatzidakis, un compositore greco che mi piace moltissimo, diceva in merito alla Grecia, che il Paese va avanti grazie alle eccezioni. Direi la stessa cosa anche per l’Albania. Mi auguro, pertanto, di vedere sempre più eccezioni che spingano avanti il Paese mio che sta sulla collina…





