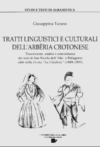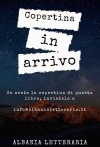Giuseppina Turano è professoressa associata di Lingua e letteratura albanese presso l’Università Ca’Foscari Venezia. In precedenza, ha insegnato all’Università della Calabria (1997-2002), all’Università di Bari (2000-2002) e all’Università di Firenze (2000-2008).
È stata visiting professor all’Università di Scutari, di Tirana e di Prishtina. Ha partecipato a diversi progetti PRIN (Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale) banditi dal Ministero dell’Università e della Ricerca. È socia dell’Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo (A.I.S.S.E.E.). È co-direttrice della rivista Balcani et Slavia – Studi linguistici, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, oltre a far parte del comitato redazionale di diverse riviste. È referente scientifica di diversi progetti Erasmus. Buona lettura.
Professoressa, lei si occupa di letteratura albanese e dialettologia arbëreshe. Quando è iniziato e com’è stato il suo percorso formativo?
Insegno la lingua, la letteratura e la cultura albanese ma, in realtà, per la mia ricerca, mi occupo di linguistica e più esattamente di sintassi della lingua albanese e dei suoi dialetti, compresi i dialetti arbëreshë.
L’interesse per la lingua, la letteratura e la cultura albanese e, per l’Albania in generale, prende impulso dalla mia origine arbëreshe. Il gruppo etnico arbëresh ha una storia che comincia nel XV° secolo e termina nel XVIII°. Partiti dall’Albania alla metà del Quattrocento, gli albanesi, avventurandosi lungo la via del mare, sono giunti nell’Italia meridionale, nei territori dell’allora Regno di Napoli. E qui tuttora vivono. L’etnia arbëreshe è presente nel territorio italiano da un arco di tempo che oramai abbraccia più di cinque secoli ed è distribuita tra sette regioni del centro meridione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Ad oggi conta circa una cinquantina di comunità. Io sono nata in una di queste comunità, S. Nicola dell’Alto, in provincia di Crotone. Siamo dunque nella Calabria mediana.
Il mio percorso formativo inizia all’Università degli Studi di Firenze dove, come studentessa iscritta alla Facoltà di Lingue e letterature straniere, mi ritrovai a frequentare le lezioni di Linguistica, tenute dal professor Leonardo Maria Savoia. Il modulo da lui tenuto introduceva ad un modello teorico che, seguendo le linee guida del suo fondatore, il linguista americano Noam Chomsky, era ed è ancora noto come Teoria dei Principi e dei Parametri e si muove nell’ambito della cosiddetta Grammatica generativa, un modello che, grazie alla sua ricca articolazione interna, è in grado di spiegare le proprietà della sintassi delle lingue naturali, è in grado di descrivere i fatti e di spiegare le differenze empiriche riscontrabili tra le lingue umane. Il modello teorico della Grammatica generativa ha segnato, fin dai suoi esordi negli anni ’50, un cambio di approccio allo studio delle lingue naturali.
Conoscitore delle parlate italo-albanesi, per aver insegnato all’Università della Calabria, il professor Savoia mi invitò ad esplorare un dominio empirico poco indagato quale quello della sintassi arbëreshe utilizzando come modello teorico proprio quello della grammatica generativa. Un compito arduo data la quasi totale mancanza di studi e ricerche sul dominio linguistico in questione. Ancora oggi, infatti, gli studi sulla sintassi dei dialetti italo-albanesi non sono molto esaurienti e lasciano tuttora aperto il campo alla ricerca. Certo non mancano studi su queste parlate. I dialetti italo-albanesi hanno suscitato un grande interesse sia tra gli esperti di dialettologia sia tra gli specialisti di linguistica e di linguistica del contatto. Già a partire dalla fine dell’Ottocento e ancor più alla metà del Novecento, studiosi di diversa provenienza e formazione (accademici di lingua tedesca, intellettuali e studiosi italo-albanesi, linguisti e dialettologi albanesi, studiosi italiani e americani) si sono accostati allo studio di questi dialetti offrendo descrizioni parziali o totali di differenti aspetti della loro grammatica anche se non tutte le aree geografiche e tutti i campi della grammatica risultano esplorati a fondo. Le descrizioni dialettologiche di cui disponiamo sono quasi sempre studi di carattere fonetico-fonologico o morfo- lessicale mentre pochi sono gli studi di carattere sintattico.
Dunque, fu il professor Savoia ad iniziarmi al contempo alla grammatica generativa e allo studio della sintassi arbëreshe. Sotto la sua guida, ho preparato e discusso la mia tesi di laurea avente per oggetto lo studio delle strutture causative dell’arbëresh, in chiave comparativa con quelle dell’italiano. Si trattava di una tesi unica nel suo genere, poiché applicava per la prima volta i metodi della Grammatica generativa ad una varietà arbëreshe mai studiata prima di allora. Quel lavoro ha dato l’avvio ad una serie di ricerche sulle corrispondenti strutture causative in altre lingue e in altri dialetti. Per me si trattava di applicare il modello della grammatica generativa alle mie competenze linguistiche giacché avrei utilizzato come dati empirici quelli della mia parlata natia.
Quel momento di ricerca, iniziato con la tesi di laurea, ha avuto una sua naturale continuazione nel Dottorato di Ricerca in Albanologia, unico in Italia, organizzato dall’Università degli Studi della Calabria congiuntamente con l’Università degli Studi di Palermo. Un’occasione particolare non solo per la ricerca individuale ma anche e soprattutto per la ricchezza delle iniziative offerte da queste due istituzioni. Grazie all’instancabile attività dei professori Francesco Altimari, Matteo Mandalà e del compianto professor Antonino Guzzetta, l’Università della Calabria e quella di Palermo sono state promotrici di numerose iniziative scientifiche e culturali: lezioni, seminari, convegni, congressi, momenti di incontro che, oltre a stimolare dibattiti, sono stati occasione per riflettere con altri studiosi di lingua e linguistica e per divulgare i risultati delle ricerche condotte da validi studiosi del mondo arbëresh.
Continuando, sull’asse cronologico, va ancora all’Università della Calabria il merito di aver organizzato un viaggio di studio, nell’agosto del 1990, a Tirana dove ho potuto partecipare al corso estivo di lingua albanese riservato a studenti stranieri. Quello è stato il mio primo contatto con l’Albania d’oltre Adriatico. Chiusa ancora nella morsa della dittatura, perché alla morte del dittatore Hoxha, la carica di Primo Segretario del Partito del Lavoro d’Albania era passata al suo braccio destro Ramiz Alia, l’Albania si presentava come un paese fuori dal tempo: l’intero territorio bunkerizzato, un’economia bloccata dalla statalizzazione, nessuna infrastruttura, dovunque militari armati a controllare la popolazione, un paese arretrato sulle cui strade transitavano uomini e animali (quasi assenti le automobili), asini e muli usati come mezzi di trasporto, campi zappati a mano, donne che lavoravano come muratori fino a notte fonda o trasportavano balle di fieno sulla schiena. E noi stranieri guardati a vista e tenuti rigorosamente lontani dagli albanesi. È durante quel soggiorno che ho messo a fuoco quale fosse il rapporto tra i nostri dialetti arbëreshë e la lingua dalla quale derivavano.
Tornando alla mia formazione, al Dottorato di Ricerca ha fatto seguito una borsa di studio post- dottorato, di durata biennale, anche questa presso l’Università della Calabria. L’approdo al mondo accademico è stato dunque naturale. Ho iniziato subito dopo la borsa di post- dottorato e proprio dall’Università della Calabria dove ho tenuto, come docente a contratto, l’insegnamento di “Dialetti albanesi dell’Italia meridionale”, un corso che era stato avviato dal prof. Francesco Solano. Ho tenuto quel corso dal 1997 al 2002. Dal 2000 al 2002 ho invece tenuto il corso di “Lingua e letteratura albanese” all’Università di Bari e dal 2002 al 2008 ho tenuto il corso di “Lingua e letteratura albanese” all’Università di Firenze. Nel 2002 sono stata inquadrata come ricercatrice di “Lingua e letteratura albanese” all’Università Ca’ Foscari Venezia dove sono poi stata chiamata come professoressa associata.
Diciamo che sono riuscita a trasformare la passione per la linguistica e la mia conoscenza
dell’arbëresh/albanese in una professione.
La sua attività di ricerca spazia nei campi della sintassi albanese e arbëreshe, ma non sono gli unici ambiti ai quali si interessa, giusto?
È vero. Mi occupo prevalentemente di sintassi della lingua albanese e dei dialetti arbëreshë e lo faccio usando come metodo e strumento di ricerca il modello teorico della grammatica generativa. Come dicevo prima, questo modello teorico si è imposto a partire dagli anni ’50 del secolo scorso ed è stato accolto da linguisti di sintassi romanza, germanica e di altri gruppi linguistici. Lingue note e meno note hanno fatto da base empirica su cui applicare i moduli di questa teoria. Alla lingua albanese, questi metodi linguistici recenti sono stati applicati solo negli ultimi venti anni. La descrizione della sintassi albanese è sempre stata fatta seguendo metodi tradizionali, dunque, mediante la presentazione e la classificazione delle varie frasi della lingua ma senza mai arrivare ad una analisi delle stesse, senza mai entrare nel merito della loro struttura, dei rapporti che intercorrono tra i vari elementi che compongono le frasi, delle leggi che regolano certi comportamenti o spiegano certe devianze.
Lo stesso si può dire dei dialetti arbëreshë, la cui sintassi è diventata dominio di studio solo a partire dagli anni ’90.
Nell’affrontare lo studio dei dialetti arbëreshë, le questioni che emergono sono quelle che riguardano il legame tra l’arbëresh e la lingua madre, ovvero l’albanese d’Albania, il modo in cui l’arbëresh si è continuato in ambiente romanzo, le caratteristiche che ha conservato o innovato. È un fatto già accertato che i dialetti arbëreshë, dal momento in cui si sono separati dall’albanese hanno, per un verso, continuato il sistema originario, del quale hanno conservato i tratti di fondo, mentre, per l’altro verso, hanno cominciato ad innovare la loro grammatica e così hanno continuato a restare simili e vicini nei loro tratti conservativi ma, allo stesso tempo, hanno finito per allontanarsi l’uno dall’altro in virtù delle loro innovazioni. Pertanto, benché oggi si mostrino ancora ricchi di tratti decisamente conservativi al confronto con l’albanese odierno, i dialetti arbëreshë, allo stesso tempo, manifestano vari fenomeni innovativi, imputabili all’influenza romanza. Fenomeni che si osservano su tutti i livelli: fonologico, morfologico, lessicale e sintattico.
Io, attraverso la disamina di alcune strutture sintattiche, cerco di illustrare come opera la continuità e l’innovazione in questi dialetti sradicati dalla madrepatria da ben oltre cinque secoli. Generalmente nei miei lavori opero un duplice confronto: da un lato, il raffronto continuo tra il sistema morfo sintattico dell’arbëresh e quello dell’albanese d’Albania, che consente di verificare lo stato di resistenza della grammatica arbëreshe verso il modello originario e, dall’altro, il confronto tra l’arbëresh e l’italiano, che permette di evidenziare i mutamenti avvenuti nella struttura dell’arbëresh a seguito del contatto con l’italiano e i dialetti romanzi in area romanza. La descrizione dei dati della lingua albanese letteraria o standard è un presupposto necessario sia per poter stabilire le corrispondenze fondamentali tra l’albanese e l’arbëresh che per cogliere il rapporto tra l’arbëresh e l’italiano. Quindi, utilizzo una metodologia ‘moderna’ (non tradizionale) per indagare un dominio largamente contaminato da condizioni di variabilità linguistica. Per questi dialetti, il contatto linguistico è infatti la regola. Ogni singola comunità italo-albanese è punto di incontro e di sovrapposizione di due differenti sistemi linguistici: quello albanese e quello italiano. Un bilinguismo completo dove la mescolanza non è solo di tipo lessicale ma è anche una condivisione di strutture sintattiche. E, dati i legami plurisecolari delle parlate italo-albanesi con la popolazione italiana, le corrispondenze sintattiche tra l’arbëresh e l’italiano non possono che essere interpretate come il risultato di questa continua situazione di bilinguismo.
Dunque mi muovo in una dimensione strettamente linguistica, ma in una prospettiva comparatistica albanese-italiano-arbëresh per mostrare che, riguardo alla particolare creatività innovativa dell’arbëresh non ci sono sostituzioni secche di forme nuove a forme antiche ma coesistenza dei due modelli.
Benché la sintassi rappresenti, per eccellenza, il mio campo di ricerca, ho spaziato in altri domini con studi che riguardano la modalità di formazione delle parole (dove si intersecano componenti della grammatica come il lessico e la morfologia), per mostrare la ricchezza e la complessità degli elementi derivativi e compositivi delle parole. Ho fatto qualche breve irruzione nel campo della fonetica, occupandomi del sistema fonetico delle comunità arbëreshe dell’alto crotonese e di una particolare evoluzione che ha subìto un antico dittongo. Mi sono addentrata nel mondo della traduttologia per mostrare quanto sia complicato tradurre l’intraducibile, ovvero quanto sia difficile tradurre in modo fedele la narrativa albanese in lingua italiana vista la complessità semantica di alcuni testi che rimandano ad espressioni dell’universo culturale del popolo albanese. Questa lingua possiede alcuni costrutti, arcaismi, termini dialettali, espressioni e locuzioni radicati nella tradizione orale e popolare, legati alla vita, alla cultura, all’etnografia del popolo, per i quali il significante e il significato sono irriproducibili in una lingua diversa da quella originale. Tradurre dall’albanese all’italiano significa tradurre una identità composta da fattori di tipo etnico, culturale, nazionale in un contesto linguistico, ideologico e culturale differente, e ciò pone al traduttore una serie di difficoltà legate non solo alla differenza tra la lingua di partenza e quella di arrivo ma soprattutto determinate dal fatto di dover restituire un testo radicato nella tradizione orale di un popolo che ha seguito una traiettoria culturale diversa. Tradurre comporta sempre qualche compromesso, e impone delle limitazioni quando la distanza culturale e linguistica tra il contesto di partenza e quello di ricezione è molto grande. Ho toccato il campo del lessico, occupandomi della lingua di Kadare e del modo mirabile con cui crea neologismi e mescola le forme dialettali con quelle della lingua standard. Mi sono avvicinata a temi legati alla questione dell’identità albanese e al suo riflesso in letteratura e, ovviamente, alla cultura arbëreshe.
Quale tipologia di discenti si avvicina agli studi della lingua albanese?
Si tratta, in parte, di studenti figli di emigrati albanesi o kosovari che non hanno completato gli studi in patria o si sono scolarizzati in Italia e dunque parlano l’albanese dei loro familiari che quasi mai coincide con lo standard. Frequentano i nostri corsi per avvicinarsi all’albanese letterario, per imparare a scriverlo e a leggerlo. Per l’altro verso, si tratta di studenti italiani attratti dal carattere esotico di questa lingua, che è antica ed unica. L’albanese appartiene alla famiglia delle lingue indoeuropee benché indipendente all’interno della stessa ed è considerata la continuatrice di una altrettanto antica lingua parlata nei Balcani, l’illirico. Ha caratteristiche uniche che la avvicinano alle lontane lingue baltiche e all’armeno ed ha una serie di corrispondenze con le lingue balcaniche, che partecipano alla cosiddetta Lega linguistica balcanica. In Italia ha attirato l’attenzione degli studiosi già all’inizio del 1700. È infatti del 1716 l’opera Osservazioni grammaticali sulla lingua albanese, del frate francescano Francesco Maria da Lecce il cui duplice intento, a detta dello stesso autore, era offrire uno strumento ai missionari italiani impegnati nel propagare la fede cristiana in terra d’Albania e offrire uno strumento agli albanesi perché potessero imparare la forma scritta del loro idioma. Questa lingua, nel corso dei secoli, è stata scritta con alfabeti diversi: latino, greco, slavo, fino a quando, nel 1908, fu definito quello che è ad oggi il suo alfabeto ufficiale. È una lingua che ha raggiunto lo status di lingua letteraria unificata solo nel 1972 giacché in precedenza non è esistita una norma ufficiale valida per tutto il territorio albanese. Non meno interessante è la Storia, che, nei secoli, ha visto l’Albania come terra di conquista, fino all’ultima e più lunga dominazione, quella ottomana, terminata soltanto all’inizio del secolo scorso. È una terra che, per la sua posizione strategica, all’incrocio delle grandi vie di comunicazione fra Occidente ed Oriente, assomma in sé diversi modelli di civiltà: l’elemento romano, quello slavo, quello ellenico, quello orientale. È una terra caratterizzata da pluralismo religioso: qui convivono cattolicesimo, religione ortodossa, islam. L’Albania rappresenta un mirabile esempio di integrazione che mette insieme la cultura occidentale e le suggestioni del vicino levante ottomano. Non dimentichiamo poi la vicinanza con l’Italia, paese al quale è straordinariamente legata: vi è una trama di relazioni che da secoli unisce Italia e Albania, e in particolar modo, per ragioni storiche antiche, unisce proprio Venezia e l’Albania. Agli studenti non mancano le ragioni per scegliere di studiare l’albanese!
Parliamo delle sue pubblicazioni?
Certo! Due monografie sono dedicate alla lingua albanese: una in chiave comparativa con l’italiano, presenta la grammatica di questa lingua, e l’altra si concentra su un certo numero di strutture sintattiche analizzate con il metodo teorico della grammatica generativa. In un terzo libro, in collaborazione con la collega Flora Koleci (Università del Salento), proponiamo una introduzione alla sintassi generativa dell’albanese. Altri due volumi sono dedicati a materiali raccolti nell’Arbëria crotonese, dei quali si fa una analisi di taglio linguistico e culturale.
Poi c’è tutta una serie di articoli pubblicati in volumi o riviste nei quali affronto questioni di sintassi (e non solo) sia albanese che arbëreshe.
Per la lingua albanese, ho scritto sulle strutture locative ed esistenziali; sulle costruzioni Raising e pseudo-Raising (per intenderci, quelle col verbo duket “sembrare” che ammettono due possibilità: una col soggetto in posizione iniziale di frase, come nell’esempio italiano “Gianni sembra che sia felice” ed una in cui il soggetto è nella frase subordinata come in “Sembra che Gianni sia felice”. Le due strutture, nella lingua albanese hanno un comportamento dissimile da quello dell’italiano); sulla realizzazione del possesso predicativo; sulle particelle modali delle frasi congiuntive, infinitive e supine; sul fenomeno della cliticizzazione e del Clitic climbing (ovvero la salita del clitico da una frase subordinata ad una frase principale come nell’italiano “Voglio farlo”, “Lo voglio fare”); sulla interazione tra i clitici e la negazione; sui modificatori nominali preceduti dall’articolo; sulla struttura delle frasi contenenti nominali al caso ablativo; sull’interazione tra il caso, la definitezza e l’atelicità; sulle strategie di formazione delle strutture causative; sulle strutture interrogative; sui nominali indefiniti; sul comportamento degli elementi interrogativi e indefiniti; sui dimostrativi seguiti da un nominale definito; sulle peculiarità degli elementi possessivi. Ancora, sulla lingua albanese, ho raffrontato alcune caratteristiche linguistiche dell’albanese del XVII° secolo con quelle odierne attraverso l’analisi dell’opera Cuneus Prophetarum di Pietro Bogdani e l’uso della lingua materna nella prassi liturgica albanese nel Messale di Gjon Buzuku. Con la collega Lindita Sejdiu Rugova (Università di Prishtina) abbiamo analizzato i ruoli semantici e le strutture principali utilizzate in Viber.
Per l’arbëresh, ho trattato la realizzazione della voce verbale non-attiva nella sua interazione con le categorie del tempo e dell’aspetto; l’assegnazione del caso e le proprietà strutturali delle costruzioni causative e percettive; alcuni tipi di frasi participiali assolute, ovvero in posizione iniziale di frase e i problemi che sollevano in termini di assegnazione di caso e accordo col soggetto; la posizione dei clitici nelle strutture imperative, tra sviluppi autonomi e fenomeni di contatto; alcune strategie di assimilazione lessicale e morfosintattica che mettono in luce regolarità e devianze nei dialetti arbëreshë; alcune forme di contaminazione lessicale; fenomeni di continuità e innovazione nella morfosintassi dell’arbëresh; la struttura degli aggettivi-quantificatori; il costrutto ‘pa “senza” + participio’; la particolare evoluzione del dittongo ua in certi dialetti arbëreshë e, in collaborazione col compianto amico e collega Giovanni Belluscio, il vocalismo tonico della parlata arbëreshe di S. Nicola dell’Alto (KR).
Altri lavori sono dedicati all’assegnazione del caso nelle strutture pseudo-partitive; ad alcune similarità e differenze tra i numerali; ai soggetti con caso accusativo e dativo; alle strutture congiuntive; alle strutture infinitivali nei dialetti arbëreshë, nel tosco e nel ghego (i due tipi dialettali d’Albania); ai diversi tipi di frase possessiva nelle lingue balcaniche; al Clitic Climbing nelle lingue balcaniche da una prospettiva sincronica.
Andando oltre, ci sono lavori dedicati al problema della traduzione dall’albanese all’italiano; ai neologismi nell’opera di Ismail Kadare e all’incrocio fecondo tra la lingua e il dialetto nella sua scrittura; alla minoranza arbëreshe fra integrazione e assimilazione; al modo di declinare l’identità albanese tra categorie universali, come etnicità, lingua e fede, e categorie etiche come onore, rispetto, ospitalità, coraggio, nobiltà d’animo, buona condotta, parola d’onore; ai rapporti antichi tra Albania e Italia; al contributo degli studiosi italiani nel dominio della sintassi albanese e al contributo degli studiosi tedeschi alla dialettologia arbëreshe.
Ci sono poi una serie di curatele, frutto per lo più della raccolte dei contributi di diversi studiosi a convegni organizzati a Ca’ Foscari sui temi della linguistica generativa, della balcanistica e dell’albanologia.
Tra i suoi colleghi regna una grande preoccupazione circa le sorti della lingua arbëreshe. Qual è il suo parere a tal proposito?
Partirei da una premessa: l’arbëresh ha una modalità di lingua e di cultura orale e questo non è un fatto di poco conto. L’arbëresh è passato da uno stato di piena vitalità ad una condizione di forte regresso. La secolare conservazione del dialetto arbëresh nel territorio italiano è stata favorita, secoli addietro, sia dall’isolamento delle comunità che dal tipo di economia. Le comunità arbëreshe, insediatesi su aspre falde montane, in luoghi remoti e inaccessibili, sono state vere e proprie isole linguistiche fino alla fine dell’Ottocento. Solo alla fine del XIX° secolo, i parlanti sono passati dal monolinguismo arbëresh al bilinguismo arbëresh-dialetto locale con l’arbëresh ancora in posizione dominante. Mentre, durante il XX° secolo, l’aumentare delle comunicazioni ha esposto le comunità ai rapporti e allo scambio con i vicini paesi italofoni e soprattutto negli anni ’50 si è passati dal bilinguismo arbëresh-dialetto locale al trilinguismo arbëresh-dialetto locale-italiano con l’arbëresh già in posizione subordinata. È vero dunque che l’arbëresh è in una condizione di regresso e le caratteristiche della sua regressione non sono uniformi né omogenee. Variano a seconda delle zone geografiche: più vulnerabili sono state le comunità di pianura, più resistenti quelle di montagna. L’arbëresh regredisce anche in termini qualitativi rispetto alla quantità di strutture linguistiche conosciute, ibride e interferite. Nel parlare degli arbëreshë, le commutazioni di codice linguistico avvengono oramai all’interno della stessa frase che registra quindi la coesistenza delle varietà in combinazioni diverse. L’uso monolingue esclusivo del dialetto arbëresh è assai raro e la competenza delle diverse grammatiche è così profonda che il cambio di registro è rapidissimo e non va in una sola direzione ma è bidirezionale, così che mentre si parla albanese si può passare all’italiano e viceversa e le circostanze dell’attivazione sono del tutto individuali. L’arbëresh regredisce dunque rispetto alla frequenza di uso. C’è ancora un altro fatto: l’intenso contatto che dura oramai da più di cinque secoli ha fatto sì che la storia linguistica della comunità arbëreshe si intrecciasse fortemente con la storia linguistica delle regioni d’Italia che ospitano tali comunità: l’arbëresh ha inevitabilmente preso a prestito forme lessicali e strutture sintattiche ma resta il fatto positivo che i tratti imprestati sono stati integrati nella grammatica originaria consentendole di restare viva.
Se analizziamo l’arbëresh alla luce dei livelli di rischio stabiliti dall’Atlante UNESCO, dobbiamo
riconoscere che questa varietà ha, dove più, dove meno, toccato tutti i livelli: a) è vulnerabile, giacché, in alcune comunità, i bambini la parlano ma limitatamente a determinati contesti (a casa o coi compagni di gioco); b) è in pericolo laddove i bambini non la imparano più come madrelingua; c) è in grave pericolo laddove i genitori la capiscono ma non la insegnano ai loro figli; d) è in pericolo critico laddove è parlata solo dalle generazioni più anziane; e) è estinta laddove non ci sono più parlanti. È chiaro dunque che tutto ciò che si dice su questa lingua minoritaria ha un sapore tragico!
Il problema più preoccupante è che l’arbëresh regredisce in termini quantitativi dal momento che si riduce il numero e la classe dei parlanti. La fuga verso il Settentrione prima e il calo demografico dopo sono le vere minacce alla sopravvivenza di queste parlate che, ancora oggi, rivelano secoli di attaccamento alla lingua madre. Gli arbëreshë sono sopravvissuti con una grande fedeltà a sé stessi per oltre 500 anni. Questo è un dato di fatto! Se si estingue l’arbëresh, con esso si perdono tutti i valori che questo trasmette perché l’arbëresh non è solo quel che si parla, è anche cultura, patrimonio di valori; è modo di pensare, è bagaglio di storia, di tradizioni, di memoria; è simbolo di identità e di unità della comunità. Oltre a ciò, l’arbëresh ha un alto valore scientifico: è una pietra miliare nello studio dell’albanese d’Albania giacché attraverso questi dialetti si può studiare l’evoluzione della lingua albanese prima e dopo l’emigrazione dalla madrepatria verso l’Italia; si possono recuperare voci arcaiche che l’albanese d’Albania ha ormai perso perché sostituite con altre; si possono monitorare i suoi rapporti con l’albanese d’Albania.
È necessario salvaguardare questo prezioso patrimonio linguistico. Bisogna difenderlo e promuoverlo, renderlo visibile attraverso i media (giornali, radio, TV), farne strumento di comunicazione nella quotidianità, allargare i domini del suo utilizzo consentendone l’uso in tutti i contesti, in tutte le situazioni e istituzioni, dunque anche in ambiti amministrativi e scolastici; è necessario promuovere un’istruzione bilingue, creare tutti gli strumenti per il suo apprendimento. Bisogna pensare ad una vera pianificazione linguistica con la messa in pratica della legge 482 del 1999 che, pur avendo adottato le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche, non ha mai trovato una vera e piena applicazione nelle comunità arbëreshe. Devono intervenire le Regioni alle quali la legge ha dato piena autonomia. Bisogna sensibilizzare le istituzioni perché tutelino una lingua storica sul territorio italiano. Bisogna restituirle il prestigio di cui godeva due secoli addietro quando De Rada lo utilizzava nel primo giornale della stampa albanese in Italia (“L’Albanese d’Italia”). Certo, se si continua a solo forme di folclore, la lingua andrà a morire.
Progetti futuri?
Parliamo intanto di quelli in corso che comunque si proiettano nel futuro. Un progetto coraggioso e transdisciplinare che unisce diverse competenze è il Moti i madh, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Solano, l’Università della Calabria e quella di Palermo, con il coinvolgimento dell’Università del Salento, dell’Università di Milano e dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e il cui obiettivo è quello di tutelare, valorizzare e divulgare il patrimonio intangibile di queste comunità. Lo stesso gruppo accademico lavora poi ad un progetto PRIN che mira a creare un archivio digitale, ovvero un atlante linguistico multimediale delle varietà arbëreshe, da adottare per le ricerche linguistiche, socio-antropologiche, filologico-letterarie e di statistica. Qualcosa di buono e positivo verrà fuori di certo!