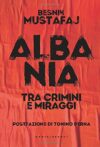Il mio nome è Bardhyl Huta. Mi hanno sempre chiamato col diminutivo, Luli. Sono il figlio di Omer Huta. Il nome di mio padre non è per niente conosciuto.
Anzi, lui ha sempre fatto di tutto per restare il più lontano possibile dall’attenzione degli altri. Non voleva essere notato né in bene né in male. Ho l’impressione che quell’uomo abbia sognato tutta la sua vita di essere invisibile. Quanto meno, di stare nell’ombra. In qualche modo, quest’ultimo obiettivo lo aveva raggiunto. Le rare persone che lo ricordano, al di fuori delle mura domestiche, cioè nell’azienda dove lavorava come magazziniere degli attrezzi di lavoro – altrove non andava mai –, lo definirebbero facilmente un’ombra. Entrava e usciva come un’ombra. Salutava prevalentemente con un movimento del capo e ci sarebbe voluta una ragione imprescindibile perché aprisse la bocca e ne facesse uscire una voce spenta, quasi che avesse in gola un qualche ostacolo che gli rendeva difficoltosa la pronuncia delle vocali. Io oso, in questa occasione, citarlo con il suo nome, togliendolo così, volente o nolente, al suo anonimato, soltanto perché è indispensabile per lo sviluppo della storia. Ovviamente approfitto anche del fatto che egli non sia più tra noi. Non può impedirmelo.
Noto, direi molto noto, soprattutto tra gli anziani della zona di origine della mia famiglia, è il nome di mio nonno Oso Huta. A lui è legato il primo snodo del racconto. Di Oso Huta, la gente e anche molti scritti di storia locale dicono che era stato un uomo coraggioso e temerario, cosa che in mio padre, a quanto mi era dato vedere, non suscitava alcun moto d’orgoglio. Anzi, il contrario. Gli elogi per Oso Huta, soprattutto quando questi elogi si facevano altisonanti, provocavano in lui una sorta di turbamento, incomprensibile non solo a me che ero bambino. Mentre altri non avevano remore perfino a inventarsi dal nulla glorie familiari, eroismi contro gli occupatori stranieri o anche contro il deposto regime monarchico. In una situazione in cui tutti erano stati spogliati di qualunque patrimonio materiale, una gloria del genere aveva il valore di un’eredità inestimabile, venuta dagli antenati della famiglia a migliorare nel concreto le condizioni di vita delle generazioni del comunismo. Le medaglie luccicanti erano associate a sussidi alimentari preziosi, a posti di lavoro confortevoli, al diritto dei figli di studiare nelle scuole migliori.
Di questa eredità, che gli veniva dal fatto di essere il discendente diretto e unico dell’eroe, mio padre non voleva proprio saperne. Con questo suo comportamento io non ero affatto d’accordo. Quando fui cresciuto abbastanza per acquisire il diritto di parlare al suo cospetto, gli espressi più volte la mia meraviglia, e anche il mio disaccordo riguardo a questo suo atteggiamento. Rientra in te, mi rimproverava mio padre, senza darmi alcuna vera spiegazione. Chi sale è destinato a cadere a testa in giù. Non c’è modo di scendere dall’alto in basso in maniera indolore. La testa ti trascina verso l’abisso. Risposte di questo genere non facevano che aumentare la mia confusione. Egli aveva trovato, tuttavia, il modo di insegnarmi a considerare l’orgoglio qualcosa di particolarmente rischioso. L’orgoglio ti porta in carcere. Mio padre aveva una paura istintiva del carcere. L’evocazione del carcere aveva sempre gravato sulla mia famiglia come un incubo cieco, ingiustificato, soprattutto per me che ero nato e crescevo in un contesto sociale in cui l’esaltazione delle glorie passate era nella morfologia stessa della lingua. Come figlio di Omer, mi sarebbe piaciuto scavalcare mio padre e presentarmi come il discendente diretto e unico di Oso Huta.
Mio padre non consegnava né valorizzava questa eredità. Per di più, non ci dava alcuna spiegazione. Si limitava, ogni mattina, a raccomandare a me e a mia madre, prima che uscissimo di casa, di stare attenti. Se andate in carcere, non verrò a trovarvi, ci minacciava ogni volta. Ed era assolutamente serio. Non vorrò nemmeno sapere se siete vivi o morti. Ma non l’ho mai sentito spiegarci da dove potesse venire una simile minaccia, né che genere di misure dovessimo prendere per scongiurarla. Arrivato a una certa età, mi è capitato a volte di chiedergli perché avesse così tanta paura del carcere. Io questo ti dico, rispondeva reciso. «Non presagire al tuo unico figlio il male» lo pregava mia madre. Una predestinazione che oserei definire fatale mi ha unito a Linda. Non che io non sia soddisfatto di aver scelto lei come donna della mia vita. Se dovessi sposarmi altre cento volte, sarebbe sempre lei mia moglie. Voglio dire che una predestinazione fatale mi spinse proprio verso una ragazza la cui storia familiare aveva anch’essa, nel profondo, il carcere, proprio come una placca tettonica che scatena terremoti senza preavviso. Mio padre già non era più in vita. Sapevo che avrebbe fatto di tutto per mettersi di traverso fra noi. La sua assenza, per molte ragioni, mi facilitava le cose. Ovviamente non gli avrei permesso di ostacolare il mio rapporto con Linda, cosa che, si capisce, sarebbe stata un duro colpo per il suo amor proprio. Ma il colpo vero e distruttivo lo avrebbe subito in seguito, a causa della piega che prese la mia vita. Di certo, si sarebbe considerato colpevole di non essere riuscito a prevenire la catastrofe.
Dei genitori di Linda ho conosciuto solo la madre. Si chiamava Selvi ed era la figlia di Hyqmet Hidi, per tutta la vita guardia carceraria. A quella guardia è legato il secondo snodo di questo racconto. La mia condanna dimostrò che erano stati inutili tutti gli estenuanti tentativi, sia della mia famiglia che di quella di Linda, di costruire per noi, i loro figli, una vita che non avesse legami con il passato. I miei genitori e quelli di Linda non avevano avuto bisogno di conoscersi e di accordarsi per avere un desiderio comune: seppellire una volta per tutte il passato sotto la polvere dell’oblio. La mia condanna non stupì nessuno. È legato, così, a me il terzo snodo del racconto. Gli Huta hanno il carcere nel sangue, si disse tra i vecchi conoscenti della nostra famiglia. E si rinnovarono misteriosamente i ricordi su mio nonno. Andò diversamente per Linda. Lei fu compatita da tutti. Povere donne, si sussurrò. Tale la madre, tale la figlia! Il destino le ha inchiodate al carcere come alla grotta del diavolo.
L’opinione e la voce dell’autore
Sono due le principali tematiche di approfondimento intorno alle quali si snoda questo Piccola saga carceraria di Besnik Mustafaj, per la traduzione di Caterina Zuccaro: l’esplorazione della prigionia politica come organismo e come dimensione atta a suggestionare più le persone libere che quelle incarcerate e quella delle prigioni, i penitenziari, i campi di deportazione, di internamento, dove vige il lavoro forzato, luoghi terribili di persecuzione, di soppressione delle più elementari condizioni della dignità umana e in molti casi di morte.
È la sorte carceraria che soffoca la libertà: Mustafaj, attraverso la “piccola” saga della famiglia Huta, evidenzia come la storia socio-politica dell’Albania (in special modo quella che riguarda gli anni successivi al secondo dopoguerra, con l’avvento del regime comunista), sia stata sempre stretta nella morsa del dominio, con un isolamento apparentemente protettivo e in realtà, creato con il becero obiettivo di incatenare il pensiero e mortificare l’identità del popolo.
Mustafaj con la penna lucida e decisa che lo contraddistingue, descrive il sistema creato dal regime, fautore del terrore che si manifesta nella comunità, tanto quanto nelle celle, nei parlatori, nelle stanze delle torture. Narra di una sorta di forzato indottrinamento, che crea divisioni tra carcerati e prigionieri, spiati e spie, che imprigiona i corpi, ma soprattutto le menti.
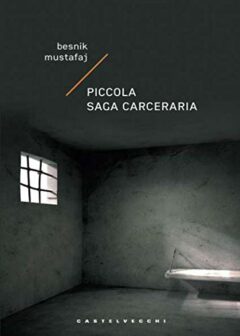
Durante il periodo comunista, posso dire che il più grande gesto eroico fosse quello di farsi domande, perché solo se ti poni dei quesiti cerchi le risposte. Per questo motivo, il sistema totalitario era impostato affinché il popolo potesse non farsi domande e di conseguenza non cercare le risposte, prendendo in considerazione e per veritiera solo l’ideologia governativa. Il mistero, per me, stava proprio nel fatto che ad avere paura fossero i cittadini liberi, fuori dal carcere.
Mustafaj ha voluto scrivere circa la storia della prigionia politica del Novecento durante la monarchia, il fascismo e il comunismo, tre sistemi più o meno monolitici, sia politicamente che giuridicamente. I personaggi che animano i miei libri non sono mai incarcerati, tranne quello protagonista del periodo comunista, anche se vorrebbe vivere come se fosse fuori. Quando ho compreso che la situazione mentale della gente libera e non condannata era la vera prigione e una sorta di lotta per la sopravvivenza, ho ritenuto opportuno raccontare questa verità.
Quindi, Piccola saga carceraria è composta da tre libri che potrebbero essere pubblicati anche separatamente, in quanto autoconclusivi. La prima storia narra della prigionia politica durante la monarchia; ho scritto circa centocinquanta pagine, facendolo passare come un racconto per bambini e pubblicandolo nel 1987. Del resto, il personaggio protagonista è un ragazzino e per questo ha visto la luce come un libro rivolto ai ragazzi, ma non lo è. Si tratta di un racconto terribile, che nulla ha a che fare con l’infanzia, ma la censura non lo ha compreso: ha guardato il profilo del bimbo e il periodo monarchico, nulla di più.
Il racconto riguardante il fascismo è stato pubblicato nel 1989, mentre quello narrante la realtà comunista, ha visto la luce su una rivista, subito dopo la caduta del regime, esattamente nella settimana seguente la liberazione. In quel periodo, ho compreso che, anche in un momento caratterizzato dalla libertà, non era facile accettare la realtà vissuta durante la dittatura. La figura protagonista di questa storia è un prigioniero politico, che ha diritto di trascorrere una notte con sua moglie in una camera, chiamata speciale. Egli attende tanto il momento per poter passare del tempo con l’unica donna della sua vita, che ama. Quando si trova nella situazione, non ce la fa a fare l’amore, perché subentra la paranoia, (o la verità), di essere ascoltato e spiato dalla guardia e per questo non riesce a essere maschio, senza poterne spiegare le motivazioni, altrimenti la donna risulterebbe colpevole di fronte al regime. Nasce, così, un’incomprensione tra i due amanti, tanto che la moglie gli chiede se fosse diventato omosessuale. Non è una domanda accusatoria, ma dettata dalla perplessità e dalla mancanza di chiarezza. Era la prima volta che si parlava di omosessualità in un libro albanese.
Quando il mio testo è stato pubblicato sulla rivista, un ex perseguitato politico e scrittore ha redatto un articolo terribile contro di me, per aver rappresentato, secondo il suo parere, i prigionieri politici come degli inetti e degli omosessuali. Questo dimostra come, per gli albanesi, la prigione sia mentale, specialmente in relazione alla politica, una realtà ancora oggi persistente. (dall’ intervista rilasciata da Besnik Mustafaj ad Albania letteraria).