Anesti Naçi vive a Valona sino alla tarda adolescenza, quando si trasferisce in Italia. Studia all’Università di Udine, dove consegue la laurea in Lettere e qui è dottore di ricerca in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera.
Prende parte, in qualità di assistente di cattedra, ai corsi di Storia contemporanea presso l’Università di Udine con la quale continua la collaborazione occupandosi di Storia culturale albanese, con riferimento al periodo comunista e con un occhio attento alle tematiche dell’ateismo di Stato, della religione, dell’identità e del carattere nazionale albanese e i suoi rapporti con l’alterità.
Di seguito l’intervista realizzata in occasione dell’uscita del libro Il dramma dell’Albania nel racconto del delegato apostolico Leone G. B. Nigris (1938-1944) , di cui è curatore, pubblicato da Forum Edizioni con il sostegno dell’Istituto Pio Paschini.
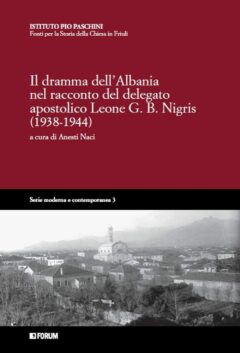
Parliamo della genesi del tuo ultimo libro Il dramma dell’Albania nel racconto del delegato apostolico Leone G.B. Nigris (1938-1944)?
La genesi di un libro di storia è quasi sempre legata a un personale percorso di ricerca, al tentativo di dare luce a uno studio intrapreso attorno a una data questione. In questo caso è un po’ diverso, c’entra tanto anche la fortuna, che, più di quanto si pensi, regna talora sovrana nel mondo della ricerca.
Il documento pubblicato (Cenni sulle vicende dell’Albania dal 1938 al 1944), conservato nell’archivio della Biblioteca Arcivescovile di Udine, ha dapprima incuriosito i responsabili della Biblioteca e coinvolto successivamente l’Istituto di ricerca “Pio Paschini”, del cui comitato scientifico fanno parte alcuni professori e colleghi dell’Università di Udine con la quale collaboro.
In quanto studioso della cultura albanese, mi è stato chiesto di curare l’edizione di questo scritto, proposta che ho accolto con entusiasmo. L’ho considerata una opportunità per dare alla luce un documento importante della storia albanese, che fotografa l’Albania di quegli anni difficili.
L’istituto Paschini, che si occupa della storia della Chiesa in Friuli, si è impegnato in questo modo nella pubblicazione di un testo sulla storia dell’Albania, cosa che in sé è molto bella: due mondi, quello friulano e quello albanese, hanno così avuto modo di incontrarsi, ora attraverso questa collaborazione, negli anni della seconda guerra mondiale attraverso la figura del delegato apostolico monsignor Leone G. B. Nigris, nato appunto in provincia di Udine. In verità, nel libro si scoprirà che questi due mondi sono stati molto più vicini di quel che si possa pensare già dal primo ‘900.
Quale criterio è stato adottato nella scelta delle foto che impreziosiscono il volume?
In merito a questo vorrei ricordare innanzitutto il contributo del Museo Nazionale della Fotografia “Marubi” di Scutari, che ha reso possibile la realizzazione dell’appendice, diciamo così, estetica. A essere sincero, non era mia intenzione inserire delle foto; i colleghi dell’Istituto mi hanno spronato in questa direzione, con la finalità di dare un volto ai personaggi coinvolti nelle vicende narrate da Nigris.
Ho così colto l’occasione per cercare qualcosa che riguardasse Scutari, città meravigliosa, che amo: Scutari e Valona rappresentano le due “città della passione” , le uniche, oggi come allora, nel ruolo di alter-ego culturale della “tiranizzazione” (mi permetta questo neologismo) dell’Albania.
Il dramma, che l’Albania ha vissuto durante la seconda guerra, è stato raccontato più volte. Quali sono i “nodi cruciali” di questa relazione che fanno la differenza?
Ovviamente qui si tratta di una testimonianza – già alcuni studiosi avevano consultato e adoperato la versione vaticana di questo documento – che, nonostante non si possa definire del tutto disinteressata, rappresenta uno sguardo “altro”, in certi passaggi perfino neutrale, esterno alla dinamica politica che coinvolge il Paese delle Aquile. Alla fine l’autore offre una sua visione, da una prospettiva certo cattolica, certo italiana, ma non fascista e, ovviamente, nemmeno comunista.
L’aspetto dominante del racconto riguarda le osservazioni su ciò che monsignor Nigris conosce meglio: gli italiani e i cattolici. Al di là delle considerazioni che riguardano altre categorie, come comunisti, musulmani ecc., quello che possiamo valutare come particolarmente importante è il racconto sugli italiani e gli albanesi con cui Nigris viene in contatto.
“I nodi cruciali”, quindi – come Lei dice –, riguardano le osservazioni o le narrazioni che il Delegato fa soprattutto nei confronti della componente anticomunista, cioè di quella parte del paese che, al di là del giudizio morale sulle scelte che ne contraddistinsero l’azione, si è trovata dalla parte “perdente”, sbagliata, della storia albanese. Quella componente è quella che Nigris conosce meglio, ed è quella a cui riserva le sue “attenzioni” particolari: è questo, direi, l’aspetto più importante di questa pubblicazione.
Quanto studio e approfondimento ha richiesto la cura di questo volume?
Io mi occupo di storia albanese del ‘900, sotto il profilo culturale soprattutto. Molte cose che ho qui cercato di presentare e approfondire le avevo già affrontate. Le difficoltà maggiori in questo caso hanno riguardato la possibilità di lavorare negli archivi, considerando che si è trattato di un periodo condizionato dalla pandemia e dalla chiusura di biblioteche e istituti di ricerca.
Il libro che ha in mano presenta un argomento un po’ di nicchia, se vogliamo: tuttavia, l’apparato di note esplicative è tale da rendere lo scritto comprensibile, un vero testo di storia. Nella versione albanese del volume – è nostra intenzione procedere anche in questa direzione – molte parti verranno riscritte: più che chiarimenti, saranno necessari ulteriori approfondimenti. Il pubblico albanese non avrà bisogno di sapere in sette, otto righe di nota chi era il loro re o il loro primo ministro dell’epoca … ci sarà semmai la necessità di introdurre alcuni personaggi italiani.
Il lavoro di pubblicazione di una versione albanese del volume dovrà offrire spunti ed elementi per la valutazione obiettiva di quel periodo storico; e, per una volta, mi piacerebbe che in Albania non ci si concentrasse solo sulle dinamiche albanesi – infatti ho cercato di rimanere il più possibile neutrale in merito alla diatriba politica della storiografia che riguarda il periodo in questione – ma ci si soffermasse anche sulla componente italiana: chi
erano realmente gli italiani del ’39?
Questa relazione costituisce una fonte straordinaria non solo per la storia dell’Albania ma anche dell’Italia. Perché anche per l’Italia e in maniera così netta?
Un grande storico come Enzo Collotti lamentava l’assenza di studi sul fascismo italiano esportato in Albania, sulle dinamiche umane e di potere che si sono succedute, sulle faccenderie, sulla rete di corruzione e camorristica che ha coinvolto il Paese e gli italiani in primis.
Collotti sollecitava uno studio che riguardasse l’«affarismo di regime» che si impose in Albania. E qui, in questo documento, Nigris ci offre effettivamente la possibilità di avvicinarci a questo tema, naturalmente senza prendere per verità assolute le sue parole, i suoi giudizi – cosa che mai uno storico dovrebbe fare dei testimoni e delle fonti che maneggia. Certamente nella sua testimonianza ci sono indizi importanti: nomi e cognomi di quel fascismo dalle mani sporche. Ci sono nelle sue riflessioni una serie di valutazioni dell’operato italiano.
Sin dalle prime righe Nigris segue un percorso fatto di continue osservazioni e giudizi morali e politici, valutazioni sull’operato del proprio paese invasore, che vuole assoggettare un paese più piccolo. Inizialmente sembra che Nigris sia convinto del valore morale dell’impresa, appare quasi tentato di giustificare tale salto nel buio dell’Italia mussoliniana.
Il tempo trascorso accanto alle autorità italiane lo porterà, tuttavia ben presto, a parlare di fallimento totale: elencherà e indagherà chiaramente una serie di “errori” fatali, tredici per esattezza. Per me –che mi occupo di storia culturale – un altro aspetto importante di questo testo riguarda il rapporto fra italiani e albanesi, la riflessione sulle dinamiche di reciprocità fra i due paesi: in questo senso, il punto di vista di Nigris è una fonte straordinaria, il delegato apostolico rientra fra gli italiani che giudicano l’Albania e gli albanesi. Ecco, in questo senso è una fonte anche per la storiografia italiana, che dovrebbe porsi l’obiettivo di risolvere questo “problema”: il rapporto culturale con l’Albania.
Due parole sulla figura di Nigris e sul suo ruolo in Albania.
Leone G. B. Nigris è una figura molto complessa e direi, per certi versi, controversa. Nonostante la ricerca sul personaggio e la lettura dei suoi scritti, non posso dire di avere composto un ritratto definitivo. A volte ripenso a ciò che ho scritto … si tratta di un uomo con una personalità complicata e dalle molte sfumature. Uomo di chiesa, con un alto valore dell’ordine e un forte senso del dovere, che deve affrontare la sua missione in un contesto fortemente politicizzato, nel senso anche discutibile del termine, in un luogo la cui cultura e lingua, le cui usanze e tradizioni conosce ben poco. Da molti in Albania è visto come un uomo dal carattere difficile, rigido e “proveniente da un ambiente ristretto” – come lamentano i gesuiti.
Se si volesse indicare la sua qualità principale (che tuttavia raramente lo ha aiutato in quel contesto) dovremmo riferirci soprattutto alla sua morale e alla sua intransigenza, che lo hanno reso inviso alle autorità politiche e civili italiane che si spartivano la torta coloniale dell’Albania. In nome della morale, di una certa morale, intesa anche in senso laico, non solo religioso, Nigris prende spesso posizione contro gli uomini di potere nell’Albania del periodo, che inquadra entro un ordine di «cerchi malefici».
Allo stesso modo però, quando veste i panni del sacerdote premuroso, ruolo che gli è più congeniale, riesce anche nella difficile impresa di trovarsi vicino a coloro che subiscono le sorti tragiche di quella guerra; vicino ai sofferenti, ai soldati italiani e agli ebrei soprattutto. Un giudizio definitivo su questo uomo della Chiesa risulta difficile: sarebbe riduttivo in effetti ingabbiare in definizioni di sintesi personaggi, come lui, dalle molteplici sfaccettature, obbligati ad agire in condizioni molto difficili.




