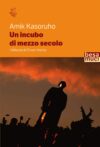Prima insegnante, poi ambasciatore d’Albania in Francia, in Portogallo e a Monaco, Ylljet Aliçka è autore di un cospicuo numero di opere letterarie. Da alcune di esse sono state tratte importanti sceneggiature, mentre altre sono nate dalla sua penna. Apprezzato in Albania e tanto all’estero, Aliçka, nell’intervista che ci ha gentilmente concesso, racconta la sua storia di uomo e di scrittore.
Perché decidi di iniziare a scrivere?
In verità, ho studiato scienze naturali e non ho mai pensato di diventare uno scrittore: da adolescente non ho mai scritto nemmeno una poesia. Appartengo, però, alla generazione del comunismo albanese, per la quale, a causa dell’isolamento a cui il Paese è stato costretto per tanti anni, la lettura era uno dei piaceri più grandi. Abbiamo letto molto in quell’epoca, adesso lo facciamo molto meno: io leggo ancora, ma non come una volta. In quel periodo si leggeva di tutto e soprattutto il gusto e la voglia di farlo erano molto forti. Ho iniziato a scrivere quando avevo quarant’anni e per caso.
A quei tempi ero burocrate presso il Ministero della Cultura e durante un viaggio a Strasburgo per il Consiglio d’Europa, una missione per me storica e fortunata, durante una serata in compagnia degli appartenenti alle altre delegazioni, ciascuno di noi, ha raccontato una storia del proprio Paese. Avevo voglia di narrare qualcosa dal sapore esotico e mi è venuta in mente una vicenda accaduta quando ero insegnante in un villaggio di montagna. Oltre ai corsi che tenevamo e alle lezioni con gli alunni, avevamo l’incarico di posizionare degli slogan politici sulle montagne, che fossero visibili da lontano, come strumento di propaganda del regime. Era un lavoro molto duro, bisognava andare nelle scarpate più impervie, da dove lo slogan potesse essere visibile, dove preparare un terreno liscio per poter inserire le pietre lavorate creando, appunto, delle frasi propagandistiche a favore della dittatura. Era un lavoro fisico molto pesante e a seconda della simpatia o dell’antipatia, veniva assegnata una frase con poche o tante lettere.
Un giorno, è arrivata a scuola una nuova insegnante molto bella, alla quale il direttore ha affidato uno slogan fatto di sole 4/5 lettere e tutti noi abbiamo capito che la sua scelta era dettata dalla volontà di corteggiare la giovane. Dopo sei mesi, durante una riunione, lo stesso uomo ha affidato alla bella ragazza uno slogan chilometrico che recitava così: Noi dobbiamo pensare, lavorare e lottare come dei veri rivoluzionari. Ella era molto triste, abbattuta e tutti noi abbiamo capito che il suo corteggiamento non era andato a buon fine. I partecipanti alla cena si sono mostrati molto divertiti, tanto che un francese di Marsiglia, il giorno dopo mi ha chiesto di mettere nero su bianco lo stesso racconto. In realtà, me lo chiedeva in quanto direttore di una rivista marsigliese e avrebbe voluto pubblicarlo. Sotto forma di fiction o di documentario non era così importante, bastava scriverlo. Una volta rientrato a Tirana, mi sono messo a redigere un testo per la prima volta nella mia vita e ci sono riuscito. Naturalmente, nonostante conoscessi il francese, l’ho scritto in albanese: una volta tradotto, l’ho inviato al direttore della rivista che ha provveduto a pubblicarlo. Quindi, il mio primo racconto è stato pubblicato in Francia ed è talmente piaciuto ai lettori, che il giornale mi ha inviato un compenso di duecento dollari. Ero davvero felice.
La cosa, in realtà, non è finita qui. Lo stesso direttore mi ha chiesto altri tre racconti, che ho fatto presente di non avere. La sua risposta è stata gentile, ma diretta: se sei stato capace di scrivere un racconto, puoi scriverne altri tre. In quel momento mi sono sentito apprezzato, tanto da considerarmi già uno scrittore. Ho redatto i tre racconti, tutti pubblicati e quando sono arrivati a dodici, sempre lo stesso responsabile ha fatto da tramite con una casa editrice di Marsiglia, che ha pubblicato la raccolta. Per me è stato un grande piacere, una grande avventura.
Inoltre, un produttore di film francesi mi ha proposto di scrivere una sceneggiatura. Gli ho riferito di non averne mai scritta una e anche in questo caso, la risposta è stata la stessa: se sei stato capace di scrivere i racconti, sarai capace di scrivere una sceneggiatura. Effettivamente, adattare il racconto a una suddivisione in scene non è stato così difficile: ne è nato un film franco italiano, che niente di meno è stato selezionato al festival di Cannes nel 2001, ricevendo il Premio della critica. In quel momento, ho pensato che sarei stato famoso, ma non è stato così. Insomma, ho iniziato a scrivere per caso.
Vorrei toccare anche con te un argomento di cui ho discusso con altri, precedentemente. Cosa ne pensi della Lega degli scrittori?
Ogni scrittore, durante il regime dittatoriale era costretto a rispettare gli standard del realismo socialista, cioè la tipologia del personaggio positivo contro il male, contro tutto ciò che era negativo, soprattutto politicamente e ideologicamente. Questo era lo standard. Ogni autore era costretto a fare un compromesso con il regime e con se stesso. Il mosaico intellettuale era variegato: c’erano scrittori realmente convinti, soprattutto quelli della generazione degli anni ‘40, influenzati dal comunismo europeo dell’epoca. Erano autori impegnati politicamente, persuasi del fatto che il comunismo e il realismo socialismo fossero al servizio del popolo. Quest’ultima sezione, non aveva bisogno di trovare alcun escamotage, mentre gli altri sì, perché era l’unico modo per essere pubblicati e poter esprimere le proprie idee. Oggi va di moda criticare il Blocco e i privilegiati dell’epoca. Noi tutti aspettavamo con grande emozione la pubblicazione dei libri di Ismail Kadare, innanzitutto per il suo valore artistico e poi per poter cercare e trovare le allusioni contro il regime.
Cosa che Kadare dice di aver fatto, di essersi espresso tramite metafore.
È vero. Sono del parere che questo abbia funzionato. Egli aveva trovato il modo di omaggiare la dittatura, scrivendo in una maniera che potesse piacere anche a noi. I suoi scritti ci nutrivano spiritualmente: per tutta la mia generazione, a parte qualche eccezione, era così. Adesso ci sono varie opinioni, ma per tutti gli intellettuali dell’epoca, la vita era doppia. Era un’esistenza caratterizzata da un unico pensiero: il totalitarismo non cambierà mai, la dittatura non finirà mai e così ciascuno aveva trovato il modo di sopravvivere, ma di farlo con gioia. Insisto su questo concetto, perché tutti dicono che abbiamo sofferto durante quel periodo. Certo, ma non per tutti era così, perché l’idea di piacere non era relativa solo all’economia, ma, anche, al concetto di superiorità.
A quei tempi, le famiglie privilegiate si sentivano felici, perché erano superiori, erano un gradino sopra agli altri. Oggi, malgrado la loro condizione economica sia molto migliorata, non si sentono così bene. Io ho provato a descrivere questo anche nel mio ultimo romanzo, Metamorfosi di una capitale (Castelvecchi, 2019), affermando che il concetto della felicità, non era legato solo alla ricchezza materiale, ma anche all’idea di protagonismo. Essi erano felici, perché si sentivano figure centrali ed è in questo modo che io spiego la nostalgia del regime che provano molti ex privilegiati. Hanno, appunto, nostalgia della loro posizione. In questo modo chiarisco come non tutti hanno sofferto durante il comunismo; a meno che non si fosse perseguitati, si trovava lo spazio per essere tranquilli e vivere serenamente. Io, per esempio, non ero perseguitato, ma non ero privilegiato: odiavo la dittatura, per me la peggiore forma di democrazia odierna è migliore della dittatura di un tempo.
Queste sono le stesse polemiche che stanno coinvolgendo Lea Ypi. Ella è cresciuta in una famiglia non molto privilegiata, che ha mantenuto segreti i sentimenti anti – comunisti e per questo si sentiva felice, bambina, con il suo fazzoletto rosso al collo. All’epoca tutti noi eravamo così stupiti nel vedere la Lega degli scrittori, un centro culturale importante e guardavamo le loro serate mondane con meraviglia. Gli scrittori dell’epoca non avevano di certo il paraocchi, semplicemente trovavano la via d’uscita per poter scrivere facendo un compromesso con il regime.
Parliamo dei tuoi libri pubblicati in Italia. Vorrei iniziare da Gli internazionali (Rubbettino, 2018), in quanto è un libro che mi ha colpito molto. Perché decidi di scriverlo?
Non è il mio miglior libro, ma mi ha fatto soffrire, soprattutto dal punto di vista istituzionale. Ricevevo pressioni; non dico da chi, naturalmente. Mi chiedevano chi mi avesse sostenuto, se i cinesi, gli arabi o gli orientali o chi mi avesse spinto a scriverlo. Non mi aveva spinto nessuno, era solo un rabbia personale: il tutto era iniziato con dei problemi avuti con uno dei miei capi, che voleva sostituirmi perché era innamorato di una giovane (che avrebbe preso il mio posto). Egli era italiano: io all’epoca lavoravo all’Ambasciata dell’Unione Europea, un ambiente caratterizzato da una buona multinazionalità. Ero responsabile della cultura e tutti noi sentivamo a quei tempi lo sguardo sprezzante e discriminatorio nei confronti del nostro essere albanesi. Basti pensare all’attraversamento del confine dei vari stati, mille domande solo per quanto vedevano scritto sul passaporto. A volte il tono indagatorio si trasformava in razzismo. Io avevo un buon stipendio, un buon lavoro, ero pagato da Bruxelles, dall’Unione Europea ed ero venuto a conoscenza, appunto, dell’intenzione di mandarmi via. Mi sono sentito incapace di far fronte a questa pressione psicologica e sentivo di subire un’ingiustizia.
Siccome non vedevo mezzi intorno a me per fronteggiare quanto mi stava accadendo, ho iniziato a scrivere il libro per sfogare tutto il mio odio, il mio rancore e il mio risentimento. Scrivendo, è venuto fuori un lavoro che ha abbracciato un contesto più generale; l’obiettivo era quello di far passare un messaggio sull’uguaglianza. Tutti quei piccoli difetti, tutte quelle piccole cose fastidiose, che vedevano in noi, erano presenti anche in loro. Il libro in Albania ha suscitato molto scalpore: ho avuto il coraggio di affermare determinate cose e forse per questo, è stato un grande successo, tanto da essere continuamente ristampato.
È uno scritto ancora oggi cercato, perché è capace di esprimere l’uguaglianza tra i vari popoli, contestando aspramente la visione esclusivamente positiva dell’Europa. Il profilo dell’Albania, certamente non è del tutto roseo, ma è ben più positivo dell’idea che uno straniero che non l’ha mai visitata, possa essersi fatto. Spesso sento dire che si ha paura di venire da noi, ma non è così. Dalle statistiche dell’Interpol, è emerso che il nostro Paese è uno degli ultimi nella classifica relativa alla piccola delinquenza e questo mi fa piacere. Mi deludono le voci che parlano di un territorio pericoloso: al limite lo è tanto quanto altri posti. Insomma, ho iniziato la stesura del libro partendo da un’emozione personale e poi mi sono allargato. Il volume è stato tradotto in varie lingue, in cinese, norvegese, arabo, francese e italiano.
Hai avuto conseguenze dopo la sua pubblicazione?
All’inizio ho rischiato. Diciamo che ho avuto più conseguenze a livello psicologico a causa delle forti pressioni: penso di aver subito un processo di tipo kafkiano. Addirittura, è arrivata una delegazione da Bruxelles per farmi una sorta di intervista sul libro e ho spiegato tutto come sto parlando ora e la loro relazione è stata molto positiva.
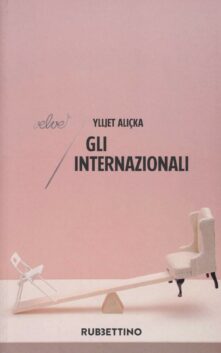
Parliamo di un altro tuo lavoro importante, Il sogno italiano (Rubbettino, 2016)
In un paese isolato per lungo tempo, l’immagine che ci si crea della dimensione estera è ben diversa dalla realtà. Nella testa degli albanesi si creavano immagini illusorie, paradisi stranieri e attraverso la storia della famiglia Popa, ho voluto toccare la disillussione della gente. Tanto del mio lavoro si è basato sullo studio di archivi e documenti.
I Popa non sono mai stati maltrattati in Italia; il problema si è creato a causa delle loro aspettative, in quanto erano convinti che sarebbero stati trattati come eroi. In realtà, gli italiani hanno fatto tanto in quel periodo per proteggere i diritti umani, anche a livello legislativo. Sono nati dibattiti all’epoca, per capire se fosse il caso di proteggere o meno la famiglia Popa e rompere o meno le relazioni con l’Albania. Quando sono arrivati in Italia, all’inizio sono stati accolti come eroi, però poi sono entrati nel processo normale di trattamento dei rifugiati, collocati in un campo per profughi e così è arrivata la delusione.
In seguito, hanno dato loro una casa popolare situata alla periferia di Roma e così sono rimasti ulteriormente isolati. È sorta l’incapacità di adeguarsi e di adattarsi, cosa che non è stata proprio colpa loro, ma del sistema, della storia d’Albania e poi di tutte le ondate di albanesi che arrivavano in Italia, che mi sembra siano stati ben accolti. Io non sono tra quelli che accusa il governo italiano, tutt’altro. Il problema nasceva dall’aspettativa, molto illusoria, non corrispondente alla realtà. La stessa cosa è accaduta per gli albanesi che sono arrivati in Francia, a Marsiglia che si aspettavano qualcosa di diverso. Questa forte differenza tra le aspettative/speranza e verità, mi ha molto colpito: il crollo del sogno e delle fantasie, che si creano proprio grazie all’isolamento totale dalla realtà.
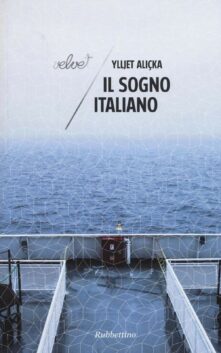
In Metamorfosi di una capitale, (Castelvecchi, 2021), il tuo ultimo libro pubblicato in Italia, tu sei molto diretto, non ti risparmi nel raccontare di una Tirana in continua evoluzione, che però resta sempre ferma. Giusto?
Non proprio. Vivendo a Tirana, ho seguito l’evoluzione politica nella mentalità della gente. Il pensiero, il motore che muove la convinzione delle persone è quello di lottare per il proliferare dell’economia, per il benessere e per il protagonismo. Una sorta di lotta tra il rapporto dominante e la sottomissione. Però, quando si giudica un sistema o un governo, nessuno racconta a se stesso di queste ragioni, (forse perché non si ha voglia di dirlo). Nessuno ammette io sto dalla parte di questo governo per me stesso, per la mia ricchezza personale. Ogni volta, questa necessità si maschera con il bene della società. In qualche modo si nasconde a se stessi la realtà dei fatti, manipolando e manipolandosi.
Rapportando questa mia convinzione all’ideologia di un popolo, posso affermare che i vincitori di ieri sono ancora gli stessi di oggi. La realtà, molto spesso, si copre con l’ideologia euro-socialista e questo lo fanno specialmente gli intellettuali, che sono quasi sempre di sinistra, perché fa moda. Anche in Paesi come l’Italia e la Francia si palesano come tali, ma è diversa quella italiana dalla sinistra ereditiera del totalitarismo. Non può, chi è figlio di questa ideologia essersi trasformato immediatamente in euro socialista, appropriandosi dei veri valori umani. Questa è l’automanipolazione che gli uomini hanno usato per poter trovare una propria tranquillità nella realtà post – dittatoriale.
Si tratta, per questo, di un libro ironico. Ho fatto sarcasmo su tutti gli alibi con cui gli ex criminali si sono arricchiti, nascondendosi sotto l’ombrello dei valori umani, oppure sotto un pragmatismo estremo.
I personaggi che animano il libro sono tutti ispirati alla realtà. Ho scritto questo romanzo, a cui tengo molto, per dare la mia opinione sulla manipolazione e sull’usurpazione del bene comune.
Per fortuna, in Francia sta andando molto meglio che in Italia. Sono stato invitato dal Parlamento francese. Questa cosa è molto importante; è la prima volta che i Parlamentari vogliono discutere sull’evoluzione della mentalità dal comunismo a oggi. Anche presso il Palazzo d’Europa si organizzerà a breve un dibattito con altri intellettuali su questo libro. Ho un’intervista con Le Monde e Le Figaro. Non è facile per uno straniero orientarsi nella lettura di questo volume, però i meccanismi di manipolazione, anche se esposti in forma ironica sono basati su storie vere che hanno coinvolto l’Albania. Metamorfosi di una capitale non ha avuto successo come Gli internazionali, ma è comunque apprezzato.
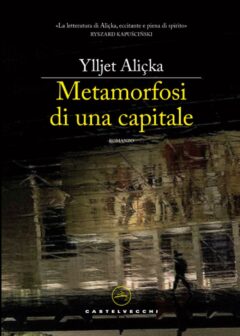
Ne I compagni di pietra, (Guaraldi, 2006), ho percepito una realtà albanese un po’ più spaccata, o sbaglio?
Ha deciso l’editore il titolo, perché quello originale era Gli slogan di pietra. Sono racconti naif della vita quotidiana, che permettono di conoscere meglio sia la realtà albanese durante il comunismo, che quella di oggi. Ci sono due modi per affrontare queste tematiche, o con delle storie forti, epiche, oppure attraverso la routine della quotidianità. Ho tentato di offrire piccoli racconti di vita collocati nelle varie epoche.
La maggior parte di questi racconti sono diventati film, sono novelle molto apprezzate all’estero, tanto da essere tradotte in tredici lingue. Vengono lette soprattutto in Polonia e nei Paesi dell’est; in Repubblica Ceca, hanno scritto svariati articoli a riguardo e mi hanno intervistato in tanti. Penso di essere molto più conosciuto in Polonia, che altrove. Forse tornerò a scrivere racconti, non mi sento di redigere un romanzo, al momento.
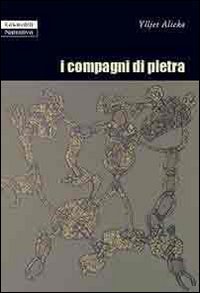
Cosa ne sarà dell’Albania?
Una domanda semplice! Naturalmente, sono ironico. Innanzitutto, dipenderà molto da quello che decideranno i politici. Vedo con amarezza che la maggior parte dei giovani sta tentando di lasciare l’Albania, che secondo me è un Paese dinamico, abitato da una popolazione con una capacità di orientamento molto forte. Io sono ottimista, credo nei valori degli albanesi, penso che sempre di più si alzerà l’attenzione verso l’Albania, grazie alle sue risorse intrinseche. Credo si possa trovare una strada che porti verso una vita con standard europei. Mi piace pensare all’Albania nell’Unione Europea. Purtroppo siamo poco conosciuti all’estero o si pensa sempre alla parte esotica della nostra nazione. Però c’è la routine della quotidianità, io in Albania mi trovo bene. Ho avuto l’occasione di lavorare e vivere in Francia, ma qui mi sento bene. Non vedo molta differenza tra i valori albanesi e altri. La vedo positiva.