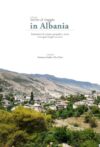Con questa citazione, stampata a piena pagina prima dell’Introduzione, Paolo Rago inizia il suo saggio:
«Un certo numero di scrittori ha voluto dimenticare che l’Albania è un paese balcanico e che i Balcani dovrebbero essere giudicati con i loro standard e non con quelli europei». (Constantine A. Chekrezi, Albania past and present, The MacMacmillan Company, New York 1919, p.192).
Nella collana di Studi politici e internazionali “InterPolis” è stato recentemente pubblicato il volume di Paolo Rago «Tradizione, nazionalismo e comunismo nell’Albania contemporanea».
La collana “InterPolis” – pubblicata dalla casa editrice “Nuova Cultura” sotto l’egida dell’Università “La Sapienza” di Roma – si propone di rendere disponibile a un vasto pubblico i lavori di studiosi e cultori di storia delle società moderne e contemporanee, analizzata nelle sue dinamiche intrinseche internazionali.
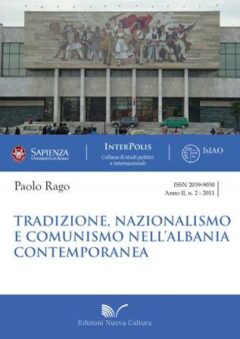
Paolo Rago
Paolo Rago – che vive ininterrottamente da circa venti anni in Albania – ha lavorato con la Direzione Generale della Cooperazione Italiana, l’UNICEF, la Banca Mondiale ed altre organizzazioni internazionali. Ha collaborato con l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana ed è stato capo-dipartimento della lingua italiana presso l’Università “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana. Inoltre ha curato la traduzione in lingua albanese di opere di saggisti italiani ed è autore di saggi e articoli sull’Albania. Nel passaporto rilasciatogli dalle autorità di Tirana risulta essere di cittadinanza albanese.
L’autore è appassionato della piccola Albania che ha conosciuto nel magico momento del passaggio incruento dalla dittatura alla libertà.
Per oltre due millenni regione di incontro e di scontro di varie civiltà, i Balcani hanno visto un fase storica del tutto diversa dalle precedenti a partire dal secolo XIX, quando il fiorire di movimenti politici legati alla dottrina romantica divenne il motore di radicali cambiamenti nei secolari equilibri dell’area.
L’affrancamento dalla dominazione ottomana e la realizzazione degli ideali nazionali determinarono nella coscienza dei popoli balcanici interpretazioni alimentate da miti e utopie.
Alla luce di quanto esposto, lo studio della storia e delle vicende del popolo albanese deve essere considerato alla stregua di un particolare tassello del più grande mosaico che rappresenta la penisola balcanica. Vittime forse più di altri di pregiudiziali categorie interpretative, gli albanesi sono stati immaginati e descritti generalmente con uno stile retorico di sapore fantastico-leggendario, di cui erano ricchi i resoconti di viaggiatori di inizio Ottocento.

Resta indubbio che gli albanesi sono portatori di alcune specificità, di cui la più evidente è forse la convivenza esistente tra diverse religioni presenti nel Paese, caratteristica che li distingue dai popoli confinanti tra i quali un’unica confessione è condivisa dall’intera nazione. La coabitazione religiosa e la sostanziale assenza di conflitti religiosi tra cattolici, ortodossi, musulmani e bektashi ha colpito l’immaginazione degli osservatori, concordi nel mettere in risalto l’importanza del legame etnico rispetto al fattore religioso.


Tutto ciò ha trovato una sua particolare definizione in un termine, coniato da Pashko Vasa negli ultimi decenni dell’Ottocento, di shqiptaria, forma sui generis di nazionalismo, connaturato con lo spirito del popolo albanese, per la sua storia chiuso ad influenze esterne, auto-referenziale e proiettato al suo interno. Fenomeno originale, prodotto di reazione ai rischi esterni – questi sì di più proprio carattere nazionalista – la sua comprensione permette di esaminare con maggiore profondità gli eventi salienti del percorso risorgimentale albanese di fine Ottocento, gli anni relativi alla monarchia di Re Zog ed il successivo regime comunista, inquadrandoli in un equilibrio stabile.
Per meglio spiegare questi passaggi storici è parso opportuno all’autore mettere in evidenza i principali elementi culturali ispiratori dell’azione dei patrioti risorgimentali, ponendoli in correlazione con il pensiero romantico-nazionale sviluppatosi in altri paesi della regione. Parimenti, l’analisi e l’interpretazione delle cause dell’ascesa al potere del Partito Comunista albanese e del suo capo, Enver Hoxha, ha messo in luce le strette relazioni con i contenuti e i valori più profondi espressi nei codici consuetudinari, il più importante dei quali è il Kanun di Lekë Dukagjin.
Legati l’uno all’altro da tanti fili comuni, tali differenti aspetti della storia nazionale albanese hanno prodotto la costruzione, edificata a più riprese, dei tanti miti per il rafforzamento della compattezza nazionale, i tentativi esperiti per modernizzare la nazione, l’apparente incoerenza presente nella conciliazione tra il comunismo ed il nazionalismo per mezzo della cultura tradizionale.
Il saggio di Paolo Rago di oltre 270 pagine è suddiviso in sette capitoli:
- La nascita del nazionalismo nei Balcani;
- Il risorgimento nazionale albanese;
- Gli albanesi tra verità e mito; La religione;
- Il secolo del nazionalismo;
- Tradizioni di clan e il diritto consuetudinario:
- il Kanun di Lek Dukagjin;
- Il comunismo di Enver Hoxha.
Una ampia bibliografia correda il libro e lo rende prezioso per gli studiosi e i lettori desiderosi di approfondire la conoscenza di questo così interessante paese.
Mi sembra importante infine riportare quanto scrive il professor Roberto Morozzo della Rocca, profondo conoscitore delle cose albanesi, nella prefazione al volume:
« Lo sforzo di erudizione e di interpretazione condotto da Rago non sarà dunque troppo razionalizzante né universalista nei metodi e nei risultati, ma appare comunque meritorio perché non elude alcuna questione cruciale dell’albanesità, ed anzi per ciascuna cerca soluzioni e definizioni nette. A volte troppo nette, ma questo fa parte dell’albanesità stessa, abbracciata da Rago nella metà schipetara del suo cuore.
Albanesità che è vissuto sanguigno, è forte sentire, è pensiero assertivo, e non è gusto del pensare in tensione, dell’antinomia, della contraddizione, del dubbio, come non è ricerca di concetti sofisticati, di colori sfumati, di nuance. Il lettore rispetterà questi giudizi risoluti dell’autore, sapendo che provengono da chi frequenta ciò di cui scrive, e se sono poco sfumati è perché eccedono in passione. In ogni caso, l’insolita albanesità di un italiano consente un accesso privilegiato, dall’interno, alla questione antica e nuova dell’Albania, della sua natura e dei suoi destini».

[È il museo più importante d’Albania. Contiene 3.600 reperti del patrimonio culturale albanese, che risalgono dal periodo del Paleolitico fino ai giorni nostri. I più interessanti sono i padiglioni della antichità, del medioevo e quello dell’indipendenza e formazione del stato albanese.]