Musine Kokalari – La mia vita universitaria. Memorie di una scrittrice albanese nella Roma fascista (1937-1941). A cura di Simonetta Ceglie e Mauro Geraci con un saggio di Visar Zhiti. Viella Editore, Roma, in corso di stampa (maggio 2016)
La mia vita universitaria è l’autobiografia giovanile di Musine Kokalari, oggi riconosciuta quale prima, grande scrittrice e poetessa albanese, scritta tra il 1937 e il 1941 durante gli anni di studio alla Sapienza.
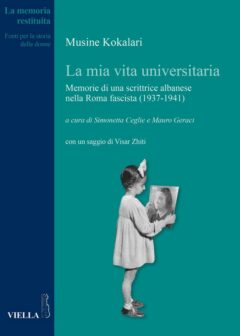
Si tratta della prima sua opera che, a settant’anni circa dalla stesura, oggi ha visto la luce in Italia, paese per il quale era stata pensata, e nella prestigiosa collana La memoria restituita dell’editore Viella, patrocinata dalla stessa Sapienza e dall’Archivio di Stato di Roma.
Frutto di un lungo lavoro di ricerca storica, archivistica e antropologica svolto tra Roma e Tirana da Simonetta Ceglie e Mauro Geraci, il volume contiene anche un corposo inserto di immagini e documenti in gran parte inediti e un originale saggio del poeta Visar Zhiti.
Composta a Roma durante il fascismo e direttamente in lingua italiana, La mia vita universitaria testimonia, intanto, l’entusiasmo di chi aveva visto negli studi universitari la «più grande e nuova aspirazione per una ragazza albanese»; l’impegnativa formazione di una coscienza critica e politica tuttavia spezzata alla radice dalla condanna, dai lunghissimi anni di reclusione e isolamento forzato che Musine Kokalari, rientrata in Albania nel ’42, dovette subire fino all’83, anno della sua morte, quale tenace organizzatrice di un articolato progetto di democrazia e libertà nazionale fortemente temuto e stroncato dall’incipiente regime comunista di Enver Hoxha.

Molteplici sono le ragioni che rendono preziosa dal punto di vista storico, letterario ed etico questa scrittura del sé che ci accompagna tra le dolcezze e le paure, le gioie e le tristezze, le amicizie e gli abbandoni, le ambizioni e gli smarrimenti sentimentali della studentessa che ama perdersi e ritrovarsi nella Capitale del Mondo. Pensate per essere libro, queste memorie rivelano la sensibilità umana, po-etica, antropologica per la quale la giovane Musine era già nota in Albania come giornalista e autrice di finissimi racconti ambientati nel mondo popolare albanese di cui aveva perfetta conoscenza, come il cimentarsi in una lingua e un Paese stranieri. Una lingua e una penisola, però, anche sue dal momento in cui, tra il 1939 e il 1942, l’Albania si trovava sotto l’occupazione dell’Italia fascista.
La mia vita universitaria è quindi risultato di due punti di vista dialettici, l’albanese e l’italiano; testimonianza d’antiche controversie che emergono attraverso i piccoli, grandi drammi vissuti dall’autrice giorno per giorno, negli anni che la videro frequentare la Sapienza, di cui descrive ambienti, relazioni, complicità studentesche, e far la spola tra Roma e Tirana. È un testo “adriatico”, differenziale, che coltiva il dolce, malinconico «sguardo da una certa distanza» di verghiana memoria. Interessantissimo per i continui scarti narrativi della ragazza albanese e musulmana che riesce a fronteggiare un mondo romano, maschile, fascista, cristiano vissuto con la curiosità osservativa e introspettiva dell’intellettuale.
Vi è infine la costante attenzione a una nascente “questione femminile”, per la quale Muza era stato lo pseudonimo con cui aveva già firmato inchieste davvero spavalde per una ragazza di quei tempi, che denunciavano i problemi sociali della donna nell’Albania anni Trenta. Per l’appassionata ricerca di una via democratica ostile a ogni dittatura, Musine, condannata a vita dalla morsa del comunismo albanese, resta una «ragazza uragano» che ancor oggi sa infondere alle future generazioni l’amore per la giustizia e la libertà.
Da La mia vita universitaria di Musine Kokalari:
«La mattina del 15 gennaio 1938, in casa mia tutti erano presto in piedi: stavo per partire per Roma. I preparativi rendevano commoventi gli ultimi istanti, come anche il vedere le valigie ordinate nell’ingresso, il sentire i passi lenti di mia madre e notare gli sguardi sorpresi dei bambini.
Tutti mi accompagnarono fino alla porta. I baci, gli abbracci dei miei famigliari, le lagrime di mia madre mi commossero; più ancora quando vidi la nipotina Carolina che mi si aggrappava al collo, e che non voleva lasciarmi partire e poi vedere le sue manine agitarsi piangendo mentre la macchina si allontanava.
Non descrivo il viaggio, perché fu per me più una sofferenza che altro. Seguii la strada Durazzo-Bari e dopo ventiquattro ore eccomi finalmente a Roma in compagnia di mio fratello.
Roma, il mio sogno! Quante cose avevo imparato intorno a questa città: essa fu fondata nel 753 A.C. da Romolo; sapevo delle prime case sparse sui pendii del colle Palatino; Roma capitale del mondo antico, capitale del mondo Cristiano, la città che per tanti secoli rimase senza rivale, patrona del mondo, la città eterna!
Il primo giorno del mio arrivo, era un giorno freddo e il cielo era coperto di nuvole. Sul primo momento sentii una sensazione nuova, angosciosa. L’idea dell’ignoto mi dava un senso di malinconia. Il rumore della grande città, le strade lunghe che a me sembravano tutte uguali, le case alte, ogni cosa in contrasto con tutto quello che si può vedere nel nostro paese, nella città di Tirana, mi confondevano. Pensai che sarebbe per me una cosa difficile orientarsi in quell’immensità e nei primi giorni in mezzo alla folla mi sembrava di essere troppo piccola e spersa.
Mi sistemai presso una famiglia del nuovo quartiere di Piazza Bologna e dopo la partenza di mio fratello mi sentii ancora più sola. Cominciò subito la noia. Uscivo di rado anche perché non ero pratica dei luoghi. Dalla mia camera vedevo attraverso i vetri cadere la pioggia e quando alzavo lo sguardo: grandi palazzi a destra, palazzi di fronte, palazzi a sinistra. Tutte case quadrate senza giardini, strade diritte senz’alberi, nessuna via tortuosa come quelle che piacciono tanto a me, nessuna casa antica che potesse attirare la mia attenzione. Qui la natura è chiusa fuori della nostra vita, e si vive in casa, dove si sentono camminare quelli di sopra, e quando camminiamo noi, disturbiamo sicuro quelli del piano di sotto.
Benché fosse allora l’inverno, non sentivo i tuoni, per via dei rumori della strada, né vedevo i fulmini che scoppiavano dietro le case alte, e invece di sentire un po’ di freddo, sentivo troppo caldo a causa del riscaldamento centrale moderno.
Tali furono le mie prime impressioni di una grande città.
Era la prima volta che non provavo le vere emozioni della stagione invernale. Ogni tanto uscivo a passeggio sotto la pioggia godendo dell’acqua che mi schizzava sul viso, e così mi sentivo felice. Nell’uomo civile moderno manca lo spirito della natura.
Dopo una decina di giorni dal mio arrivo mi recai per la prima volta all’Università, da sola. Ero titubante e mentre camminavo mi sembrava che la gente indovinasse che io non sapevo orientarmi».
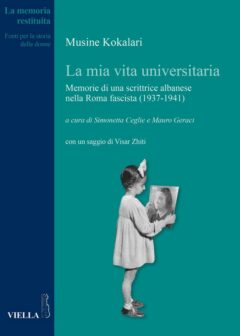
Vi invitiamo a leggere anche “Nel compleanno di Musine Kokolari un rimprovero alla memoria collettiva ” di Visar Zhiti





