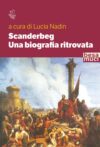Una bandiera che sventola su uno dei tre ovali del soffitto, in cui si rievocano le storie bibliche di Ester e di Mardocheo, presenta un’aquila nera su fondo rosso ed è stata letta fino ad oggi come bandiera asburgica, in rapporto alle vicende di cui sopra. In realtà la bandiera asburgica non ha mai avuto il fondo rosso, ma chiaro.
La bandiera albanese
È stato pubblicato nel numero CXCVIII, terza serie 10/II (2011) della prestigiosa rivista di scienze, lettere ed arti «Ateneo Veneto» un articolo di Lucia Nadin, di cui l’autrice aveva dato notizia a Tirana, nel novembre scorso, in occasione delle celebrazioni del Centenario dell’Indipendenza dell’Albania, dal titolo: Proposta di rilettura delle pitture di Paolo Veronese in San Sebastiano a Venezia: Scanderbeg, Miles Christi, e la Chiesa d’Albania.

L’articolo, precisa l’Autrice, è solo una anticipazione di studi che ha in corso e che intendono restituire all’Albania un luogo d’arte eccezionale a Venezia: la chiesa di San Sebastiano, ubicata nel sestiere di Dorsoduro, famosissima in quanto chiesa “d’autore”: essa infatti è un rarissimo esempio di chiesa in cui tutto l’apparato decorativo porta la firma di un unico artista: Paolo Caliari, il Veronese, uno dei massimi interpreti della pittura veneziana del ‘500.
Luogo simbolico, dunque, insigne monumento del Rinascimento, di fama internazionale, conosciuto come il “tempio” dell’artista che in esso volle anche essere sepolto. Purtroppo una serie di affreschi andò nel tempo distrutta.
Le pitture del Veronese, dal soffitto della Sacrestia, al soffitto della navata centrale, alle pareti, alla zona del barco, cioè del Coro pensile riservata ai frati dell’annesso convento, sino alle grandi teli del Presbiterio, furono eseguite in un arco di tempo compreso tra il 1555 e il 1565. In tutto il ciclo si celebra il trionfo della Fede/Chiesa/Vergine Maria attraverso il racconto esemplare di un suo martire: San Sebastiano.
La lettura prevalente da parte della critica d’arte ha collegato il ciclo ad intenti celebrativi in funzione antiprotestante, in rapporto agli eventi che videro nel primo Cinquecento l’esplosione della protesta luterana contro la chiesa cattolica e le relative guerre di religione.
Una bandiera che sventola su uno dei tre ovali del soffitto, in cui si rievocano le storie bibliche di Ester e di Mardocheo, presenta un’aquila nera su fondo rosso ed è stata letta fino ad oggi come bandiera asburgica, in rapporto alle vicende di cui sopra.
In realtà la bandiera asburgica non ha mai avuto il fondo rosso, ma chiaro.
La lettura proposta da Lucia Nadin è tutt’altra e si avvale anche dei suoi studi sull’emigrazione albanese in terra veneta nel secondo Quattrocento, conseguente ai grandi eventi che sconvolsero allora i Balcani, divenuta massiccia dopo la morte di Scanderbeg e dopo la pace con i Turchi nel 1479, a seguito dei due logoranti assedi di Scutari e Drivasto nel 1474 e nel 1478.
La studiosa, già Docente di Letteratura italiana nell’Università Statale di Tirana, parte dal dato della bandiera nel soffitto della chiesa, che richiama la bandiera di Scanderbeg e dunque dei Castriota, già descritta da Marino Barlezio e confermata come bandiera albanese da Konica nel 1908 e poi in occasione dell’indipendenza albanese nel 1912: aquila nera bicipite su fondo rosso.
La Nadin legge metaforicamente le vicende di Mardocheo, che lotta per il riscatto del suo popolo ebreo, vicende che si sovrappongono a quelle di Giorgio Castriota. Quindi analizza tutta la celebrazione di san Sebastiano che – in modo inedito per la tradizione veneziana – è presentato non come santo taumaturgo, ma come Miles Christi, che affronta Diocleziano, il grande persecutore dei cristiani, e va incontro quindi al sicuro martirio, per il trionfo della Fede.
A San Sebastiano, Miles Christi, si sovrappone metaforicamente anche in questo caso Giorgio Castriota Scanderbeg, ripetutamente appellato da vari papi il Miles Christi, difensore della cristianità occidentale.
La testa di capra
Corre lungo tutta la parete alta della navata della chiesa e nel barco il fregio di una testa di capra: rinvio all’acuta vista dell’animale nei Bestiari medioevali, simbolo addirittura della lungimiranza del Cristo.

Ma la testa di capra doveva anche ornare la corona di Scanderbeg, quando fosse divenuto re del suo popolo, a seguito della crociata voluta da papa Pio II e conclusasi tragicamente con la morte del papa stesso in Ancona.
Dunque un altro preciso simbolo castriota, “albanese”.
Nel martirio di san Sebastiano visualizzato nelle tele del presbiterio l’autrice legge il martirio di tutta la Chiesa di Albania; e in un personaggio specifico che porta una veste con aquila bicipite incoronata il rinvio alla famiglia Angeli, che vedeva riconosciuto dalla Curia Romana proprio agli inizi degli anni cinquanta l’Ordine cavalleresco di San Giorgio: una famiglia che era impegnata in una tenace opera di recupero di memoria storica dell’ Albania (per la quale opera si veda anche il recente lavoro della Nadin, in edizione bilingue: Albania ritrovata. Recuperi di presenze albanesi nella cultura e nell’arte del Cinquecento veneto, Tirana, Onufri, 2012).
Si attende dunque il resoconto completo degli studi dell’autrice sulla Chiesa di San Sebastiano; ma già da questo articolo che li anticipa, all’Albania viene restituita una importantissima e fondamentale pagina della sua storia e un suo luogo d’arte per eccellenza, tanto più carismatico perché legato all’opera di uno dei massimi pittori di tutti i tempi: Paolo Veronese.
Desideriamo ricordare, alla conclusione di questo articolo, l’importante scoperta di Lucia Nadin degli Statuti di Scutari, recuperati dalla studiosa dopo quasi sette secoli dalla originaria stesura nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia: Lucia Nadin ne dava notizia nel 1997 nella Conferenza Scientifica dell’Università Luigi Gurakuqi di Scutari.