Mira Meksi fa parte della rosa di scrittori e traduttori albanesi tra i più apprezzati del panorama letterario nazionale e internazionale. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio per la traduzione letteraria dal Ministero della Cultura, nel 2008 e il Premio Letterario Nazionale, nel 2020, per il romanzo Diktatori ne kryq, Il dittatore in croce, recentemente tradotto da Giovanna Nanci e pubblicato da A & B Editrice, 2023. Durante l’intervista, che Mira ci ha gentilmente concesso, si è parlato della sua figura di scrittrice e traduttrice, dei suoi libri tradotti in Italia e della visione della letteratura albanese. Buona lettura.
Partiamo dalla domanda cult: tu sei scrittrice e traduttrice. In quale delle due figure ti identifichi di più?
In verità, mi identifico nella figura della creatrice letteraria, sia in relazione alla letteratura e all’essere autrice, che come traduttrice dei libri di grandi scrittori. Ho iniziato come scrittrice, pubblicando i primi miei racconti all’età di 12 anni e la prima volta fu su riviste dedicate ai bambini. Traduco da quando frequentavo le Scuole Superiori; iniziai durante miei studi di Filologia Francese. Negli anni Novanta mi riconoscevo di più nel ruolo di traduttrice, mentre in questi ultimi trent’anni penso di essermi immedesimata nella simbiosi autrice-traduttrice. Restringendo il campo temporale e parlando degli ultimi periodi, posso affermare di sentirmi più scrittrice, anche se, ultimamente, ho tradotto, in albanese, i capolavori di Gabriel Garcia Márquez.
Mi piacerebbe dessi un tuo parere circa la letteratura albanese oggi e come, secondo te, viene percepita nel mondo.
Penso che la letteratura albanese, oggi, non abbia contorni chiari, che sia amorfa. È importante non dimenticare che, per molto tempo, è stata la letteratura di un Paese isolato, costretta a seguire i principi del realismo socialista. Dopo la caduta del regime, gli scrittori si sono ritrovati, improvvisamente, ad avere a che fare con una riacquistata libertà, a contatto con nuovi modelli letterari che prontamente furono imitati in maniera disordinata, senza considerare che essi avevano già fatto un percorso in Europa e oltre il continente.
È dagli inizi degli anni Novanta che la letteratura albanese si profila con un carattere non definito, in cui si scorgono ancora tracce del realismo socialista (esistono scrittori che continuano a scrivere secondo quei canoni), in cui si intravedono tendenze influenzate dal boom di quella latinoamericana o esperimenti letterari ormai superati nel resto del mondo, come l’esistenzialismo, l’assurdo, il nuovo romanzo postmodernista. Non mancano gli orientamenti verso il nuovo, che si scorgono nella letteratura europea e che tendono alla produzione dell’autofiction o all’apertura verso una prosa romanzesca, che si avvicina alla saggistica o alle scienze storiche e sociali. Penso che i volumi di maggiore successo, nel genere romanzato albanese, siano quelli della metanarrativa storiografica.
Gli scrittori albanesi si sforzano per farsi riconoscere in Europa e nel mondo, con scarsi risultati. Ritengo che lo Stato faccia molto poco per supportare la diffusione della letteratura albanese all’estero; non vi è alcun paragone con il grande aiuto dato dagli altri governi dei Paesi ex comunisti, per il riconoscimento della propria cultura fuori dai confini.
Un tempo la Francia era un valido centro di promozione della nostra letteratura, cosa che oggi sembra non essere più di alcun interesse. Ultimamente, pare che l’Italia sia più attenta nei confronti della produzione libraria albanese, grazie alle iniziative nate dal lavoro dei piccoli editori, tranne rare eccezioni. Ritengo che una cultura letteraria marginale come la nostra, rapportandosi con il polisistema intellettuale, secondo la teoria di Even-Zohar, non possa far altro che arricchirlo con elementi dinamici. Purtroppo, però, non credo che nel mondo si percepisca questo della letteratura proveniente dall’Albania.
Tu sei una scrittrice pluripremiata e molto apprezzata: cosa ne pensi dei Premi letterari?
Ho ricevuto diversi Premi nel periodo più alto della mia maturità letteraria. Il Premio Nazionale, il massimo riconoscimento riservato agli scrittori in Albania, mi è stato conferito solo nel 2020, con il romanzo, Il dittatore in croce. Per la prima volta a essere premiata era una donna, sfatando così il mito di una gratifica trasformata in qualcosa di prettamente maschilista. Personalmente non ho molta fiducia nei Premi letterari, che, tranne casi saltuari, sono basati sul nepotismo, sugli interessi politici o riservati ai clan. Invece di strutturare un sistema solido in questo senso, che possa contribuire a restituire valore alla letteratura, cosa per noi fortemente necessaria, gli albanesi lo stravolgono, oltre ogni logica. Anche il Premio letterario più prestigioso, il Nobel, viene da tempo assegnato sulla base di valori che nulla hanno a che fare con quelli letterari.
Il dittatore in croce è un libro significativo e molto forte, in cui demonizzi il regime e con la tua scrittura abbatti ogni forma di potere del dittatore e di tutti i tiranni. Perché decidi di scrivere questo testo e di conferirgli una caratteristica così universale?
Gestire la figura del dittatore Hoxha, durante la stesura del libro, ha costituito una grande sfida per me, in quanto la distanza temporale utile per guardare i fatti con un’ottica prettamente letteraria, non era stata raggiunta; erano passati appena trent’anni dalla sua distruzione, troppo pochi per avere una visione chiara delle cose.
Nessun altro scrittore albanese, fino a oggi, si è avvicinato, in tal modo, a questa figura. I regimi profilati come comunisti, che siamo abituati a collocare in “campo socialista”, hanno molte caratteristiche in comune, ma tutti i ricercatori e gli studiosi sono concordi nell’affermare che quello albanese sia stato il più selvaggio, il più denigrante, il più sanguinario e il più schiavizzante.
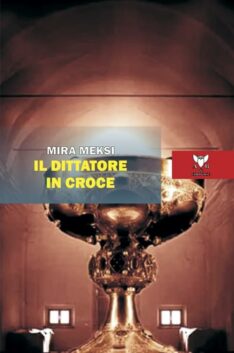
Ho voluto dare un’immagine universale sia del dittatore (partendo da Enver Hoxha), con tutto quello che ha rappresentato per la mia gente, che del suo ruolo e di quello del governo totalitario, da porre tra i più grandi mali della storia dei popoli, indipendentemente dal luogo e dal tempo.
Ho desiderato descrivere la miseria umana e il degrado di un uomo apparentemente potente, che non solo non si pente dei tanti delitti che gravano sulle sue spalle, ma li ritiene addirittura necessari. È la povertà d’animo di un personaggio del tutto privo di umanità, che non crede in nulla se non nel proprio potere, ma che in realtà è debole, abbandonato, terrorizzato a morte dalla vendetta di Dio, verso il quale nutre un senso di appartenenza, pur avendo massacrato i suoi figli sulla terra. Nella sua incoscienza, egli arde dal desiderio di resuscitare con l’aiuto del Figlio di Dio.
Penso ai principi che muovono le azioni del dittatore e il sistema totalitario e li considero universali. Il potere assoluto, di qualsiasi colore e tempo, crea una mancanza di comunicazione, produce isolamento, una gigantesca ipocrisia e una solitudine incommensurabile. La letteratura stessa è poliedrica e ti dà l’opportunità di universalizzare l’argomento che tratta, rendendolo più potente.
Oggi, in Albania, molti sostengono che il mancato processo al dittatore e a chi ha fatto parte del suo circondario, costituisca quel filo che lega il Paese indelebilmente al passato, perché nessuno ha pagato per quanto accaduto. Ti chiedo se uno dei significati che hai voluto attribuire alla Croce sia questo: il tentativo incessante da parte del passato di tornare in vita.
Sì, quello che dici è verissimo. Noi albanesi abbiamo ancora problemi irrisolti con il nostro passato e la colpa di questo è da attribuire alla politica. Non abbiamo ancora chiarito la nostra memoria storica di quel tempo, il che rende la connessione con il futuro molto fragile, soprattutto nella ripetizione degli errori. Non vi è alcun dubbio che esista la possibilità di “resurrezione” del male, finché persiste la Croce del passato che ancora portiamo sulle nostre spalle. Credo che questa sia una delle più significative metafore del romanzo.
L’altro tuo volume tradotto in italiano è La maledizione delle sacerdotesse d’Illiria, Besa Muci Editore, 2022, trasposizione di Valentina Notaro e Shpëtim Doda, in cui Teuta d’Illiria è la protagonista indiscussa del romanzo: è la regina guerriera, considerata l’antenata degli albanesi. Come tu stessa affermi, non esistono documenti inerenti la figura di questa donna. Ti chiedo quale percorso informativo hai dovuto seguire per scrivere questo libro e quanto impegno e tempo ha richiesto il lavoro svolto.
Il romanzo sull’Illiria e la regina Teuta è la mia grande impresa letteraria più recente. La ricerca e la stesura del libro hanno richiesto una lunga gestazione, che si è trasformata in otto anni di lavoro. Ho letto migliaia di pagine di autori antichi e moderni che hanno scritto sull’Illiria e i suoi re, in particolare l’opera del famoso artista illirico Aleksandër Stipčević.
È vero che la documentazione storica relativa alla regina Teuta non esiste. Polibio è l’unico storico antico che ha scritto su di lei, non fornendo fatti storici oggettivi, bensì esprimendo il suo evidente disprezzo per la regina dei pirati. Nel tempo, ho raccolto moltissimi documenti relativi al folklore, ai miti, alle leggende, ai racconti, pilastro della memoria viva dei Balcani. Sono riuscita a distinguere i fatti storici dalle leggende e dai miti, stabilendo il giusto rapporto tra la storia e la narrativa o fantasia, riuscendo a stilare un romanzo a sfondo storico o per meglio dire, una metanarrativa storiografica.
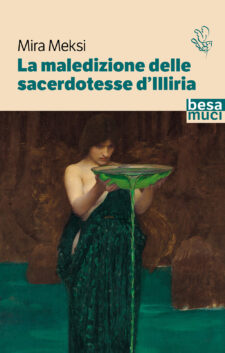
Quello che però non emerge nella versione in italiano del romanzo, è uno dei suoi elementi chiave, cioè la lingua utilizzata. Molti filologi stranieri e nazionali sono giunti alla conclusione che l’albanese sia l’unica lingua attiva derivante da un ramo di Illirico, di cui non abbiamo ancora testimonianze scritte.
Questi elementi e la similitudine di linguaggio, non solo mi hanno dato l’opportunità di fare un salto temporale di 2200 anni indietro e di stabilire una sorta di comunicazione con la regina Teuta, che però era una donna, come me, ma mi hanno aiutata anche a donare “il colore” più appropriato al linguaggio.
Ho, pertanto, liberato il lessico dall’influenza linguistica ottomana, appartenente a un’altra epoca, e dai modernismi, ma sono riuscita, anche, ad arrivare agli etimi della lingua albanese e del greco antico, mescolato con le radici dell’albanese, per costruire l’idioma del romanzo nella misura giusta per il lettore moderno, con lo scopo di semplificare la lettura. Dico sempre che in questo mi hanno aiutata due opere del noto Vladimir Orel: Ricostruzione del protoalbanese e Dizionario etimologico della lingua albanese.
Stai scrivendo un nuovo libro?
Il mio nuovo romanzo, Parisi Vret (Parigi uccide), è appena stato pubblicato, in Albania, dalla casa editrice Onufri. Il racconto è ambientato negli anni Novanta e si snoda intorno alla storia di uno scrittore albanese di fama internazionale. Siamo nel periodo successivo alla caduta del muro di Berlino, in cui al regime è stato inferto un duro colpo, ma nonostante questo, tenta, a tutti i costi, di tenere in mano le redini del potere. Gli intellettuali che non si trasformano nella sua scialuppa di salvataggio, che mettono in pericolo i suoi principi, vengono eliminati.
Da poco ho iniziato la traduzione del romanzo inedito di Gabriel Garcia Marques En verano nos vemos, che sarà pubblicato in originale e simultaneamente in tante lingue del mondo (anche in albanese) a marzo del 2024, nel decimo anniversario della morte del grande scrittore.




