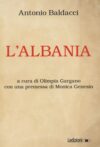Monica Genesin è professoressa associata di Lingua e cultura albanese presso l’Università del Salento. Il suo percorso di studi ha conosciuto diversi atenei, come quello di Padova, di Monaco di Baviera e l’Università della Calabria. Fa parte dell’Associazione di studi del sud-est europeo e della Balkanologenverband (Università di Jena) e del Comitato di redazione della rivista Palaver dell’Unisalento. È stata vicedirettore del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università del Salento. In questa intervista, che ci ha gentilmente concesso, racconta della sua passione che ha trasformato in un interessante percorso professionale.
Intervista a Monica Genesin
Come nasce il suo interesse verso gli albanesi e la loro lingua?
Per chi non è vicino alle questioni albanesi, suonerà strano quanto affermo: la mia area di provenienza, il Veneto, esattamente come la Puglia e il Salento in particolare, è stata sempre fortemente legata alla storia dei Balcani e dell’Albania. Mi rifaccio, in particolare, al ruolo importante che Venezia ha avuto nel tempo, principalmente nell’area adriatica (è ormai nota la presenza veneziana sulle coste dell’Albania). In virtù di questo, nelle nostre biblioteche, hanno sempre campeggiato libri che narrano dell’Albania e non è detto che nelle nostre vene non scorra sangue albanese. Non dico che questo sia il mio caso, però, non dimentichiamo che dopo la conquista ottomana, è nata una diaspora che ha interessato tutta l’Italia e non solo quella meridionale, con la formazione di varie comunità. Infatti, studi molto recenti testimoniano di come essa abbia attraversato l’Italia centrale e anche il mio Veneto, proprio come il Friuli.
Purtroppo, però, questi passaggi sono stati solo temporanei e non hanno mai dato vita a collettività dedite alla conservazione della lingua e della cultura albanese. Lucia Nadin, la nota studiosa che conosciamo tutti molto bene, in diverse pubblicazioni, oltre che nell’opera di recente pubblicazione Scanderbeg una biografia ritrovata (Besa Muci, 2021), ha sottolineato la presenza di una comunità socialmente molto stratificata, la cui sede era rappresentata dalla “Scuola di Santa Maria e San Gallo degli Albanesi” sita nel sestiere di San Marco, un edificio che raccoglieva tra i suoi confratelli esclusivamente gli albanesi residenti o di passaggio a Venezia. L’edificio è ancora esistente con la sua bella facciata caratterizzata da un fregio, che racconta l’assedio di Scutari. Inoltre, tanti sacerdoti sono passati in Veneto, fermandosi sulle nostre montagne, nel bellunese, per esempio, e in tutta l’area friulana.
Nella città di Padova ho avuto il mio primo incontro con la lingua e cultura albanese, in questa città dove è stato stampato uno dei più antichi testi albanesi, il Cuneus Prophetarum di Pjetër Bogdani (1685). All’Università di Padova, che è stata, in passato, frequentata da studiosi albanesi, all’epoca dei miei studi, mi sono imbattuta nel professor Giambattista Pellegrini, un grandissimo romanista, studioso della socio-linguistica e della linguistica romanza, con un’ampia vastità di interessi, tra cui la lingua albanese. È stato proprio grazie alla conoscenza del professore, che mi si è aperto un mondo: ho iniziato, così, a studiare l’albanese, in un momento storico in cui c’era molta curiosità nei confronti di un Paese fondamentalmente chiuso, di cui non si sapeva quasi nulla.
Ho avuto anche la fortuna di conoscere il professor Francesco Altimari, che mi ha assistito nel percorso successivo, fatto con il dottorato in albanologia. Con me, c’erano altri due colleghi e a questo proposito vorrei ricordare Gianni Belluscio che è venuto recentemente a mancare. Noi siamo stati i primi ad aver conseguito il dottorato in materia.
Io ho avuto la possibilità di approfondire i miei studi anche a Monaco di Baviera, grazie ad alcune borse di studio e al sostegno della fondazione Alexander von Humboldt. A Monaco, ho trovato un ambiente molto favorevole e qui, ho potuto usufruire di un’ottima biblioteca nata grazie all’impegno del professor Martin Camaj, un linguista e scrittore albanese, un esule della diaspora politica. Egli, dopo varie vicissitudini, si è, appunto, rifugiato a Monaco, dove ha avviato gli studi di albanologia.
Un’altra figura importante è stata quella del professor Wilfried Fiedler, proveniente dalla DDR, l’ex Germania dell’Est, che, ai tempi del muro, era uno dei pochi paesi in Europa ad avere rapporti con l’Albania, forse, grazie alla sua posizione. Anche nell’ex Germania dell’est, si è creato un centro di studi albanologici molto attivo, che ha regalato grandi studiosi, tra cui il professor Fiedler, purtroppo venuto a mancare, anche lui, recentemente.
Ho continuato, così, i miei studi e mi sento di dire grazie alle tante persone che hanno creduto in me, specialmente ai bravi colleghi, come il professor Altimari che ho menzionato sopra e il professor Matteo Mandalà, che ha offerto, recentemente, un interessante contributo sulla storia della diaspora in Istria, intitolato L’immigrazione albanese in Istria, (Besa, 2021).
Un’altra figura di rilevante importanza nel mio percorso, è stata quella del professor Antonino Guzzetta, arbëresh di Piana degli Albanesi, uno studioso di grande umanità e di fondamentale importanza presso l’Università di Palermo: anche lui, purtroppo, ci ha lasciato.
Il mio percorso di studi è partito dalla linguistica storica albanese, sino a toccare svariati filoni. I miei interessi non sono rivolti verso la letteratura in senso stretto, ma verso le conoscenze di carattere etno-linguistico, antropologico e storico. Attualmente, sto leggendo con grande interesse, le relazioni che sono state stilate da alcuni vescovi in visita nei territori albanesi, che il professor Peter Bartl ha raccolto nella pubblicazione Albania Sacra, (Otto Harrassowitz, 2014 e oltre). Un’opera costituita da una miniera enorme di informazioni relative alla realtà albanese, a partire dalla fine del ‘500, fino all’800 e i primi del ‘900, attinte dai resoconti che i sacerdoti e i vescovi hanno scritto visitando il Paese, poco conosciuto e molto fuori mano. Potrebbe sembrare una cosa monotona, ma l’opera contiene incredibili pezzi di vita vissuta. Spesso, sono spaccati di esistenze anche curiosi e divertenti. Uno degli argomenti meglio affrontati, sono le lamentele dei prelati, per problematiche nate dalla mancanza di comprensione della realtà albanese, arrivando loro da situazioni strutturate diversamente e trovandosi ad affrontare un contesto sociale, politico, etnografico e antropologico totalmente differente. Quindi, in un territorio sotto la dominazione ottomana, hanno dovuto cercare un proprio equilibrio e un proprio modus vivendi.
Le lettere si riferiscono, per esempio, alle popolazioni cattoliche del nord, dove alcuni padri davano in moglie la propria figlia a persone di origine musulmana, cosa mal tollerata dai preti, che mettevano tutto per iscritto, minacciando la scomunica. Si leggono notizie di altri matrimoni celebrati non secondo le regole della Chiesa cattolica, come il matrimonio in prova, che prevedeva una convivenza precedente all’unione, affinché la donna potesse dare la garanzia di essere in grado di avere figli. Parliamo di società gestite da regole ben precise e spesso tali aspetti non erano ben compresi dai preti in visita, tranne che in casi specifici.
Posso menzionare lo studioso e sacerdote Don Ernesto Cozzi, un personaggio poco noto, ma che è stato rivalutato per le sue osservazioni molto acute di carattere etnografico e antropologico sugli abitanti delle montagne albanesi. Don Ernesto cercava infatti di capire la loro mentalità dall’interno.
La sua attenzione è rivolta alla linguistica albanese diacronica e sincronica. Cosa vuol dire?
Io sono partita, come dicevo, dallo studio della lingua dal punto di vista storico. Perché l’albanese è una lingua interessante? Fa parte delle lingue indoeuropee, di quella famiglia che comprende buona parte delle lingue parlate in Europa, quindi il gruppo delle lingue romanze che derivano dal latino, quello delle lingue germaniche, delle slave e ancora il gruppo delle lingue baltiche e quello delle celtiche, il greco, l’armeno.
Spostandoci, quindi, in un immaginario mappamondo, andando verso est, ci sono altre lingue facenti parte della famiglia indoeuropea, come, per esempio gruppi linguistici lontani dell’Asia, come le lingue indoiraniche parlate nell’odierno Iran, in Afghanistan e nel subcontinente indiano.
L’albanese è l’unica superstite di un gruppo di lingue antiche parlate nei Balcani, come del resto, il greco o l’armeno. È uno dei rametti isolati di una grande famiglia e presenta elementi di innovazione, ma anche di conservazione. Per questi motivi, è una lingua che suscita molto interesse in chi si occupa di linguistica storica indoeuropea, perché offre molte opportunità di confronto, di studio e poi, perché, è una specie di cartina di tornasole. Tutti i contatti che il popolo albanese ha avuto nel corso della sua storia, si riflettono a livello linguistico, per cui abbiamo prestiti dal mondo greco e qualcuno dal greco antico, dal greco bizantino e da quello più moderno. Questo, soprattutto, nel Sud dell’Albania, che anche grazie alla posizione geografica, ha avuto contatti molto stretti con i greci, attraverso la religione ortodossa.
Altra fase importante, è il contatto con il mondo latino-romanzo e qui l’albanese ha preso tanto dal punto di vista culturale e dal punto di vista linguistico. I riferimenti al latino sono tanti e nel corso del tempo si sono adattati. Faccio un esempio, riferendomi al termine casa – shtëpi che deriva dalla parola latina hospitium, che in italiano si trasforma in ospizio, mentre in albanese conserva il termine di rifugio, di luogo dove vive la famiglia. Sono tanti i settori riguardanti la vita quotidiana caratterizzati da parole di origini latine. Naturalmente, mi riferisco ai termini base.
Altrettanto, si può dire di espressioni linguistiche che risentono dell’influenza romanza, compresa quella veneziana: per esempio, pirun – forchetta, mentre noi diciamo piron. Attraverso la stratificazione cronologica della lingua, si può seguire, in qualche modo, l’evoluzione dei rapporti tra gli albanesi e i diversi popoli che hanno influenzato la storia dell’Albania.
Non mancano i prestiti presi dalle comunità slave, visto che il Paese ospita minoranze macedoni e montenegrine. Chiaramente, la dominazione ottomana, con i suoi cinquecento anni l’ha fatta da padrone, regalando molti turchismi. La lingua ha, poi, subito un processo di ripulitura, dopo l’indipendenza del 1912, quindi, molte di queste espressioni sono state sostituite da termini albanesi, grazie all’opera di diversi studiosi. Tutto questo è in riferimento allo sviluppo diacronico, quindi alla lingua nel suo divenire storico, mentre con sincronico ci si riferisce allo studio della lingua nel suo uso corrente.
Qualche giorno fa, durante una breve chiacchierata, ha accennato a informazioni non veritiere, circa le argomentazioni linguistiche. Mi fa qualche esempio?
Tutti sappiamo che da quando esistono i social, in tanti esprimono pareri su conoscenze che fondamentalmente non hanno. Chiaramente, non è un fenomeno riguardante solo il nostro settore. Mi è capitato di leggere teorie fantasiose, tipo che l’albanese deriva dall’etrusco e cose similari che non hanno alcun senso. Io consiglio, vivamente, di informarsi prima di esprimere pareri. Ci sono case editrici come Besa o Argo che pubblicano tanti volumi informativi a riguardo, per cui possibilità di saperne di più, ne abbiamo. Consiglio anche un sito, serio e ben fatto, di uno studioso Robert Elsie www.elsie.de, dove si trova tantissimo materiale sui dialetti, la lingua, la storia e la cultura albanese, creato da un intellettuale che tanto si è impegnato nella divulgazione delle sue conoscenze. Sono molto dispiaciuta per le informazioni errate che vengono diffuse, anche se, ormai, non intervengo più, perché vedo che è tempo perso. Apprezzo, però, l’opportunità che Albania News mi sta offrendo e invito a una seria riflessione prima di scrivere certe cose.
Diamo qualche consiglio sui libri da scegliere a chi si avvicina per la prima volta all’argomento?
Innanzitutto, consiglio Tra gli albanesi d’Italia, (Besa Muci 2021) di Eqrem Çabej e Gli albanesi tra Occidente e Oriente, (Besa Muci, 2020) e poi il sito sopra citato, che è in inglese, ma ormai è una lingua che mastichiamo tutti.
Per concludere, chi ricordiamo ancora?
Vorrei ricordare un’altra figura importante, che è quella di Olimpia Gargano, che ha fatto tanto, anche se non è un’albanologa in senso stretto, però si è impegnata molto nella divulgazione della letteratura di viaggio, in riferimento a chi ha visitato l’Albania e i Balcani e ha tradotto il bellissimo libro di Mary Edith Durham, La scoperta dell’Albania nell’Europa del primo Novecento, (Besa, 2016), un’opera fondamentale di una scrittrice che ha fatto molto per promuovere la causa albanese nei primi del ‘900. Quello che è più interessante, è il modo con cui l’autrice descrive i popoli delle montagne e la modalità con cui i viaggiatori occidentali si approcciavano a questa realtà, qualche volta con un senso di superiorità, anche, perché non venivano comprese.
Consiglierei, in questo caso, un sito, fatto abbastanza bene, Viaggioadriatico, www.viaggioadriatico.it, curato sia dall’Università del Salento che da quella di Bari, quindi da studiosi di entrambe le istituzioni, anche se è l’espressione di un gruppo di esperti più ampio, provenienti da Università dell’area adriatica, quindi, dal Montenegro, dalla Serbia, dalla Bosnia, dall’Albania, ecc. Una sorta di contenitore, che raccoglie testi per lo più risalenti all’800 e al ‘900 di viaggiatori e appunto di letteratura di viaggio.
Due parole sulle comunità arbëreshe
Per quanto riguarda il Salento, si parlava di Albania Salentina, proprio per indicare una comunità arrivata dall’Albania, a partire dalla seconda metà del ‘400. È rimasta traccia della presenza arbëreshe, nella comunità di San Marzano, in provincia di Taranto. Dopo un periodo di trascuratezza, (negli anni ’60 e ’70, c’era ancora poco interesse per queste realtà), la comunità si è arricchita di persone molto interessate, che portano avanti la promozione dell’identità culturale e linguistica. Noi stiamo cercando di fare il nostro e abbiamo in corso un progetto curato dalla collega Flora Koleci, finanziato da fondi europei, per il tramite della Regione Puglia, con l’obiettivo di creare un atlante linguistico ed etnografico degli arbëreshë della Puglia, dove, oltre quella di San Marzano, abbiamo comunità molto attive, come, appunto, Chieuti e Casalvecchio, in provincia di Foggia. E poi, vorrei ricordare che a Lecce c’è anche una chiesa di rito greco, chiamata la Chiesa degli albanesi, collocata accanto al Vico degli albanesi, a testimonianza della presenza antica della comunità nel Salento.
La prossima chiacchierata con la prof.ssa Genesin, sarà incentrata unicamente sulle comunità arbëreshe. A presto!